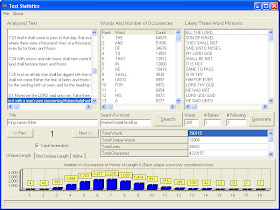Il De dimensione terrae di Caspar Peucer (1525-1602) è un piccolo trattato di geografia matematica destinato all’insegnamento all’interno delle facoltà di filosofia: non fa parte certamente delle opere fondamentali della storia della scienza, ma, se ci si interessa delle pratiche scientifiche e pedagogiche, l’opera testimonia l’alto livello raggiunto nel campo della matematica dalle università protestanti del Sacro Impero nel XVI secolo.
Il suo autore, allievo e genero del riformatore
Filippo Melantone (ne aveva sposato la figlia Magdalena nel 1550), fu professore di matematica, d’astronomia e medicina all’Università di Wittenberg, poi medico personale del principe elettore Augusto di Sassonia. Tra il 1574 e il 1586 Peucer avrebbe subito una lunga detenzione, legata alle lotte interne al luteranesimo tedesco a causa delle sue posizioni considerate cripto-calviniste.
Il De dimensione terrae, pubblicato a Wittenberg nel 1550, fu in seguito rieditato altre tre volte fino al 1587. L’insieme di queste edizioni s’inscrive nel movimento di grande attività scientifica che conobbero le università luterane tedesche in seguito alla riforma intrapresa da Melantone. Si tratta di un piccolo volume che uno studente poteva acquistare senza spesa eccessiva e che si aggiunge al cospicuo numero di trattati ideati da Melantone stesso o da altri professori di Wittenberg per i corsi propedeutici dei primi anni e riguardanti la fisica, l’astronomia, l’astrologia o la storia. Peucer fu associato assai giovane alla composizione di alcune di queste opere. Il De dimensione terrae è il primo manuale che uscì con il suo nome. Nel 1550 aveva 25 anni e non si era ancora fatto conoscere in campo astronomico e astrologico. Quattro anni dopo, quando apparve una versione riveduta dell’opera, lo statuto del suo autore si era modificato: Peucer aveva pubblicato nel frattempo altri testi ed era appena stato nominato alla cattedra di alta matematica (astronomia) della facoltà di filosofia, carica che mantenne fino al 1560.
La prima edizione del
De dimensione terrae era una breve sintesi dei trattati antichi consacrati alla misura della sfera e alla questione della determinazione delle coordinate geografiche, alla quale si aggiungeva uno sviluppo sui metodi per calcolare la distanza tra due località date. La seconda versione torna con maggior dettaglio su questo punto, consacrando diversi capitoli alla conversione delle coordinate geografiche in distanze, con un grado di difficoltà supplementare introdotto nelle dimostrazioni geometriche. Per l’autore è l’occasione per mettere in opera il sapere più recente sulla trigonometria sferica e di citare i nomi di
Regiomontanus, Nicolò Copernico e
Georg Joachim Rheticus.
Quest’ultimo nome riveste un’importanza particolare. Rheticus, famoso per essere stato il primo discepolo di Copernico e l’editore delle sue opere, aveva dedicato una grande parte del suo lavoro scientifico alla trigonometria piana e sferica. I suoi lavori furono pubblicati solo molto tempo dopo la sua morte, ma è tuttavia assai probabile che egli abbia iniziato qualche collega a questi argomenti durante i suoi soggiorni a Wittenberg. La seconda novità del 1554 è l’aggiunta al testo scientifico di due brevi opere di natura del tutto differente: una descrizione della Terra Santa del XIII secolo di Burchard di Mont-Sion (morto dopo il 1285) e una piccola descrizione dei toponimi biblici, redatta da Melantone. Questa curiosa associazione è stata mantenuta nelle edizioni successive.
Il
De dimensione terrae si distingue dalla maggior parte delle opere di cosmografia della sua epoca in quanto produce uno sforzo costante per delimitare e restringere il suo oggetto di studio. Durante il Rinascimento il sapere geografico non costituisce una disciplina chiaramente definita: la descrizione della Terra, secondo la tradizione alla quale appartiene, utilizza metodi diversi. Essa può essere aggiunta a una descrizione generale del cosmo, all’interno della quale la Terra costituisce un oggetto celeste tra tanti, come nel
De Spharea Liber di Giovanni di Sacrobosco (ca. 1195-1256), trattato medievale assai di frequente utilizzato nelle università europee del Rinascimento, oppure nella
Geografia di Tolomeo (II sec. e.v.), riscoperta in Italia all’inizio del XV secolo e largamente diffusa dalla stampa, che aggiunge alla descrizione di meridiani, paralleli ed equatore l’esposizione di numerose tecniche di proiezione cartografica sconosciute nel Medio Evo. I manuali cosmografici più popolari nel XVI secolo associano questi due aspetti e si basano largamente sul testo di Tolomeo. L’approccio matematico può essere integrato anche da una descrizione testuale di contenuto storico o etnografico, nella tradizione della
Geografia di Strabone (I sec. a.e.v.). Questi diversi approcci al sapere geografico, che si combinano più che escludersi a vicenda, hanno in comune la caratteristica di descrivere e non misurare il globo terrestre: si tratta di inventariare e collocare ciò che si trova sulla sua superficie. Nel XVI secolo le tecniche relative alla misura della Terra cominciano appena ad interessare i matematici, con strumenti teorici che rimangono assai rudimentali.
Peucer definisce chiaramente il suo oggetto proponendosi di calcolare le distanze terrestri tra punti conosciuti. L’originalità del De dimensione terrae è così duplice: richiede un sapere attivo nel dominio della matematica e intende applicare questo sapere alla scala del globo. L’opera s’inquadra esattamente in ciò che a partire dal secolo successivo sarà l’oggetto della geodesia: stabilire una rete di punti di riferimento sparsi le cui posizioni sul globo siano conosciute con precisione, sulla quale basare i lavori di misurazione e topografia.
Come la maggior parte dei trattati destinati all’insegnamento a Wittenberg, il
De dimensione terrae è fornito di un importante apparato retorico di legittimazione del sapere e delle tecniche utilizzate, sulla scorta degli insegnamenti di Melantone, la cui attività di diffusione del sapere matematico ha una triplice giustificazione. La matematica ha innanzi tutto un’utilità pratica, che la rende indispensabile nella vita quotidiana, come ad esempio nel viaggio, la navigazione, il commercio o la guerra. Essa mette inoltre in opera un modo di ragionamento strettamente logico che costituisce il livello superiore, e auspicabile, del metodo filosofico: la matematica e la geometria costituiscono per lo spirito un allenamento al ragionamento logico e più in generale alla filosofia, che è considerata non come un accumulo di dottrine o di opinioni, ma come un insieme di risultati acquisiti per prova e ragionamento. Infine, la matematica traduce con fedeltà la regolarità dei movimenti celesti, ricordando così che questi fenomeni naturali, che non possono essere dovuti al caso, rivelano un’intenzione divina.
Intesa come Provvidenza, l’azione divina nel mondo si traduce nel mantenimento d’un ordine naturale costante, ma anche per la capacità concessa all’uomo di conoscere quest’ordine. Apprendere e comprendere la matematica riveste una funzione devozionale e meditativa, che Peucer sottolinea con forza: si tratta di ammirare la saggezza divina, di nutrire rispetto nei confronti di Dio. L’incitamento a praticare la matematica in onore di Dio non è pura forma. Esso accompagna la costruzione di un sistema d’insegnamento e di una comprensione del mondo tipicamente luterani.
Matematico, l’oggetto del De dimensione terrae lo è effettivamente, perché Peucer intende insegnare i metodi antichi e moderni di misurare la Terra. In questa prospettiva, il trattato appartiene esplicitamente alla disciplina geografica, nella definizione che allora più spesso vi veniva data nell’università sassone, per la quale la geografia è una descrizione puramente matematica del globo terrestre. Essa dipende in questo senso dal sapere astronomico, che le fornisce l’essenziale dei suoi strumenti concettuali : meridiani, paralleli, equatore sono cerchi immaginari concepiti dall’astronomia greca antica come percezione geometrica e semplificata dei fenomeni celesti, proiettati sulla superficie terrestre. Questa descrizione matematica deve concretizzarsi nella costruzione di carte geografiche. Nella sua definizione melantoniana e nel modo in cui è insegnata a Wittenberg, la geografia non comprende la descrizione testuale, di natura storica o etnografica.
Questo trattato puramente matematico presenta tuttavia la particolarità di giustificare il suo oggetto anche per il suo ruolo riguardo al sapere storico. Le carte devono illustrare la conoscenza del passato: «In realtà, la lettura della storia non dà alcun piacere, non tocca lo spirito, se manca l’osservazione dei luoghi». Secondo Peucer, la geografia deve illuminare la storia, renderla presente, conferirle una forza persuasiva. Questo legame tra conoscenza storica e cartografia può così chiarire l’associazione a un’opera matematica di testi che riguardano la topografia e la toponomastica della Terra Santa: il racconto del pellegrinaggio e il breve trattato sui nomi biblici di Melantone devono ricordare allo studente che la prima cartografia lo si sollecita ad esercitarsi è quella del teatro della sacra scrittura, la prima testimonianza della rivelazione divina al mondo.
Il
De dimensione terrae non si attarda sulle questioni di fisica: la classica questione della costituzione fisica della Terra, composta da due sfere inserite l’una nell’altra, terrestre e acquatica, è affrontata in modo rapido solamente perché consente di definire la forma d’insieme della Terra, risultato preliminare indispensabile agli sviluppi geometrici che costituiscono l’essenziale del trattato. Il Rinascimento, seguendo su questo punto gli Antichi, considerava la Terra come una sfera perfetta: è solo a partire dal XVII secolo che i lavori di geodesia si sono preoccupati di definire la forma reale del globo terrestre.
Peucer, all’inizio della seconda parte del trattato, dà la definizione della longitudine e della latitudine. Questa definizione sottintende la semplice comprensione, dal punto di vista geometrico, di ciò che rappresentano le linee immaginarie che sonno i paralleli e i meridiani. Essa consente agli studenti di localizzare su un modello della sfera terrestre, mappamondo o globo, dei punti dei quali sono loro fornite le coordinate. Questo sapere fondamentale, che proviene dalla Geografia di Tolomeo, è una semplice guida per la lettura e la comprensione delle informazioni geografiche.
Ma Peucer vuole condurre i suoi studenti più lontano. È in questa prospettiva che sottolinea che il suo trattato non ha lo scopo di riprendere e spiegare le tecniche di proiezione cartografica trasmesse da Tolomeo. Non si tratta di contestare l’utilità delle carte, la cui elaborazione rimane una meta essenziale del sapere geografico, ma di sviluppare, a monte di ciò, la capacità degli studenti di calcolare da soli certi dati che permetteranno loro di disegnare queste carte. Il proposito di Peucer non è precisamente la descrizione né la localizzazione degli oggetti terrestri, ma la misura delle distanze, stabilite e verificate sistematicamente con il calcolo, tra due punti dati.
La prima parte del trattato di Peucer è dedicata alla ripetizione degli antichi fondamenti della geodesia: il calcolo della circonferenza, del diametro, della superficie e del volume del globo terrestre. Essa permette di ricordare agli apprendisti geografi i nomi di alcuni grandi matematici greci dell’Antichità e di sviluppare con precisione il dettaglio dei calcoli intrapresi. Così egli ricorda il metodo di Eratostene per il calcolo della circonferenza terrestre.
La materia originale dell’opera è concentrata nella seconda parte, nella quale l’autore affronta la questione delle coordinate geografiche, designate con i termini di latitudo e longitudo, di cui dà prima la definizione antica e poi quella moderna. Infatti, nella definizione antica, desunta da Tolomeo, questi termini non designavano soltanto la posizione dei luoghi in rapporto all’equatore e a un meridiano di riferimento, ma anche l’estensione da Nord a Sud e da Est a Ovest del mondo abitato, l’œkoumène. Peucer espone in seguito nei loro aspetti principali le tecniche esistenti per determinare latitudine e longitudine. La determinazione delle coordinate di un punto sulla superficie del globo terrestre passa necessariamente per l’osservazione astronomica. Abbastanza facile per la latitudine, il calcolo della longitudine nel XVI secolo è ancora problematico. Essa si ottiene con l’osservazione concomitante dello stesso fenomeno celeste (ad esempio un’eclisse di luna) in due luoghi distinti. La differenza tra le ore di inizio del fenomeno in ciascun luogo indica la differenza di longitudine, espressa in unità di tempo. Il problema fondamentale attiene alla necessità d’avere in ciascun luogo una conoscenza assai precisa dell’ora e il mezzo di misurare con precisione lo scorrere del tempo. Peucer non si ferma a queste questioni, se non per indicare le tecniche antiche, e relativamente facili da riprodurre, del calcolo della latitudine per mezzo di uno gnomon. Riconosce che la determinazione della longitudine crea incertezze, che richiede tempo e la collaborazione di diverse persone e che è senza dubbio preferibile che gli studenti facciano ricorso alle tavole delle coordinate stabilite da altri.
Si tratta di uno dei pochi passaggi dell’opera nei quali l’autore rinvia gli allievi ai testi di riferimento piuttosto che alla loro riflessione personale. Egli sembra essere consapevole del carattere spesso lacunoso dei dati utilizzati ai suoi tempi per la costruzione delle carte. Il fatto di avere a disposizione un’informazione supplementare poteva però spingere i cartografi ad applicare con maggior prudenza le tavole delle coordinate delle grandi città del mondo che erano riportate dalle edizioni aggiornate della Geografia di Tolomeo e i trattati moderni di cosmografia. Le distanze tra le città erano spesso conosciute in modo approssimativo, sulla base dell’esperienza dei tempi di spostamento da un luogo all’altro. Un risultato ottenuto con il metodo di calcolo proposto da Peucer poteva avere l’effetto di suscitare la sfiducia del cartografo riguardo alle coordinate geografiche trasmesse senza correzione. Il metodo del De dimensione terrae era dunque di ausilio alla verifica di questi dati.
Riguardo alla questione che più gli interessa, cioè il calcolo delle distanza tra due punti conosciuti, Peucer fornisce allora una traduzione geometrica del caso generale. Due punti sulla superficie della terra di cui sono note le coordinate consentono, prolungando sino all’equatore i meridiani sui quali sono situati, di costruire un triangolo sferico che costituisce la base dei calcoli sviluppati in seguito. Un vertice di questo triangolo si trova al polo del globo terrestre. Due lati sono costituiti dai meridiani, prolungati sino all’equatore, sui quali si trovano i punti conosciuti, L’angolo formato al polo del globo terrestre è dato dalla differenza di longitudine tra i due punti. Le distanze rispettive dei punti dal polo e dall’equatore sono conosciute dalle latitudini. Questa configurazione generale consente a Peucer di distinguere poi nove casi di figure, determinati in funzione della posizione dei luoghi conosciuti (sullo stesso parallelo oppure no, sull’equatore, nello stesso emisfero oppure no) e dei diversi triangoli così costruiti. Si tratta sempre di giungere a una risoluzione dei triangoli a partire dagli angoli e delle distanze conosciuti, utilizzando un piccolo numero di teoremi geometrici. Peucer fornisce due comuni definizioni di trigonometria prima di entrare nel dettaglio delle dimostrazioni, quelle di sinus rectus e di sinus totus. Queste definizioni non corrispondono alle funzioni trigonometriche nel significato odierno. Il sinus rectus è la metà di corda d’arco definita da una retta qualsiasi che taglia un cerchio e il suo diametro (che la corda taglia ad angolo retto). Il sinus totus, nella stessa costruzione, è la metà del diametro, o il raggio tagliato dall’arco.
Il trattato prosegue, per ciascuno dei nove casi determinati, in modo analogo: definizione del caso, traduzione in termini di problema geometrico, metodo di risoluzione, infine applicazione a uno o più casi geografici reali. Peucer si cura di spiegare con precisione il suo metodo e di ricordare in ogni caso i teoremi che utilizza. Nell’opera egli però non fornisce alcuna tavola trigonometrica, il che pone il problema di quali tavole utilizzassero gli studenti, anche se sembra probabile che il
De dimensione terrae facesse riferimento a quelle di Regiomontanus. Tra i vari teoremi, quelli che interessano strettamente la
trigonometria sferica sono assai pochi e sono basati su quelli di Regiomontanus e Copernico. Quest’ultimo è ben conosciuto nell’università sassone, grazie alla mediazione di Rheticus e all’interesse che il
De revolutionibus orbium coelestium (1543) ha suscitato tra i matematici dell’ateneo. Il
De dimensione terrae sembra comunque utilizzare in modo sistematico e approfondito il trattato di Regiomontanus, che rappresenta alla metà del XVI secolo l’opera di trigonometria più nuova e completa.
Peucer, in realtà, cita un solo teorema di Copernico, che chiama “terzo teorema di Copernico”, senza fornirne il contenuto. Si tratta della terza proposizione del capitolo XIV della prima parte del De revolutionibus, lo sviluppo di un teorema già noto a Tolomeo e utilizzato dal matematico arabo Jabir. I primi tre teoremi di Copernico tratti da Euclide e Copernico nel De revolutionibus sono infatti i seguenti:
“Dato il diametro di un cerchio, sono dati anche I lati del triangolo, del quadrato, del pentagono dell’esagono e del decagono che lo stesso cerchio circoscrive”. (“Theorema Primum”);
“È inoltre manifesto che quando è data una corda che sottende un arco, si può trovare quella corda che sottende il resto del semicerchio” (“Porisma” – corollario autoevidente);
“Quando per esempio sono dati il lati del pentagono e dell’esagono inscritti, da questo calcolo è data una linea che sottende un arco di 12°, che è la differenza tra gli archi ed è uguale a 20.905 parti del diametro” (
“Theorema Tertium”). Con riferimento alla figura, si ha infatti:
Nella moderna notazione trigonometrica, il calcolo sopra riportato corrisponde alla seguente applicazione della formula di sottrazione:
Il teorema è utile a Peucer in quanto i meridiani su cui giacciono i luoghi geografici conosciuti tagliano l’equatore ad angolo retto e formano un triangolo rettangolo. L’utilizzo ripetuto di questo teorema e la sua citazione sempre allusiva sembrano testimoniare una certa diffusione a Wittenberg dell’opera dell’astronomo polacco, nonostante il fatto che le autorità accademiche proibissero l’insegnamento della teoria eliocentrica. Ciò conferma che i lavori di Copernico erano allora considerati assai seri e che l’astronomo era valutato come uno dei più grandi esperti, a prescindere dall’accettazione delle sue idee cosmologiche.
Il testo del Peucer possiede dunque la caratteristica, allora rara, di distinguere un oggetto di studio effettivamente geografico. Il manuale si differenzia chiaramente dai trattati di cosmografia del XVI secolo, che mescolano di frequente questioni fisiche (la natura del cielo), astronomiche (osservazione degli astri, in particolare per la determinazione delle coordinate), geografiche (suddivisione della sfera terrestre in zone climatiche, inventario sommario dei popoli che l’abitano), tecniche (proiezioni cartografiche) e storiche. Peucer dedica tutta la sua opera all’oggetto terrestre, slegato del suo contesto celeste: si tratta di un passo importante nel processo di costituzione di una disciplina geografica autonoma. L’autore, d’altra parte, restringe il suo studio geografico ad un approccio geometrico della sfera. Questa scelta si può spiegare con il contesto universitario di produzione dell’opera, che sottoponeva gli studenti di filosofia a un
cursus studiorum stabilito rigidamente e a un ordine determinato di saperi. L’accresciuta importanza della matematica a Wittenberg ha senza dubbio contribuito in modo considerevole allo statuto della geografia come disciplina autonoma: a Wittenberg la valorizzazione della matematica spingeva a considerare la geografia come esercizio matematico, e non come accumulazione di contenuti di saperi differenti.
Al di fuori del contesto accademico, il
De dimensione terrae senza dubbio non è mai stato un manuale di utilizzo corrente tra i cartografi. Nel XVI secolo, solo le carte dedicate a piccole superfici potevano spingere a lavori sistematici di misura e calcolo di distanze con la triangolazione. Quest’ultima faceva ricorso solo alla geometria piana, e cercava di individuare i luoghi gli uni in rapporto agli altri senza utilizzare il sistema di coordinate geografiche. All’opposto, la cartografia a piccola scala applicava il più delle volte dei dati ricavati da realizzazioni cartografiche anteriori e a tavole di coordinate stabilite dagli astronomi. Questo tipo di costruzione cartografica era in gran parte affare di letterati, tra i quali le conoscenze matematiche erano assai ridotte. In entrambi i casi, il metodo proposto da Peucer con lo scopo di verificare con il calcolo l’esattezza delle coordinate geografiche non poteva essere di grande utilità. Fu solo nel XVII secolo che vide la luce una geodesia sistematica, che utilizzava, a piccola o a grande scala, il calcolo delle coordinate e la geometria sferica. Fu sempre all’inizio del Seicento che le università tedesche cominciarono ad affiancare all’insegnamento della filosofia i corsi di matematica applicata diretti a formare ingegneri e geometri, le cui funzioni progressivamente si professionalizzarono. Assai innovativo, sia per il suo oggetto e il suo metodo, sia per l’attenzione che accordava alle novità matematiche del tempo, il
De dimensione terrae non poteva trovare un largo pubblico tra i contemporanei.
Fonti principali:
Axelle Chassagnette, La géométrie appliquée à la sphère terrestre, Histoire & mesure [Online], XXI - 2 | 2006, Online since 01 décembre 2009.
Peucer, Kaspar: De Dimensione Terrae Et Fontibvs Doctrinae Longitvdinis Et Latitvdinis Locorvm, Wittebergae, 1550 - Digitalisierung, Nachweis, Bereitstellung im WWW und Langzeitarchivierung der im deutschen Sprachgebiet erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (1518-1600) der Bayerischen Staatsbibliothek – MDZ Münchener Digitalisierungs Zentrum.