Al talento bizzarro del poeta Ludovico Leporeo (1582–1653 circa) ho già dedicato un articolo un paio d’anni fa. Egli fu l’inventore dei leporeambi, poesie di forme diverse (molto spesso sonetti), con metrica variabile, piene di termini inusitati, parole sdrucciole e bisdrucciole, rime interne, assonanze, allitterazioni, un funambolico meccanismo al quale l’autore pensava di affidare la propria fama d'inventore di un nuovo modo di far poesia. Autore barocco per eccellenza, in lui la grande capacità tecnica prevaleva sul messaggio: la sua arte è stata accusata di dir niente nel modo più complicato possibile, eppure è una poesia seducente, a tratti anticipatrice degli esperimenti delle avanguardie o dei giochi dei ludolinguisti.
I leporeambi morirono con il proprio creatore, almeno fino a quando un blogger che poeta non è gli ha trovati simpaticamente adatti all’invettiva politica, pur essendo consapevole della sua grande imperizia tecnica. Preveggente, il Leporeo gli dedicò questo sonetto:
Leporeambo alfabetico duodecasillabo satirico unisono irrepetito
Contra un improvisatore
acoli-ecoli-icoli-ocoli
O tu, che in poesia fai li miracoli
E 'l tutto hai penetrato allor che specoli,
Giust'è che l'universo si trasecoli,
Ché in verseggiar non hai minimi ostacoli.
Tu stampe non adopri o carte macoli,
E fai versi latini, etruschi, e grecoli,
E dicon quelli a cui narrando io recoli
Che per la bocca tua parlan gli oracoli.
Tu li poeti e i retori sventricoli,
L'Arcifanfano fai degli Arcicocoli,
E del rimario sai tutti gli articoli.
Argo sei de' Tersiti e de' monocoli,
Degno che per le piazze e per li vicoli
Ti si lancino aranci e bericocoli.
Quelli qui di seguito presentati sono componimenti dal metro irregolare, piuttosto zoppicanti, scritti per sfogare una certa indignazione in una forma che la fa virare verso il disincanto. La loro allegra idiozia è un tentativo di cogliere l’odierno cretinismo parlamentare e mediatico.
Leporeambo irregolare politico indignato irrepetito
A un trasformista di lungo corso
otto-etto-atto-itto
Meriteresti di prigion anni otto,
per il ceffo tuo che pare un retto,
la bocca larga da fare effetto
e il naso grosso da fagiol borlotto.
Poi altri trenta perché sei corrotto,
piduista come il nano abbietto,
vestito sempre in doppiopetto,
che ti prese come zerbinotto.
Per la menzogna tu sei adatto,
e dentro di te ti credi un dritto,
ma tarocco sei come il bagatto.
Or finisce l’era del gran guitto
e tu con lui, politico d’accatto,
leccante lacchè, ciccio Cicchitto.
Leporeambo irregolare politico infuriato irrepetito
Al moderato dai toni concilianti
ente-inte-onte-ante
I compari ti dicon intelligente
per le tue uscite assai distinte,
che nella saggezza paion intinte:
del compromesso tu sei l’agente.
Ma non scordo quando, indecente,
con parole di doppiezza incinte,
parlasti alla Camera dalle quinte
rivendicando opposizion clemente.
E quando dicesti di tua sponte
a seguaci e nipoti di Almirante
che Salò era un degno fronte.
Mente conciliante e benpensante,
per il poter, vero camaleonte,
daresti pur il culo, mio Violante.
Leporeambo irregolare politico acrostico irrepetito
Il capopopolo
allo-ello-ollo-illo
Benvenuto anche tu al gran ballo
E della politica il gran bordello,
Per pestar col tuo randello
Padrino, ruffiano e lor vassallo.
Eminenza, deputato e maresciallo,
Gelosi del lor pingue orticello,
Riuniti in furioso capannello,
Imprecan con parole da camallo.
La Presidenza perde il controllo,
Levandosi con fare da caudillo:
Oramai paventa il suo tracollo.
Ritieni che basti indicar bacillo?
Inver sei illuso fino al midollo,
Perché curar non sai, Beppe Grillo.










.jpg)






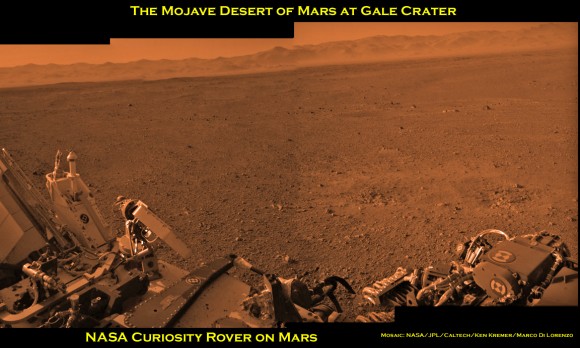
















+-+1.jpg)











