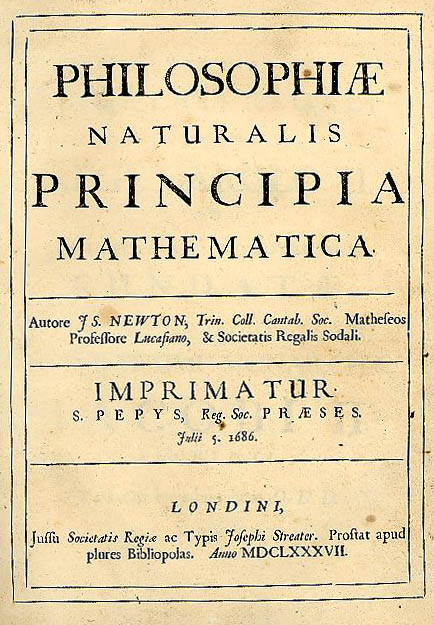George Atwood (1745-1807) era il primo figlio del curato della parrocchia di St. Clement Danes, a Westminster. Dopo aver frequentato la Westminster School, a partire dal 1759, entrò al Trinity College di Cambridge nel 1765 come pensionante (cioè si pagava da solo il mantenimento), ma gli fu poi concessa una borsa di studio l’anno successivo. Si laureò con un baccalaureato nel 1769, e conseguì il dottorato nel 1772. Nel 1773, divenne esercitatore. Le sue lezioni erano molto seguite, grazie alle spettacolari dimostrazioni sperimentali. Pubblicò le descrizioni delle sue dimostrazioni nel 1776, anno in cui fu eletto Fellow della Royal Society.
Atwood è ora conosciuto soprattutto per un libro di testo sulla meccanica newtoniana, A Treatise on the Rectilinear Motion and Rotation of Bodies, pubblicato nel 1784, dove descrive in dettaglio una macchina per esperimenti ora conosciuta come macchina di Atwood. Nello stesso anno pubblicò anche una seconda opera, An Analysis of a Course of Lectures on the Principles of Natural Philosophy, che è una versione ampliata del suo corso a Cambridge.
La maggior parte delle altre opere pubblicate da Atwood consiste nella trattazione matematica di problemi pratici. Una menzione meritano i suoi lavori sulla stabilità delle navi, dove estese le teorie esistenti per rendere conto della stabilità dei corpi galleggianti con ampio angolo di rollio, e per i quali, nel 1796, fu insignito della Medaglia Copley della Royal Society. Atwood morì nel luglio 1807 e fu sepolto nella chiesa di St. Margaret a Westminster, dove suo fratello minore Thomas era succeduto al padre come curato.
Il nome di Atwood è quasi interamente legato alla macchina dinamica da lui inventata tra il 1776 e il 1779. Il suo scopo, secondo i testi apparsi dalla fine del ‘700 fino a tempi recenti, era quello di condurre esperimenti che dimostrassero le leggi dei moti rettilinei (e rotazionali) dei corpi, con particolare riferimento ai moti regolati dalla gravità. Tale scopo della macchina di Atwood si affermò solo dopo il generale accoglimento della meccanica newtoniana, ma nella Cambridge degli anni Settanta e Ottanta del Settecento servì proprio a realizzare definitivamente tale risultato davanti a giovani studenti e studiosi che in seguito diffusero il paradigma newtoniano.
I dispositivi dimostrativi, che andavano dai planetari e i globi astronomici alle tavole con le quali si insegnavano i principi della meccanica, costituivano il corredo essenziale per i fabbricanti di strumenti di filosofia naturale nella Gran Bretagna di fine Settecento. Questi strumenti erano utilizzati in conferenze e lezioni pubbliche, che diventavano veri spettacoli per coinvolgere il pubblico utilizzando stratagemmi per mostrare le dottrine sulla natura. Ad esempio, le pulegge e i pesi in caduta coinvolti negli strumenti della meccanica newtoniana erano progettati ingegnosamente per minimizzare l'attrito e distinguere l'inerzia dalla gravità. Lo scopo della dimostrazione era di far sembrare inevitabile e credibile una certa interpretazione dei fenomeni naturali. Ciò richiedeva da parte del dimostratore un lungo allenamento, che a sua volta necessitava di essere attentamente gestito per non dirigere l’attenzione solamente sulla macchina utilizzata per la dimostrazione. Così essa richiedeva tattiche per rendere naturali i gesti e un po’ di doti teatrali.
Newton aveva scritto che il fatto cruciale che tutta la materia gravita in proporzione alla sua massa “si può dimostrare solo con gli esperimenti”. Le macchine per gli esperimenti erano progettate proprio per dimostrare queste idee. Atwood sostenne che la sua macchina era uno strumento che poteva davvero produrre tali certezze, e non semplicemente un dispositivo per dimostrare principi che gli studenti potevano già aver compreso sul piano teorico. La sfida degli esercitatori e dei divulgatori newtoniani consisteva anche nel fatto che non potevano permettersi di opporre dogmatismo a dogmatismo: le loro dimostrazioni dovevano convincere.
La macchina è descritta nel Trattato di Atwood del 1784, ma la sua diffusione fuori dall'Inghilterra risale già alla fine degli anni '70 del Settecento. Essa è costituita solo da due cilindri bilanciati collegati da una corda di seta sospesa (considerata inestensibile e priva di peso) su una puleggia, dove possono essere attaccati (e rimossi) pesi aggiuntivi a uno dei due cilindri in modo da fornire una (o nessuna) forza che agisce sul sistema. Il grande merito del filosofo naturale inglese è quello di aver trasformato una normale puleggia in un dispositivo capace di eseguire esperimenti e dimostrazioni raffinate, adatti a essere trattati con gli strumenti dell’analisi matematica.
È abbastanza istruttivo seguire da vicino come Atwood abbia ideato la sua macchina ingegnosa, partendo dalle sue prime considerazioni sul problema classico della sperimentazione sulla caduta libera dei corpi.
"Il metodo più ovvio sarebbe quello di osservare l'effettiva discesa di un corpo pesante, mentre cade verso terra per la sua naturale gravità: ma in questo caso è evidente che, a causa della grande velocità generata in pochi secondi di tempo, l'altezza dalla quale cade il corpo osservato deve essere considerevole. […] Se per rimediare a questo inconveniente si fanno scendere dei corpi lungo piani inclinati, secondo gli esperimenti del celebre autore [Galileo] di questa teoria, variando la proporzione dell'altezza del piano alle loro lunghezze, la forza dell'accelerazione può essere diminuita in qualsiasi rapporto, in modo che i corpi discendenti si muovano sufficientemente lenti da permettere che i tempi di movimento dalla quiete siano accuratamente osservati; e gli effetti della resistenza dell'aria a corpi che si muovono con queste piccole velocità saranno assolutamente trascurabili: la principale difficoltà però che qui si verifica, deriva dalla rotazione dei corpi discendenti, che non può essere impedita senza aumentare il loro attrito ben oltre quanto l'esperimento consenta" (pp.295-6).
In particolare, qui la "difficoltà principale" sta nel fatto che l'accelerazione di un corpo rotante mentre scende lungo un piano inclinato è ridotta rispetto al caso in cui la rotazione non si verifica, quando la gravità è l'unica causa di tale effetto. Il problema previsto da Atwood non è la considerazione dell'effetto di rotazione (conosceva i corretti fattori di riduzione: 5/7 per una sfera e 2/3 per un cilindro), ma semplicemente la sovrapposizione di due effetti (rotazione e gravità) che avrebbero potuto causare una non univoca accettazione del paradigma newtoniano.
"Non ci sono mezzi per separare la massa mossa dalla forza in movimento; non possiamo quindi applicare forze diverse per muovere la stessa quantità di materia su un dato piano, né la stessa forza a quantità diverse di materia. Inoltre, essendo la forza accelerante costante e inseparabile dal corpo mosso, la sua velocità sarà continuamente accelerata, in modo da rendere impossibile l'osservazione della velocità acquisita in un dato istante" (p.298).
Il primo problema è che, con un piano inclinato, non è possibile studiare la dipendenza della forza che agisce sul corpo dalla sua massa, dimostrando così la seconda legge del moto di Newton. Il secondo problema sperimentale più complesso è invece l'impossibilità di misurare la velocità del corpo in un qualsiasi istante di tempo desiderato, poiché cambia continuamente, e quindi l'impossibilità di provare la legge del tempo per la velocità nel moto uniformemente accelerato.
Qual era, allora, l'obiettivo di Atwood? I termini del problema sono ben delineati: come è possibile congegnare una serie di esperimenti con un'unica macchina con cui si affrontano forza, massa, velocità, distanze e tempi? Senza precedenti suggerimenti di altri autori, Atwood concentra la sua attenzione sulle pulegge, già conosciute da molti secoli. Ma qui il cambio di prospettiva è cruciale: un dispositivo convenzionale impiegato in statica come una semplice macchina si trasforma nelle mani di Atwood in un dispositivo dinamicamente ridimensionato con cura, in grado di essere sottoposto ad analisi matematica per l'illustrazione del pensiero newtoniano. In questa luce, infatti, si può dare un'interpretazione coerente ad una serie di problemi cinematici e dinamici - solo esercizi teorici, non direttamente collegati alla sua macchina - che compaiono nel Trattato, la maggior parte dei quali non sono affatto considerati nei successivi libri di testo sul dispositivo.
"Nello strumento costruito per illustrare sperimentalmente questo argomento, A, B rappresentano due pesi uguali fissati alle estremità di un filo di seta molto sottile e flessibile: questo filo è teso su una ruota o puleggia fissa abcd, mobile attorno ad un asse orizzontale: i due pesi A, B sono esattamente uguali e agendo l'uno contro l'altro, restano in equilibrio; e quando il minimo peso viene aggiunto a uno dei due (mettendo da parte gli effetti dell'attrito) prevarrà" (p. 299).
I problemi generali sopra previsti (tempi di caduta troppo brevi - in caduta libera o su un piano inclinato - richiedono distanze molto grandi percorse dal corpo in caduta, sul quale agisce però una forza di attrito non trascurabile, e il corpo raggiunge anche velocità troppo grandi in prossimità della fine del suo moto) scompaiono subito: un piccolo squilibrio di massa induce piccole accelerazioni e velocità, impedendo così inutili grandi altezze di caduta e, quindi, trascurando l'azione della resistenza dell'aria. Ma l'obiettivo di Atwood è una precisa conferma delle leggi di Newton, e se la realizzazione di pesi accuratamente bilanciati, oltre che di piccoli pesi aggiuntivi rimovibili, è lasciata all'arte di abili artigiani, il possibile attrito sviluppato dall'asse della puleggia merita un’appropriata considerazione.
"Quando l'asse è orizzontale è assolutamente necessario che sia appoggiato su ruote di attrito, le quali diminuiscono molto, o impediscono del tutto, la perdita di moto che sarebbe causata dall'attrito dell'asse, se ruotasse su una superficie immobile".
Un tale meccanismo, introdotto in precedenza probabilmente dall'orologiaio francese Henry Sully, fu installato da Atwood sulla sommità della colonna cilindrica della sua macchina, sulla quale è montato anche un orologio a peso per effettuare misurazioni del tempo, mentre un righello con "una scala di circa 64 pollici di lunghezza graduata in pollici e decimi di pollice" è aggiunto su un'altra colonna verticale per consentire la misurazione delle distanze percorse dai corpi sospesi sulla corda. L'assemblaggio con le ruote è, curiosamente, un pezzo rimovibile della macchina: Atwood stava, infatti, creando un dispositivo in grado di studiare i movimenti rettilinei e la rotazione dei corpi, a cui è dedicata quasi la metà del suo Trattato. Il riconoscimento di questa importante seconda parte della meccanica andrà perso nelle successive descrizioni della macchina di Atwood (e le successive copie della macchina stessa non mostreranno più l’ingranaggio rimovibile con le ruote di frizione) ma non dovrebbe cadere nell'oblio il fatto che In origine Atwood mirava a concepire una macchina "universale" adatta allo studio del moto sia rettilineo sia rotatorio.
Ciò è chiaramente testimoniato da una serie di interessanti esperimenti, proposti nel suo Trattato, da realizzare con l'ausilio di ulteriori accessori. Tuttavia, mentre la parte principale della macchina "fu eseguita con grande perizia meccanica, in parte dal signor L. Martin, e in parte dal signor G. Adams, costruttori di strumenti matematici a Londra", tali accessori non furono mai realizzati, probabilmente per il mutamento degli interessi dell’autore. Pertanto, la macchina di Atwood è stata successivamente associata solo agli studi sul moto rettilineo sotto l'azione di una forza costante.
In che modo Atwood ha ottenuto un'illustrazione soddisfacente del paradigma newtoniano con la sua macchina? Il primo passo è, ovviamente, riprodurre la legge di proporzionalità di Galilei tra le distanze percorse s e il quadrato del tempo trascorso t nel moto uniformemente accelerato: s ∝ t2. Sotto “l'azione della forza costante m" (m, qui la forza mobile netta, corrisponde al peso di 1/4 di oncia di materia; è considerata una quantità standard negli esperimenti di Atwood),
"Se i tempi di movimento sono 1 secondo, 2 secondi e 3 secondi, gli spazi descritti da fermo dal peso discendente A in quei tempi saranno rispettivamente 3 pollici, 3×4 = 12 pollici e 3×9 = 27 pollici; gli spazi descritti essendo in un rapporto duplicato dei tempi di moto" (p. 318).
Il secondo passo è studiare la dipendenza di s dall'accelerazione a del corpo discendente, qui ottenuta, in unità del valore di caduta libera g, dal rapporto tra la massa instabile e la massa totale dei corpi sulla puleggia (in termini moderni, a/g = ∆m/mtot):
"Risulta da questi esperimenti, che quando i tempi sono gli stessi, gli spazi descritti dal riposo sono come la forza di accelerazione" (p. 320) (“forza di accelerazione” significa qui accelerazione). Vale a dire, s ∝ a. Cos'altro sull'equazione del moto per quanto riguarda la distanza percorsa? Ovviamente, che a ∝ 1/t2.
"L'ultima parte dell'esperimento mostra che se lo spazio descritto rimane lo stesso, mentre la descrizione del tempo è diminuita, la forza di accelerazione deve essere aumentata in una proporzione duplicata della diminuzione dei tempi" (p. 321).
Da questi esperimenti, quindi, è completamente derivata la legge del tempo che, in termini moderni, scriviamo come s = 1/2 at2.
Atwood considera poi esperimenti idonei ad ottenere la legge della velocità, la cui misura con la macchina è particolarmente interessante. Supponiamo infatti con Atwood che la velocità istantanea del corpo discendente sia richiesta quando passa ad una certa altezza. Quindi, a tale altezza viene posizionato un anello sulla colonna con il righello, il cui anello è progettato per rimuovere la massa aggiuntiva e sbilanciata (la cui lunghezza supera il diametro dell'anello) consentendo il passaggio del corpo principale su cui è apposto. In tal modo, e d'ora in poi, la puleggia è completamente equilibrata, ed i due corpi continuano a muoversi con velocità costante, il cui valore è facilmente ricavabile dal rapporto della distanza percorsa in un dato tempo. Con questo trucco, la legge per la velocità può essere verificata sperimentalmente anche applicando una forza costante al corpo, e il primo risultato che si ottiene è la proporzionalità tra la velocità istantanea e il tempo trascorso: v∝t.
"Durante i diversi tempi di 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi, ecc. le velocità generate saranno rispettivamente di 6 pollici, 12 pollici e 18 pollici in un secondo, essendo nella stessa proporzione con i tempi in cui agisce la forza data" (pag. 324).
Pertanto:
"Sembra quindi che se forze diverse accelerano lo stesso corpo dalla quiete durante un dato tempo, le velocità generate saranno nella stessa proporzione con queste forze".
(“forze”, è bene ribadirlo, significa “forze acceleranti” o, semplicemente, accelerazione), cioè v ∝ a, in un tempo costante. Infine, come sopra, la legge completa v = at si ottiene mediante le proporzioni:
"Se i corpi sono azionati da forze di accelerazione, che sono nella proporzione di 3:4, e per tempi, che sono come 1:2, le velocità acquisite saranno nel rapporto di 1 × 3 a 2 × 4, o come 3 a 8" (pag. 326).
Vengono poi descritti altri due esperimenti per dimostrare che, per corpi accelerati attraverso lo stesso spazio s, allora v∝√a (p. 327) e, viceversa, sotto l'azione della stessa accelerazione a, v∝ √s (p. 328). Vale a dire, in termini moderni, v = √2as.
Infine, e soprattutto, "la forza in movimento deve essere nello stesso rapporto delle quantità di materia spostate", che è la seconda legge della dinamica di Newton. Gli esperimenti per illustrare questa conclusione possono essere compresi nella tabella.
Dalle prime tre colonne risulta evidente che la “forza mobile” è uguale al prodotto della “quantità di materia mossa” per la “forza accelerante”, o, nelle notazioni moderne, F = ma.
L'accuratezza delle conclusioni raggiunte da Atwood dipende ovviamente dalla sensibilità della sua macchina e da eventuali errori sistematici legati principalmente all'attrito e alla prontezza dello sperimentatore per le misurazioni del tempo. Quest'ultimo punto è stato considerato solo a grandi linee da Atwood, che ha appena avvertito possibili altri sperimentatori di allenarsi con l'attivazione "simultanea" dell'orologio a pendolo con la partenza del corpo discendente. Questa è evidentemente la principale fonte di imprecisione. Il problema dell'attrito, inclusa la resistenza dell'aria, era già stato affrontato, ma vale la pena ricordare il fatto che Atwood non si era limitato ad affermare semplicemente che “gli effetti dell'attrito sono quasi del tutto rimossi dalle ruote di attrito” (p. 316), anzi, aveva quantificato tale affermazione facendo un esperimento preliminare:
"Se i pesi A e B sono messi in perfetto equilibrio, e l'intera massa consiste di 63 m, secondo l'esempio già descritto, un peso di 11 grani, o al limite 2 grani, aggiungendo 2 ad A o B, comunicherà il movimento al tutto, il che mostra che gli effetti dell'attrito non saranno così grandi come un peso di 11 o 2 grani" (p. 316).
Si noti che una massa di 1 m corrispondeva a ¼ di oncia, mentre 480 grani rappresentavano 10 once (e quindi 2 grani ≃ 1/240 oz), quindi la sensibilità della puleggia era estremamente alta. Con il suo dispositivo, Atwood è stato quindi in grado di misurare accelerazioni fino a 1/64 del valore di caduta libera, una precisione senza precedenti in tali studi. Questo fatto fu anche il motivo della successiva fortuna della macchina di Atwood in tutta Europa.
La diffusione della macchina di Atwood fuori dall'Inghilterra avvenne ben prima della comparsa del Trattato, dove veniva descritta insieme agli esperimenti da eseguire con essa. Infatti, alcuni studiosi che ebbero l'opportunità di assistere alle dimostrazioni di Atwood a Cambridge alla fine degli anni Settanta del Settecento, intuirono subito l'importanza della macchina e ne diffusero la notizia, anche sottoscrivendo l'acquisizione di sue copie. Fu così il portoghese Magallanes il primo a pubblicare (nel 1780) un opuscolo in cui veniva ampiamente descritta la macchina, insieme a una serie di esperimenti sul moto uniforme e accelerato, sotto forma di lettera indirizzata a Volta a Pavia. L’italiano Giuseppe Saverio Poli riportò (nel 1781) per la prima volta un'illustrazione della nuova macchina, realizzata sulla copia commissionata al liutaio Ramsden, in una pubblicazione dove sono descritti anche alcuni esperimenti.
Il modello prodotto da Ramsden (il secondo mai realizzato, compreso quello originale di Atwood) introdusse un dispositivo aggiuntivo, suggerito da Poli, per innescare l'attivazione simultanea dell'orologio a pendolo e l'inizio della massa discendente. Chiaramente finalizzata ad un miglior funzionamento della macchina e, di conseguenza, ad una riduzione degli errori di misura, questa leva aggiuntiva fu sempre inclusa nelle copie successive nel corso del XIX secolo, a prescindere dalla “semplificazione” della macchina di Atwood (il gruppo asportabile di cinque ruote di frizione fu sostituito da un gruppo fisso di ruote o anche solo una semplice puleggia).
Tali modifiche avvenute sono emblematiche del diverso uso che se ne faceva. Una volta che la meccanica di Newton fu definitivamente accettata nei corsi accademici come l'unica teoria del moto possibile, la macchina di Atwood non servì più come dispositivo di dimostrazione del successo del paradigma newtoniano. Il suo uso cambiò di conseguenza e divenne uno strumento didattico che consentiva diversi esperimenti illustrativi sulla caduta dei corpi, o anche solo sul moto uniforme o uniformemente accelerato (ma anche su altri fenomeni come la legge di Stokes).
Riferimento principale:
Salvatore Esposito, Edvige Schettino, Spreading scientific philosophies with instruments: the case of Atwood’s machine, arXiv:1204.2984v1 [physics.hist-ph], 13 April 2012
.jpg)