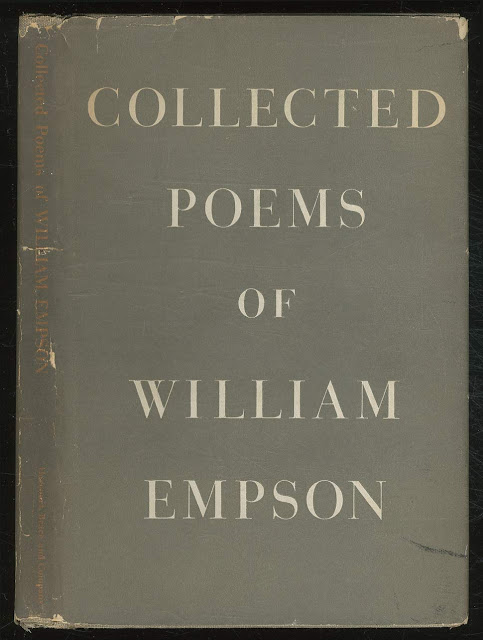William Empson (1906-1984), poeta e critico letterario, nacque nel 1906, ultimo dei cinque figli di un agiato proprietario terriero. A scuola eccelleva in matematica, Quando la miopia gli impedì di intraprendere la carriera navale che la sua famiglia desiderava per lui, nel 1925 vinse una borsa di studio in matematica al Magdalene College di Cambridge. Si iscrisse poi ai test di lingua di recente costituzione, sotto la tutela di I.A. Richards, autore di Principles of Literary Criticism (1924) e Science and Poetry (1926), e nel giugno 1929 fu premiato con una “speciale distinzione”.
Il mese successivo, tuttavia, il preside del Magdalene scelse di dargli una lezione severa per una disattenzione. Quando i custodi scoprirono che Empson era in possesso di contraccettivi, fu accusato anche di aver intrattenuto una donna nella sua stanza a tarda ora. Una riunione straordinaria dell'organo di governo del college decise di punirlo in modo esemplare (poiché la cattiva condotta sessuale era considerata un reato universitario), togliendoli la borsa di studio. Per i due anni successivi visse a Londra, dove si affermò come scrittore e frequentò scrittori come T. S. Eliot e Virginia Woolf.
A Cambridge Empson aveva scritto numerose recensioni di libri, film e opere teatrali per alcuni periodici studenteschi; nel 1928 lanciò The Experiment, una rivista universitaria gestita da un gruppo di studenti i cui interessi attraversavano l'intera gamma delle arti e delle scienze, e divenne presidente di un gruppo di discussione umanistica, gli Heretics.
Fu sempre a Cambridge che Empson si fece la reputazione di uno dei poeti più importanti della sua generazione. Molte delle poesie contenute nella sua prima raccolta, Poems (1935), apparvero per la prima volta nei periodici della città universitaria. La densità metafisica e la passione emotiva della sua poesia suscitavano stupore e consensi, tanto che la Cambridge Review lo salutò come un vero successore di John Donne (che Empson aveva preso come modello). Un secondo volume, The Gathering Storm, apparve nel 1940; le due raccolte furono riunite in Collected Poems, nel 1949, e, in un'edizione ampliata, nel 1955. La sua poesia tocca numerosi temi, dalla metafisica alla malinconia, dal sociale all'amore e alla perdita, tutti trattati con stoica dignità. Soprattutto, tuttavia, Empson fu stimolato dalle scoperte della scienza moderna, che una volta definì "l'unica parte fertile della mente contemporanea": secondo lui, la scienza è letteratura: “ho sempre trovato l’immagine del mondo degli scienziati molto più stimolante e utilizzabile di quella di qualsiasi “influenza letteraria””. A Cambridge, dove il premio Nobel per la fisica Ernest Rutherford era direttore del Cavendish Laboratory, e Sir Arthur Eddington professore di astronomia, Empson era affascinato dagli ultimi progressi nella conoscenza scientifica, specialmente in fisica e astronomia, così che la morale e la filosofia e le implicazioni della nuova scienza divennero centrali nella sua opera.
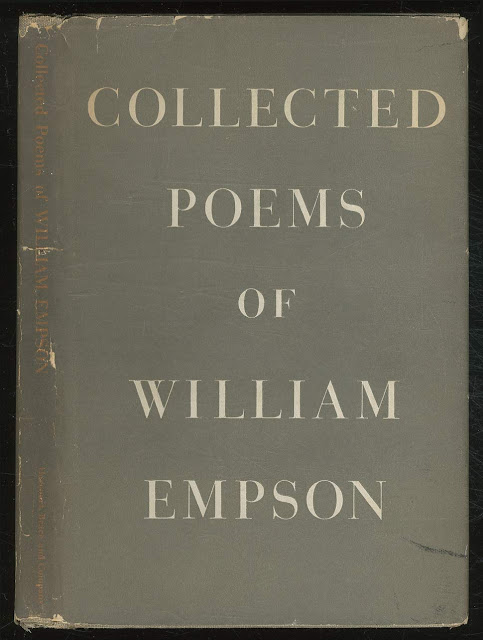
La poesia di William Empson "Lettera I" (1928-1935) è paradigmatica della sua opera in versi: colta, un po’ elitaria, di difficile lettura e interpretazione, ma indubbiamente originale e affascinante. Essa sembra anticipare i buchi neri, usando l'idea di una stella morente, da cui nessuna luce sfugge, come metafora di una passione non corrisposta. Un'analisi attenta del contesto universitario in cui fu scritta la poesia, insieme alle altre fonti incorporate con i testi divulgativi di Arthur Eddington, rivela la motivazione dietro l’ingegnosa sfida di Empson ai limiti di ciò che era possibile secondo la relatività generale. La volontà di Empson di seguire l'esempio di John Donne (che aveva inquadrato i propri affari amorosi all'interno dell’allora nuova visione copernicana), utilizzando la nuova cosmologia degli anni '20, lo portò a esplorare una condizione astrofisica estrema che Eddington aveva liquidato come assurda e che aveva ancora uno status scientifico incerto negli anni '30.
Nel 1928, innamoratosi di un compagno di studi a Cambridge (Empson era bisessuale), aveva composto la poesia in forma di lettera per l’amato, prima di una serie di sei, paragonando il suo affetto non corrisposto all'eccessiva curvatura che deformava lo spaziotempo attorno a una stella di grandi dimensioni e densità, una passione che lo separava dal resto dell'universo. Assiduo lettore di scienza popolare, Empson cercò di far entrare l'amore nell'universo descritto da Eddington, il principale divulgatore di Einstein in Inghilterra, e cercò il romanticismo nella curvatura dello spaziotempo e nel destino delle stelle.
La poesia inizia con una citazione di Pascal, avventurandosi in un vuoto senza fine:
You were amused to find you too could fear
‘The eternal silence of the infinite spaces,’
That net-work without fish, that mere
Extended idleness, those pointless places,
Who, being possibilized to bear faces,
Yours and the light from it, up-buoyed,
Even of the galaxies are void.
Ti sei divertito a scoprire che anche tu potresti temere
“L'eterno silenzio degli spazi infiniti”,
quella rete senza pesce, quella mera
indolenza prolungata, quei luoghi inutili,
chi, avendo la possibilità di sopportare gli sguardi,
tuo e la luce che ne deriva, elevata,
come le galassie sono vuote.
Giochi di parole e un ritmo aggraziato aiutano a trasformare gli spazi infiniti in un amore giovanile. Il suo andamento è una miniatura perfetta del modo in cui le poesie di Empson si snodano attraverso punti di vista mutevoli e contrari. La prospettiva di questa prima strofa, che indugia sulle parole inventate "possibilized" e "up-buoyed", è di un fascino rilassato e indulgente, tranne un brivido leggermente inquietante quando "void" chiude la riga conclusiva.
Non è certo una sorpresa sapere l'atteggiamento di chi parla nei confronti dello spazio:
I approve, myself, dark spaces between stars;
All privacy’s their gift; they carry glances
Through gulfs; and as for messages (thus Mars’
Renown for wisdom their wise tact enhances,
Hanged on the thread of radio advances)
For messages, they are a wise go-between,
And say what they think common-sense has seen.
Approvo, io stesso, gli spazi oscuri tra le stelle;
l’isolamento completo è il loro dono; portano sguardi
attraverso gli abissi; e come per i messaggi (perciò Marte
è rinomato per la saggezza con cui aumenta il loro saggio riserbo,
appeso al filo dei progressi radiofonici),
perché i messaggi, sono un saggio intermediario,
e dicono quello che pensano abbia visto il buon senso.
Il corteggiamento continua, con "sguardi" che percorrono il vuoto tra corpi stellari, ma gli sguardi possono anche essere fraintesi. Lo spazio può trasportare messaggi, ma questi possono essere confusi nel processo. Chi parla devia dal suo punto di vista sull'interpretazione del buon senso per suggerire che la reputazione di Marte di ospitare vita intelligente è rafforzata dalla nostra mancanza di comunicazione con i suoi abitanti: potremmo “appendere” le nostre speranze in questo al “filo'' dei progressi della tecnologia radio, ma la svolta cercata potrebbe benissimo mostrarci la vita marziana incomprensibile (la "sospensione" delle speranze si presta a un’inattesa svolta del gioco verbale, accentuato dall'associazione di Marte con la guerra). Possiamo comunicare al meglio solamente con i marziani della nostra immaginazione, una conclusione che non promette particolarmente bene per l'interpretazione del "buon senso" dei segnali tra gli esseri umani.
La terza strofa sviluppa un dubbio radicale sulla comprensione tra gli esseri umani. Come nelle due strofe precedenti, questa condizione è messa in atto dalle parole stesse, che sono piene di riferimenti all’antropologia e alla fisica:
Only, have we sense, common-sense in common,
A tribe whose life-blood is our sacrament,
Physics or metaphysics for your showman,
For my physician in this banishment?
Too non-Euclidean predicament.
Where is that darkness that gives light its place?
Or where such darkness as would hide your face?
Solo, abbiamo senso, il senso comune in comune,
una tribù la cui linfa vitale è il nostro sacramento,
fisica o metafisica per il tuo attore,
per il mio medico in questa messa al bando?
Situazione troppo non euclidea.
Dov'è quell'oscurità che dà alla luce il suo posto?
O perché tale oscurità nasconderebbe il tuo volto?
Nel suo commento al poema, Empson scrisse che mentre la prima strofa descrive "lo spazio vuoto che si può misurare", nella terza parla di una condizione opposta, trovata "quando due stelle non sono affatto collegate dallo spazio". Faceva poi riferimento a un fenomeno astrofisico specifico: "Una stella abbastanza grande e abbastanza concentrata, capisco, si separerebbe completamente dal nostro spazio." La situazione è "troppo non euclidea" non semplicemente perché la curvatura dello spaziotempo è così estrema, ma perché una tale condizione minerebbe la coerenza del mondo fisico. O almeno così credeva la fonte di Empson, Eddington, il quale. In una nota scherzosa, aveva notato le implicazioni "piuttosto interessanti" della teoria della gravitazione di Einstein rispetto a un'ipotetica stella gigante ad alta densità: “In primo luogo, la forza di gravitazione sarebbe così grande che la luce non sarebbe in grado di sfuggirle, i raggi ricadono sulla stella come una pietra sulla terra. In secondo luogo, lo spostamento verso il rosso delle linee spettrali sarebbe così grande che lo spettro sarebbe spostato fuori dall'esistenza. In terzo luogo, la massa produrrebbe così tanta curvatura della metrica spazio-temporale che lo spazio si chiuderebbe intorno alla stella, lasciandoci fuori (cioè da nessuna parte)”. Non convinto di invisibili corpi densi nell'universo, Eddington non poteva tollerare la prospettiva che lo spaziotempo di Einstein producesse una condizione così bizzarra.
Sapere che cosa aveva detto Eddington sulla teoria della gravitazione di Einstein ci aiuta a cogliere la situazione non euclidea, ma la strofa rimane un mistero se non si fa riferimento ad altri interessi di Empson, l’antropologia e la storia della religione e della filosofia antiche. Nella sua nota al poema, Empson spiegava di aver concepito le stelle radicalmente separate in termini di
“due persone senza idee o società in comune, quindi senza "fisica" tra loro in ciò che F.M. Cornford ha detto che era il senso primitivo della parola (physis). In mancanza di una linfa vitale comune condivisa da un totem (attore perché eroe tragico), non sono collegati da alcuna idea il cui nome derivi da quel termine”
C'è sia ironia sia melodramma nella combinazione attuata da Empson di un'idea di Eddington con un riferimento al lavoro di Francis Cornford. Il denso nucleo della poesia è compattato da libri di testo e letture extracurriculari sulle quali Empson e i suoi compagni avevano trascorso piacevoli ore discutendo, ma usa punti di riferimento condivisi nella sua cerchia di compagni di studi per lamentare la mancanza di senso condiviso tra di loro. Nel confezionare le allusioni così densamente, Empson rischia di perdere lettori che non condividono questa conoscenza, chiudendo la poesia stessa in un mondo a parte. Ma forse il fallimento comunicativo della poesia, analizzata nel contesto in cui fu scritta, è proprio il suo scopo. "Lettera I" fu inizialmente pubblicata (con solo queste tre strofe) nel primo numero di Experiment. Molti lettori, anche se disorientati, apprezzarono la sfida di seguire gli argomenti allusivi di Empson in versi, mentre altri scelsero di collocarsi al di fuori delle sue curve non euclidee.
Nel 1935 Empson aggiunse una strofa finale in cui la condizione dell'amante è paragonata a quella di una stella densa e morente che è estremamente calda, ma emette luce che non sarà mai vista da osservatori esterni.
Our jovial sun, if he avoids exploding
(These times are critical), will cease to grin,
Will lose your circumambient foreboding;
Loose the full radiance his mass can win
While packed with mass holds all that radiance in;
Flame far too hot not to seem utter cold
And hide a tumult never to be told.
Il nostro sole gioviale, se evita di esplodere
(Questi tempi sono critici), smetterà di sorridere,
Perderà il tuo presagio circoscritto;
Libererà tutta la radiosità che la sua massa può vincere
Mentre, pieno di massa, trattiene tutto quello splendore;
Fiamma troppo calda per non sembrare del tutto fredda
E nascondi un tumulto che mai verrà detto.
Come spiegò nella sua nota alla poesia, essa si basa sul destino della stella massiccia e densa descrivendo "un simile fallimento di comunicazione che potrebbe alla fine accadere al sole". Facendo riferimento all'inizio della poesia, "il tuo presagio circoscritto" denota "lo spazio vuoto intorno ad esso che ci collega a lui e di cui hai paura".
Durante il periodo di completamento del poema, l'astronomia britannica fu testimone di un aspro dibattito sulla struttura delle stelle nane bianche. Una nana bianca è una stella che ha completato la fusione dell'idrogeno in elio nel proprio nucleo; è uno degli stadi finali possibili del ciclo di vita d'una stella. In questa situazione queste stelle perdono gran parte della loro massa, espellendola in un forte getto di gas (vento stellare). Alla fine ne risulta una nebulosa planetaria, e la stella diventa un piccolo oggetto con un'altissima densità (dell'ordine delle tonnellate per centimetro cubo), che non evolverà più in modo significativo, ma si raffredderà progressivamente sempre di più. Una nana bianca inizia con un gran calore, ed è infatti "al calor bianco". Ma, a differenza della maggior parte delle stelle, non ha più una sorgente di energia. Può rimanere visibile per un lungo periodo di tempo, comparabile con l'età dell'universo, fintanto che il calore prodotto nella sua creazione non si estingue; alla fine si spegnerà nell'oscurità, diventando invisibile.

Eddington era convinto che questo potesse essere il destino finale di tutte le stelle. Tuttavia, in quel periodo il giovane matematico di origine indiana Subramanyan Chandrasekhar presentò dei calcoli per dimostrare che nessuna nana bianca poteva avere una massa maggiore di 1,4 volte quella del Sole. Le stelle sopra questa massa sembravano avere un destino diverso in serbo per loro: avrebbero continuato a contrarsi oltre il punto in cui la nana bianca aveva trovato stabilità, fino al punto in cui, se la massa della stella fosse stata molto superiore a tre masse solari, il collasso gravitazionale sarebbe proseguito indefinitamente, fino a formare un oggetto sempre più piccolo, circondato da un campo gravitazionale immenso. L’autorità di Eddington fermò per un po’ di tempo la ricerca teorica su questi corpi celesti, che sarebbero stati chiamati buchi neri nel 1967. Un buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso da non lasciare sfuggire né la materia, né la radiazione elettromagnetica, cioè , da un punto di vista relativistico, una regione dello spaziotempo con una curvatura sufficientemente grande che nulla dal suo interno può uscirne, nemmeno la luce, essendo la velocità di fuga superiore a c. Uno spazio chiuso in se stesso, tale da rendere impossibile qualsiasi comunicazione.

"Lettera I" usa la creazione poetica per testare i limiti dell'universo di Einstein, perseguendo una condizione estrema liquidata da Eddington come assurda. Empson non era vincolato né dalla cultura istituzionale dell'astronomia britannica, né dalle leggi della fisica. La sua poesia non prevede rigorosamente un buco nero, ma prende sul serio l'ipotetico estremo astronomico, secondo una tradizione che egli ammirava in Donne e altri: la capacità predittiva delle creazioni letterarie.
Empson si fece un nome al di fuori di Cambridge non tanto attraverso la sua poesia, ma con la sua precoce opera di critica letteraria, Seven Types of Ambiguity, che iniziò come studente universitario nel 1928 e pubblicò nel novembre 1930. Nel saggio definiva l'ambiguità come "qualsiasi sfumatura verbale, per quanto lieve, che dia spazio a reazioni alternative allo stesso pezzo di linguaggio". Abbiamo ambiguità quando "si possono assumere punti di vista alternativi senza un'interpretazione errata". Leggere una poesia significa perciò esplorare i conflitti all'interno dell'autore. Prendendo dalla storia della letteratura inglese una gran numero di brani (anche se non sempre poesie complete), che vanno da Spenser e Shakespeare, tracciò le complessità del comportamento ambiguo del linguaggio poetico attraverso sette fasi di "disordine logico avanzato". Il caso più estremo, il settimo tipo, esprime, o tradisce, una contraddizione totale, per cui "i due significati della parola, i due valori dell'ambiguità, sono i due significati opposti definiti dal loro contesto, per cui l'effetto totale è quello di mostrare una divisione fondamentale nella mente dello scrittore". Empson mirava principalmente a dimostrare, mediante analisi ingegnose e dettagliate, come funziona la "macchina" della poesia.

Dall'agosto 1931 al luglio 1934 fu professore di inglese all'Università di Letteratura e Scienza di Tokyo, dove rimase sconvolto dal nazionalismo in pernicioso sviluppo. Il suo secondo saggio, Some Versions of Pastoral (1935), prese forma in Giappone. La Pastorale pone il "complesso nel semplice" e serve per conciliare l'ordine sociale ricevuto. La non ortodossia dell'approccio di Empson alla pastorale, forma letteraria di soggetto bucolico che allude spesso ad atmosfere idilliache e mitiche, è insita nei testi che scelse di analizzare, che vanno dal Paradiso perduto di Milton alla Alice di Lewis Carroll. Eppure l'idea di ciò che il "campestre" rappresenta in tali testi è il nocciolo della sua tesi, debitrice di quelle dell’antropologo James John Frazer contenute nel Ramo d’oro e Il capro espiatorio e ampliate dallo storico della filosofia cantabrigense Francis Cornford riguardo al totemismo e ai legame di sangue nelle società arcaiche, visti come base non solo delle successive pratiche religiose, ma anche della prima conoscenza scientifica del mondo. Allo stesso tempo insider e outsider, l'eroe quasi divino (esemplare ed eccezionale) della pastorale, portavoce sia dei molti che dell'uno, è il tipo del “Cristo e capro espiatorio'': eroe e antieroe, redentore e vittima, riconciliatore e critico. Assimilando e attenuando così le aree di potenziale e reale conflitto nella società, l'eroe pastorale in ultima analisi rappresenta una segreta libertà dalle dottrine politiche e religiose dominanti. Come sintetizzò l’autore, "la letteratura è un processo sociale, e anche un tentativo di riconciliare i conflitti di un individuo in cui si rispecchiano quelli della società”.

Nel 1937 Empson tornò ad est, per insegnare all’Università Nazionale di Pechino, ma, per sua sfortuna, arrivò al suo posto su un treno di truppe giapponesi: si trovò nel pieno della guerra sino-giapponese. Costretto a fuggire dall'avanzata degli invasori nella diaspora delle università della Cina settentrionale, sopportò due anni di ciò che chiamò “la vita selvaggia e le pulci e le bombe".
Tornato in Inghilterra durante la seconda guerra mondiale, Empson lavorò per la BBC. Dopo essersi trasferito al servizio estero di Londra nel 1941, divenne assistente e poi redattore cinese, organizzando trasmissioni per la Cina e programmi di propaganda per l'Home Service. Alla BBC incontrò l’artista sudafricana Hester Henrietta (Hetta) Crouse [Hester Henrietta Empson], (1915–1996), una donna bella e schietta che lavorava per il servizio in afrikaans. Si sposarono a Londra nel dicembre 1941 e ebbero due figli. Nel 1947 tornò con la sua famiglia all’Università di Pechino, dove si trovò coinvolto nell'assedio comunista della città e fu testimone dell'ingresso trionfante di Mao nel 1949.
Dalla fine degli anni '30 agli anni '40, Empson redasse una serie di saggi critici correlati, raccolti in The Structure of Complex Words (1951), in cui tentò di dimostrare come le parole chiave di un’opera o di una società uniscono emozioni, sensi e persino visioni del mondo. “Approssimativamente", scrisse, "la morale è che una società in via di sviluppo decide le questioni pratiche dal modo in cui interpreta le parole che ritiene ovvie e tradizionali più che dalle dichiarazioni ufficiali del dogma corrente".
Nel 1952 Empson tornò in Inghilterra. Dal 1953 al 1971 tenne la cattedra di letteratura inglese presso l'Università di Sheffield, dove si impegnò energicamente in polemiche pubbliche, spinto dal desiderio di correggere quelle che credeva essere le ortodossie sbagliate della critica letteraria moderna, in particolare l'influenza di ciò che aveva definito "neo-cristianesimo".
Egli acquistò infatti grande fama per la sua visione della malvagità del cristianesimo quando pubblicò Milton's God (Il Dio di Milton) nel 1961. Il problema nel suo approccio, che diede ad alcuni recensori l'opportunità di criticare il libro, risiedeva nel fatto che si confrontava con il Dio cristiano attraverso un'opera dell'immaginazione letteraria, nella ardita supposizione che la visione di Milton di Dio potesse essere identificata con la "verità" del vangelo. Sostenendo che il cristianesimo era moralmente riprovevole, Empson elogiava l'integrità di Milton nel superare il mito in poesia, che era tanto più brillante perché imperturbabile. "Il poema è meraviglioso perché è un terribile avvertimento", scrisse in un testo inedito. "Lo sforzo di riconsiderare il Dio di Milton, che rende la poesia così buona solo perché Egli è così disgustosamente cattivo, è fondamentale per la mente europea."

Empson fu nominato baronetto nel 1979. Morì nella sua casa di Londra il 15 aprile 1984 di cirrosi epatica. Le pubblicazioni postume includono diversi saggi dedicati alla letteratura rinascimentale e a Shakespeare, oltre all’edizione completa delle sue opere poetiche.
Riferimenti principali:
Kitt Price, Empson’s Einstein. Science and modern reading, in The Cambridge Companion to Literature and Science, Cambridge University Press, 2018
John Haffenden, Empson, Sir William, in Oxford Dictionary of National Biography, 2006
Kitt Price, Flame far too hot: William Empson's non-Euclidean predicament, 2005
Art Kavanagh, Finite though unbounded. The abolition of infinity in the poetry of William Empson, 1996