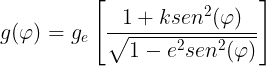Il 23 maggio 1909 Jacques Deprat (1880-1935) lasciò la Francia per Hanoi con la sua giovane famiglia per iniziare la carriera di geologo nel Service Géologique de l'Indochine. Il suo posto era stato vinto contro ogni pronostico. I suoi inizi furono umili, anche se rispettabili, ed era progredito in virtù del duro lavoro. Aveva pubblicato articoli brillanti sulla struttura geologica della Corsica, che alla fine gli era valsa il rispetto di un illustre sponsor, il professor Termier all'Ecole des Mines di Parigi. All'inizio del secolo, la gerarchia accademica in Francia era rigida e dominata dalle classi, e Deprat non sarebbe arrivato da nessuna parte senza un mecenate. Nel servizio coloniale lo snobismo era aggravato; con il giusto ambiente non dovevi fare molto per sopravvivere e prosperare: un'afosa indolenza favoriva gli intrighi sociali e scoraggiava lo sforzo intellettuale.
Visualizzazione post con etichetta geologia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta geologia. Mostra tutti i post
martedì 25 ottobre 2022
Jacques Deprat e i trilobiti boemi in Vietnam
Deprat entrò in questo ambiente con energia illimitata e determinazione a lasciare il segno. Erano i giorni eroici della geologia, quando per la prima volta si decifravano le strutture di remote regioni del mondo; eroico anche in senso letterale, poiché i geologi erano obbligati a scalare vette e scogliere mentre tracciavano le loro stratigrafie. Non era un ostacolo per Deprat, che era un esperto alpinista fin dall'infanzia. Si rallegrava dei pericoli e sembrava esultare nel visitare zone più remote di quelle che erano state raggiunte prima. Il terreno che percorreva in ogni stagione sul campo era prodigioso. I suoi studi ora si trovano nelle parti più polverose delle biblioteche di riferimento, anche se quando furono pubblicati per la prima volta furono accolti dai geologi contemporanei con entusiasmo. Abbastanza rapidamente, Deprat divenne famoso a livello mondiale. Al Congresso geologico mondiale del 1913, si sedette accanto al presidente per la fotografia ufficiale. Era brillante, aveva solo 33 anni, e il mondo era pieno di promesse. Honoré Lantenois, il direttore del Service Géologique de l'Indochine, era ai margini della stessa immagine, "il più lontano possibile dal centro". La fotografia riassume il modo in cui il vecchio ordine cedeva il passo alla nuova meritocrazia. La scienza globale non si curava delle sottigliezze della società francese e cominciava a dare più importanza ai risultati che ai privilegi. È ragionevole supporre che Lantenois fosse amareggiato per la sua eclissi da parte di Deprat: dopotutto, l'uomo più anziano aveva costruito il rilevamento geologico dell'Indocina quasi dal suo inizio.
Il 20 marzo 1917 Lantenois convocò Deprat nel suo ufficio e lo accusò di aver inserito deliberatamente esemplari fossili di origine europea tra quelli che sosteneva di aver raccolto da una remota regione dell'Annam. Si trattava di esemplari di importanza cruciale, poiché fornivano la prova che gli strati più antichi di tutta questa vasta regione risalgono al periodo dell'Ordoviciano, circa 470 milioni di anni fa. I primi tra loro erano fossili di trilobiti: artropodi marini con un'indicazione del tempo assolutamente affidabile. L'accusa di Lantenois si basava sulle prove di Henri Mansuy, paleontologo al servizio geologico di Hanoi, i cui accurati resoconti della paleontologia del Vietnam sono ancora oggi citati. Il suo compito era descrivere e nominare i nuovi fossili che Deprat aveva recuperato dal suo lavoro sul campo e che avevano fornito la base fattuale per gran parte della speculazione geologica su cui era fondata la reputazione di Deprat. Mansuy era stato sorpreso di scoprire che i fossili di Deprat coincidevano esattamente con specie provenienti dalla Boemia. Erano troppo belle per essere vere, e in seguito affermò che non erano vere: Deprat, a quanto pareva, era stato un po' troppo desideroso di dimostrare la sua tesi.
Le accuse iniziali di Lantenois erano moderate; a questo punto sarebbe stato possibile per Deprat effettuare una ritirata tattica. "Ho lavorato così duramente", avrebbe potuto dire. "Un errore, una confusione generata dall'esaurimento". Deprat era sul filo del rasoio tra la confessione dell'errore e la difesa di un'invenzione. Era un uomo intelligente e di talento, e le sue innovazioni geologiche erano abbastanza reali. Probabilmente disprezzava il rigido Lantenois. Forse il riconoscimento mondiale lo aveva reso troppo sicuro di sé. Rispose difendendosi in modo aggressivo: come osavano mettere in dubbio il suo racconto su come e dove erano stati trovati i fossili? Iniziò così il lento processo della disgrazia di Deprat, Una commissione d'inchiesta succedette a un'altra, e man mano che i grandi nomi della Société Géologique de France furono chiamati a giudicare, il self-made man Deprat perse, uno dopo l'altro, gli amici che aveva stretto nel suo cammino dall'oscurità alla fama.
Fu un affare prolungato. Deprat dovette tornare sul campo sotto l'occhio di Lantenois nel tentativo di replicare le sue scoperte, ma fallì. I controversi trilobiti furono inviati in Francia, dove la loro probabile origine nelle rocce della Boemia fu confermata da un'autorità di primo piano. Nel 1918 Deprat aveva cambiato posizione. Era, affermò, Mansuy che aveva sostituito i fossili per rovinarlo e sostituirlo nel servizio. Sembra anche possibile che la spiegazione di Deprat potesse essere vera: non tutti esaminano ogni esemplare nel corso del lavoro sul campo.
La pesante macchina della giustizia francese si fermò. Deprat affermò che Lantenois era in combutta con Mansuy. Lantenois a sua volta divenne più vendicativo, tirando le fila per assicurarsi la caduta del suo fastidioso subordinato. La reputazione di Mansuy fu pubblicamente approvata. Fu solo nel novembre 1920 che Deprat fu infine rimosso dal servizio. Umiliato e rovinato, apparentemente scomparve, e quella avrebbe dovuto essere la fine della vicenda.
Ma è più interessante di così. Nel 1926 fu pubblicato un romanzo intitolato Les Chiens aboient ("I cani abbaiano"), di un certo Herbert Wild. Racconta la vicenda di un giovane e brillante geologo che ha subito le umiliazioni seguite alle accuse di aver sostituito esemplari fossili. I nomi sono stati modificati (l'eroe si chiama Dorpat) ma è evidentemente un resoconto dettagliato dell'affare Deprat. Non sorprende che i dettagli siano stati così riccamente osservati. Perché "Herbert Wild" era in realtà Jacques Deprat, e Les Chiens aboient era il suo tentativo di dare la sua versione degli eventi. "Wild" era un bravo scrittore e forniva un'argomentazione convincente. Né Lantenois né Mansuy avevano presentato obiezioni comparabili. Attraverso Les Chiens possiamo chiaramente immaginare l'indignazione provata da un giovane e talentuoso geologo, e, a seguito delle presunte macchinazioni di Lantenois. Non è strano rilevare la curiosità di una situazione in cui qualcuno bollato come bugiardo scientifico tenta di rivendicare la sua reputazione con un'opera di narrativa scritta sotto pseudonimo. Il romanzo potrebbe anche essere un mezzo per Deprat per giustificare la sua colpa, raccontando la storia con un eroe innocente.
"Herbert Wild" continuò a guadagnarsi da vivere modestamente come scrittore di narrativa. Divenne famoso anche come alpinista e unì le sue nuove vocazioni in romanzi sull'alpinismo. Che fosse colpevole o meno, bisogna ammirare la sua tenacia e ingegno. Ma resta il fatto che Les Chiens aboient è un racconto intrigante e ambiguo. Se Deprat era innocente, allora altri dovevano essere colpevoli: ma perché Mansuy, altrimenti sincero, avrebbe dovuto mentire in questa unica occasione? E se Lantenois era l'ultimo sospettato, perché ha mostrato una vera vendetta solo quando Deprat aveva iniziato a lanciare accuse? L'unica verità a cui ora abbiamo accesso risiede negli esemplari fossili e alcuni dei controversi trilobiti sono sopravvissuti, essendo stati originariamente inviati in Francia al culmine dello scandalo. Alcuni anni fa furono esaminati dall’esperto di trilobiti Jean-Louis Henry, il quale era dell'opinione che provenissero davvero dalla Boemia e non dal Vietnam. Dalle prove scientifiche, sembrerebbe che Deprat stesse mentendo, tutto il resto è congettura.
venerdì 4 febbraio 2022
Isostasia, quando le rocce galleggiano
L’isostasia ė l’equilibrio teorico ideale di tutte le grandi porzioni della litosfera terrestre, come se galleggiassero sullo strato sottostante più denso, la astenosfera, una sezione del mantello superiore composta da roccia più fluida, che si trova a circa 110 km sotto la superficie. L'isostasia controlla le elevazioni regionali dei continenti e dei fondali oceanici in accordo con la densità delle loro rocce sottostanti. Si presume che colonne immaginarie di uguale area di base che salgono dall'astenosfera alla superficie abbiano pesi uguali ovunque sulla Terra, anche se i loro costituenti e le elevazioni delle loro superfici superiori sono significativamente diversi. Ciò significa che un eccesso di massa visto al di sopra del livello del mare, come accade in un sistema montuoso, è dovuto a un deficit di massa, o radici a bassa densità, al di sotto del livello del mare. Pertanto, le alte montagne hanno radici a bassa densità che si estendono in profondità nel mantello sottostante. Il concetto di isostasia ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della teoria della tettonica a zolle.
Circa un secolo dopo, simili discrepanze furono osservate da Sir George Everest, geometra generale dell'India, nelle indagini a sud dell'Himalaya, indicando una mancanza di massa compensativa al di sotto delle catene montuose. Anche Everest si aspettava che la massa gravitazionale dell'Himalaya avrebbe causato deviazioni nei fili a piombo, ma osservò che essi non erano deviati verso le montagne quanto ci si poteva aspettare. In effetti la differenza avrebbe dovuto essere maggiore.
Il primo tentativo di spiegazione del fenomeno tentò di darla nel 1855 il matematico inglese e missionario anglicano in India John Henry Pratt (1809-1871), che postulò differenze di densità nella crosta terrestre, densità più basse sotto le montagne, densità più elevate in pianura, per spiegare i valori (quasi costanti) ottenuti per la gravità a una data latitudine. L'ipotesi di Pratt presupponeva che la crosta terrestre avesse uno spessore uniforme sotto il livello del mare, con una base che a una determinata profondità regge un peso uguale per unità di area. In sostanza, la sua teoria sosteneva che le aree della Terra di densità minore, come le catene montuose, sporgono più in alto sul livello del mare rispetto a quelle di densità maggiore. La spiegazione di ciò era che le montagne risultavano dall'espansione verso l'alto di materiale crostale riscaldato localmente, che aveva un volume maggiore ma una densità inferiore dopo essersi raffreddato.
Sir George Biddell Airy (1801-1892), matematico e astronomo inglese, a lungo Astronomo Reale, nello stesso anno ipotizzava invece che la crosta avesse una densità uniforme dappertutto. Lo spessore dello strato crostale non è però uniforme, e quindi la sua teoria ipotizzava che le parti più spesse della crosta affondassero più in profondità nel substrato, mentre le parti più sottili ne fossero sostenute. Secondo questa ipotesi, le montagne hanno radici sotto la superficie che sono molto più grandi della loro espressione superficiale.
Entrambe le teorie si basano sulla presunta esistenza di uno strato fluido o plastico più denso, l’astenosfera, su cui galleggia la litosfera rocciosa. A metà del XX secolo, con l'analisi dei terremoti, è stato verificato che essa è presente ovunque sulla Terra: le onde sismiche, la cui velocità diminuisce con la fluidità del mezzo, passano più lentamente attraverso di essa. Sia le proposte di Pratt che quelle di Airy hanno storicamente avuto i loro pregi, ma sono semplificazioni eccessive della situazione reale.
Ancora non esisteva il termine isostasia (gr. ἴσος "uguale", στάσις "posizione"), che fu coniato dal geologo americano Clarence Dutton (1841-1912), che in una nota a piè di pagina di una recensione del 1882 sull'American Journal of Science, scrisse:
"In un articolo inedito ho usato i termini isostatico e isostacia (sic) per esprimere quella condizione della superficie terrestre che deriverebbe dal galleggiamento della crosta su un substrato liquido o altamente plastico - porzioni diverse della crosta essendo di densità disuguale".
Dutton illustrò queste idee nel suo discorso alla Philosophical Society di Washington nel 1889. Quando questo fu stampato nel 1892 fu proposto formalmente il termine isostasia, dopo che Dutton, su consiglio dei grecisti, corresse la "c" in una "s".
Una volta accettato il concetto di isostasia, si voleva stabilire a quale profondità si trova la superficie sulla quale “galleggiano” i blocchi di crosta terrestre. Agli inizi del Novecento la ricerca della “profondità di compensazione” fu una sfida intrapresa dai geologi americani John Fillmore Hayford (1868-1925) e William Bowie (1872-1940) dell’US Coast and Geodetic Survey.
La teoria di Hayford ipotizza che ci debba essere una distribuzione compensativa di materiali rocciosi di densità variabile in modo che la crosta terrestre eserciti una pressione essenzialmente uniforme a una certa profondità all'interno della Terra. Da studi sulle anomalie gravitazionali in vari luoghi, Hayford stimò che la profondità della compensazione isostatica variasse da 60 a 122 km (da 37 a 76 miglia) e da ciò dedusse la figura geometrica della Terra, che fu adottata nel 1924 come Ellissoide Internazionale dalla International Geodetic and Geophysical Union.
Bowie coordinò osservazioni sistematiche delle anomalie gravitazionali sulla terraferma e incoraggiò indagini gravitazionali negli oceani. Queste osservazioni mostrarono che le anomalie erano correlate con le caratteristiche topografiche e convalidarono l'isostasia come fenomeno geologico. Con Hayford calcolò le tabelle della profondità della compensazione isostatica, considerandola in media pari a 113 km (70 miglia). Il suo libro Isostasy fu pubblicato nel 1927.
A causa dei cambiamenti degli ambienti tettonici, tuttavia, l'isostasia perfetta viene raramente raggiunta e alcune regioni, come le fosse oceaniche e gli altipiani, non sono compensate isostaticamente. L'equilibrio isostatico è uno stato ideale in cui la crosta e il mantello si stabilizzerebbero in assenza di forze di disturbo. L'aumento e lo scioglimento delle calotte glaciali, l'erosione, la sedimentazione e il vulcanismo effusivo sono esempi di processi che perturbano l'isostasia. Le proprietà fisiche della litosfera (il guscio roccioso che forma l'esterno della Terra) sono influenzate dal modo in cui il mantello e la crosta rispondono a queste perturbazioni. Pertanto, la comprensione della dinamica dell'isostasia aiuta a capire fenomeni più complessi come la formazione di montagne e bacini sedimentari, la disgregazione dei continenti e la formazione di nuovi bacini oceanici.
Misure di gravità - Poiché l'isostasia prevede carenze di massa nelle regioni più elevate, un modo per testare l'isostasia su scala planetaria è misurare la variazione del campo gravitazionale locale. Un semplice pendolo può essere utilizzato per misurare la forza di gravità locale: in effetti, fu così che furono eseguite le prime misurazioni della gravità. Al giorno d'oggi, la geodesia fisica, lo studio delle proprietà fisiche del campo gravitazionale terrestre, utilizza i gravimetri relativi e assoluti per le indagini gravitazionali. I moderni gravimetri assoluti sono interferometri ottici a laser che misurano in un punto l’accelerazione di una massa in caduta libera nel vuoto. L’unità di misura solitamente utilizzata per le misurazioni è il milligal (mGal), che vale 10-5 m/s2. La precisione di questi strumenti è dell’ordine del microgal, cioè 1 x 10-8 m/s2. I gravimetri relativi, che misurano la differenza di gravità esistente fra due punti, utilizzano principalmente molle al quarzo a lunghezza zero e sono calibrati sui gravimetri assoluti.
A causa della rotazione, la Terra è più schiacciata ai poli e sporge all'equatore, formando all'incirca un ellissoide; quindi, al livello del mare il valore della gravità dipende dalla latitudine ed è inferiore alle latitudini vicine all'equatore che alle latitudini vicine ai poli. Questo valore di gravità in un punto particolare dell'ellissoide è chiamato valore teorico per quel punto.
Varie formule, successivamente più raffinate, per il calcolo della gravità teorica sono indicate come International Gravity Formula, la prima delle quali fu proposta nel 1930 dall'International Association of Geodesy. Una formula teorica più recente per la gravità in funzione della latitudine è la International Gravity Formula 1980 (IGF80), basata sull'ellissoide standard di riferimento WGS80, che utilizza l'equazione di Somigliana (dal nome del fisico matematico italiano Carlo Somigliana, 1860-1955, che la propose nel 1929):
g(φ) è la gravità in funzione della latitudine geografica φ della posizione di cui si vuole determinare la gravità;
k è una costante di formula;
ge, è la gravità all'equatore;
a, b sono rispettivamente i semiassi equatoriali e polari dello sferoide;
e2 = (a2-b2) / a2 è l’eccentricità quadrata dello sferoide;
da cui:
Sottraendo il valore teorico della gravità g(φ) dal valore osservato della gravità g’ in un punto, si ottiene una differenza chiamata anomalia gravitazionale. Dopo aver corretto con varie tecniche sia la quota che l'attrazione gravitazionale delle rocce tra lo strumento e l'ellissoide, il valore misurato della gravità meno il valore teorico viene detto anomalia di gravità di Bouguer.
Poiché il valore teorico viene determinato ipotizzando che la densità sia omogeneamente distribuita al di sotto della superficie terrestre secondo involucri concentrici, se risulta che il valore misurato g’ è maggiore di quello teorico g(φ) (anomalia gravimetrica positiva) vuol dire che la densità delle rocce nel sottosuolo in quel punto è maggiore di quanto previsto teoricamente. Se, al contrario, si registra che il valore misurato è minore di quello teorico (anomalia gravimetrica negativa), si conclude che nel sottosuolo si trovano masse rocciose più leggere di quelle previste teoricamente. Questo tipo di ricerche è utilizzato a livello locale nel campo della prospezione mineraria.
Le misurazioni del campo gravitazionale terrestre indicano che le anomalie gravitazionali di Bouguer sono generalmente molto negative sulle montagne e altipiani e nulle o positive sugli oceani. La gravità è infatti più debole su gran parte delle Alpi, dell'Himalaya e di molte altre catene montuose. Le anomalie tipiche delle Alpi centrali sono dell'ordine di −150 milligal. Nelle regioni che hanno avuto il tempo di raggiungere l'equilibrio isostatico senza essere disturbate da altri effetti geologici, come il sud-ovest degli Stati Uniti, esiste un'ottima correlazione tra la quota e le anomalie gravitazionali di Bouguer, fornendo prove convincenti per l'isostasia.
Le leggi dell’isostasia agiscono sui continenti proprio come farebbero sugli iceberg e sulle zattere. Un iceberg si alzerà più fuori dall'acqua quando la parte superiore si scioglie e una zattera affonda più in profondità quando vengono aggiunti carichi. Tuttavia, il tempo di adattamento per i continenti è molto più lento, a causa della viscosità dell'astenosfera. Ciò si traduce in molti processi geologici dinamici che si osservano oggi. L’esempio più noto è dato dall’isostasia glaciale.
Isostasia glaciale - L'isostasia glaciale è il processo mediante il quale la litosfera terrestre viene pressata dal peso di una calotta glaciale. Quando la massa di ghiaccio viene successivamente ridotta o rimossa e il peso viene tolto, ciò consente alla crosta di risalire e tornare alla sua posizione originale. La quantità di depressione crostale risultante del carico della calotta glaciale è una funzione dello spessore del ghiaccio e del rapporto tra la densità del ghiaccio e della roccia. La densità del ghiaccio è circa un terzo di quella della crosta, e quindi la depressione crostale sotto una calotta glaciale è circa un terzo dello spessore del ghiaccio. Una calotta di ghiaccio di mille metri di spessore ha la capacità di abbassare il terreno sottostante di 275 m. Normalmente, la quantità di depressione crostale aumenta dal margine verso il centro della calotta glaciale, dove nella maggior parte dei casi le calotte glaciali sono più spesse. Attualmente, in Antartide, il peso della calotta glaciale è così elevato che ha abbassato il continente di 1 km nella crosta terrestre. Se queste masse di ghiaccio dovessero sciogliersi, anche la terra sottostante subirebbe un rimbalzo isostatico.
Occorrono diverse migliaia di anni prima che avvenga l'adeguamento isostatico perché c'è un intervallo di tempo tra la ritirata del ghiacciaio e la risposta della crosta terrestre. Quando una calotta glaciale inizia a ridursi, sollevando il peso dalla massa continentale depressa, inizia il processo di rimbalzo, iniziando rapidamente, per poi rallentare.
Ci sono prove del rimbalzo isostatico nel passato. Nel Mar Baltico e nell'area della Baia di Hudson vicino al Canada, che erano entrambi ricoperti da una calotta glaciale 14mila anni fa, esistono oggi antiche linee di spiaggia a circa 300 m sotto il livello del mare. Gli scienziati della NASA e del Servizio Geologico americano ritengono che quest'area stia ancora attivamente risalendo, ma a un ritmo molto più lento rispetto a poco dopo l'ultima era glaciale. Affinché la Baia di Hudson raggiunga il suo stato di "equilibrio", i geologi calcolano che debba ancora risalire di circa 150 m. Il sottosuolo del Mar Baltico settentrionale (Golfo di Botnia) sale di circa 1 cm all’anno.
Per quanto riguarda il riscaldamento globale, l'isostasia glaciale entra in gioco quando si calcola l'innalzamento del livello del mare per lo scioglimento delle calotte glaciali e per l'espansione termica dell'acqua. In alcuni casi, l'isostasia può compensare alcuni degli effetti dell'innalzamento del livello del mare. Il problema, tuttavia, è che l'isostasia progredisce più lentamente dell'innalzamento del livello del mare, per cui la compensazione degli effetti negativi sarebbe minima.
Nel periodo dell'ultimo massimo glaciale, il volume delle calotte glaciali ha prodotto un abbassamento del livello del mare di circa 120-130 m. Al contrario, lo scioglimento delle calotte glaciali della Groenlandia e dell'Antartico causerebbe un innalzamento del livello del mare rispettivamente di 5,5 e 60 m (innalzamento globale medio del livello del mare di circa 70 m: vedi in figura la proiezione per l’Europa). Non sarebbe un bell'affare per le aree costiere, dove vive circa il 40% della popolazione mondiale.
martedì 1 febbraio 2022
La datazione assoluta delle rocce
Sebbene le età relative degli strati rocciosi possano essere generalmente stabilite su scala locale sulla base dei criteri paleontologici e stratigrafici, gli eventi registrati in rocce di luoghi diversi possono essere integrati in un'immagine di scala regionale o globale solo se la loro sequenza temporale è saldamente stabilita. Il tempo trascorso dalla formazione di alcuni minerali può essere determinato a causa della presenza di una piccola quantità di atomi radioattivi naturali nelle loro strutture. Mentre gli studi sulla datazione dei fossili sono iniziati quasi 300 anni fa, la radioattività è stata scoperta solo nel 1896 dal Henri Becquerel, è stata studiata intensamente nei primi decenni del secolo, ma è stato solo dal 1950 circa che i metodi per datare i materiali geologici sono diventati comuni. I metodi di misurazione isotopica continuano ad essere perfezionati e la datazione assoluta è diventata una componente essenziale di praticamente tutte le indagini geologiche.
Diversi processi della Terra creano rocce diverse come parte di quello che può essere considerato il ciclo litogenetico di formazione e trasformazione delle rocce. L'attenzione è rivolta, ove possibile, su quelle rocce che contengono minerali adatti a precise datazioni isotopiche. È importante ricordare che le età precise non possono essere ottenute per una qualsiasi unità rocciosa, ma che qualsiasi unità può essere datata rispetto a un'unità databile.
La datazione radiometrica è l'unica tecnica in grado di fornire età assolute delle rocce attraverso la documentazione stratigrafica, ma è limitata nell'applicazione dai tipi di rocce che possono essere datate. L'età di formazione dei minerali è determinata da questo metodo; quindi, se i grani di feldspato di potassio in un'arenaria sono datati radiometricamente, la data ottenuta è quella del granito da cui sono stati erosi. Non è quindi possibile datare la formazione di rocce costituite da granuli detritici e ciò esclude la maggior parte delle arenarie, delle argille e dei conglomerati. I calcari sono formati in gran parte da resti di organismi con parti dure di carbonato di calcio, e i minerali aragonite e calcite non possono essere datati radiometricamente su una scala temporale geologica. Quindi quasi tutte le rocce sedimentarie sono escluse da questo metodo di datazione e correlazione.
La formazione di rocce ignee di solito può essere datata con successo a condizione che non siano state gravemente alterate o metamorfosate. I corpi intrusivi e i prodotti dell'attività vulcanica (lave e tufi) possono essere datati e queste date sono utilizzate per vincolare l'età delle rocce circostanti alle leggi delle correlazioni stratigrafiche. I dati delle rocce metamorfiche possono fornire l'età del metamorfismo, sebbene possano sorgere complicazioni se il grado di metamorfismo non è stato sufficientemente alto da ripristinare l'"orologio" radiometrico o se ci sono state più fasi di metamorfismo.
Le relazioni stratigrafiche generali e le età isotopiche sono i principali mezzi per correlare i corpi ignei intrusivi. È possibile dimostrare che unità di roccia ignea geograficamente separate fanno parte della stessa serie o complesso igneo determinando le età isotopiche delle rocce in ciascuna località. La datazione radiometrica può anche essere molto utile per dimostrare la corrispondenza tra corpi ignei effusivi. I principali inconvenienti di correlazione con questo metodo sono la gamma limitata di litologie databili e problemi di precisione dei risultati, in particolare con rocce più antiche. Ad esempio, se si sono formati due letti di lava distanti solo un milione di anni e c'è un margine di errore nei metodi di datazione di un milione di anni, la correlazione di un letto di lava simile all'uno o all'altro non può essere certa.
Tutte le età assolute si basano sul decadimento radioattivo, un processo mediante il quale gli isotopi di determinati atomi (“genitori”) sono instabili ed emettono energia (raggi β o γ) e/o particelle α (nuclei di elio: due protoni e due neutroni), trasformandosi in altri isotopi (”figli”) a una velocità costante e nota. Il decadimento radioattivo di un isotopo genitore può portare alla produzione di un altro isotopo instabile, e così via, fino a che si produce un isotopo stabile e non si riscontra più alcuna attività radioattiva. Ad esempio, la catena di decadimento dell’uranio-238 e dei suoi figli porta alla fine all’isotopo stabile piombo-206. Ogni anello della catena segna un calo del numero di massa. Poiché gli isotopi differiscono in massa, la loro abbondanza relativa può essere determinata se le masse sono separate in uno spettrometro di massa che consente l'identificazione di atomi figli formati dal processo di decadimento in un campione contenente atomi progenitori radioattivi.
Le particelle emesse durante il processo di decadimento rivelano un profondo cambiamento nel nucleo. Per compensare la perdita di massa (ed energia), l'atomo radioattivo subisce una trasformazione interna e nella maggior parte dei casi diventa semplicemente un atomo di un diverso elemento chimico. In termini di numero di atomi presenti, è come se le mele si trasformassero spontaneamente in arance a un ritmo fisso e noto. In questa analogia, le mele rappresenterebbero atomi radioattivi, o genitori, mentre le arance rappresenterebbero gli atomi formati, i cosiddetti figli. Proseguendo ulteriormente con questa analogia, ci si aspetterebbe che un cesto nuovo di mele non contenga arance ma che uno più vecchio ne abbia molte. In effetti, ci si aspetta che il rapporto tra arance e mele cambi in modo molto specifico nel tempo trascorso, poiché il processo continua fino a quando tutte le mele non vengono convertite. In geocronologia la situazione è identica. Una particolare roccia o minerale che contiene un isotopo radioattivo (o radioisotopo) viene analizzata per determinare il numero di isotopi genitori e figli presenti, per cui viene calcolato il tempo trascorso dalla formazione di quel minerale o roccia. Naturalmente, è necessario selezionare materiali geologici che contengano elementi con lunghi tempi di trasformazione, cioè quelli per i quali rimangono alcuni atomi progenitori.
Fortunatamente per la geocronologia, lo studio della radioattività è stato oggetto di approfondite ricerche teoriche e di laboratorio da parte dei fisici per quasi un secolo. I risultati mostrano che non esiste un processo noto che possa alterare il tasso di decadimento radioattivo. Come spiegazione si può dire che, poiché la causa del processo risiede in profondità all'interno del nucleo atomico, le forze esterne come il calore e la pressione estremi non hanno alcun effetto. Lo stesso vale per i campi gravitazionali, magnetici ed elettrici, nonché per lo stato chimico in cui si trova l'atomo. In breve, il processo di decadimento radioattivo è immutabile in tutte le condizioni conosciute.
In base ai principi della meccanica quantistica, il decadimento spontaneo di un nucleo è un avvenimento puramente casuale. Tuttavia, se è vero che risulta impossibile determinare l'istante in cui il nucleo di un atomo si disintegrerà, è pur sempre possibile predire la probabilità che ha un certo numero di nuclei di disintegrarsi in un certo intervallo di tempo, esattamente come non si può predire quando un certo individuo morirà, ma si può stabilire la probabilità che egli, con i suoi coetanei, ha di vivere fino ad una certa età.
Dato un numero sufficientemente grande di atomi, la velocità del loro decadimento risulta essere costante. Il riconoscimento che il tasso di decadimento di qualsiasi atomo genitore radioattivo R è proporzionale al numero di atomi (N) del genitore rimanenti in qualsiasi momento dà origine alla seguente espressione:
La conversione di questa proporzione in un'equazione tiene conto dell'osservazione aggiuntiva che radioisotopi diversi hanno tassi di disintegrazione diversi anche quando si osserva lo stesso numero di atomi in decadimento. In altre parole, ogni radioisotopo ha la sua costante di decadimento, abbreviata λ (dimensionalmente è una frequenza, quindi t-1), che fornisce una misura della sua rapidità intrinseca di decadimento. La proporzione (1) diventa:
Detto a parole, questa equazione dice che la velocità con cui un certo radioisotopo si disintegra non dipende solo da quanti atomi dell'isotopo sono presenti, ma anche da una proprietà intrinseca dell’'isotopo, rappresentata da λ, cioè la costante di decadimento.
Nel calcolo, il tasso di decadimento R dell'equazione (2) può essere scritto come la derivata dN/dt, in cui dN rappresenta il piccolo numero di atomi che decadono in un intervallo di tempo infinitamente breve dt. Sostituendo R con il suo equivalente dN/dt si ottiene l'equazione differenziale:
La soluzione di questa equazione fornisce una forma dell'equazione fondamentale per la determinazione dell'età radiometrica,
dove N0 è il numero di atomi radioattivi presenti in un campione al tempo zero, N è il numero di atomi radioattivi presenti oggi nel campione, e è la base dei logaritmi naturali, λ è la costante di decadimento del radioisotopo considerato e t è il tempo trascorso dal tempo zero. Questa legge dice che il numero di nuclei non ancora disintegratisi decresce esponenzialmente nel tempo. L'andamento di tale curva è il seguente:
In genere vengono apportate due modifiche all'equazione (4) per ottenere la forma più utile per la datazione radiometrica. In primo luogo, poiché il termine sconosciuto nella datazione radiometrica è ovviamente t, è desiderabile riordinare l'equazione (4) in modo che sia risolta esplicitamente per t. In secondo luogo, il modo più comune per esprimere il tasso di decadimento intrinseco di un radioisotopo è attraverso la sua emivita o tempo di dimezzamento (t1/2), piuttosto che attraverso la costante di decadimento λ.
L'emivita, o tempo di dimezzamento, è definita in termini di probabilità: essa è il tempo necessario affinché esattamente la metà del numero iniziale di atomi radioattivi in media decada. In altre parole, la probabilità che un atomo radioattivo decada entro la sua emivita è del 50%. Si noti che dopo un'emivita non rimane esattamente la metà degli atomi, solo approssimativamente, a causa della variazione casuale nel processo. Tuttavia, quando ci sono molti atomi identici in decadimento, la legge dei grandi numeri suggerisce che è un'ottima approssimazione dire che metà degli atomi rimangono dopo un'emivita. I tempi di dimezzamento sono stati determinati in laboratorio per migliaia di radioisotopi (o radionuclidi). Questi variano da minime frazioni di secondo (decadimenti pressoché istantanei) fino a 1019 anni o più.
L'emivita t1/2 e la costante di decadimento λ sono inversamente proporzionali perché i radioisotopi in rapido decadimento hanno un'elevata costante di decadimento ma una breve emivita. Con t esplicitato e l'emivita introdotta, l'equazione (4) viene convertita nella forma seguente, in cui i simboli hanno lo stesso significato:
In alternativa, poiché si osserva direttamente il numero di atomi figli anziché N, che è il numero iniziale di atomi progenitori presenti, un'altra formulazione può essere più conveniente. Poiché il numero iniziale di atomi genitori presenti al tempo zero N0 deve essere la somma degli atomi genitori rimanenti N e degli atomi figli presenti D, si può scrivere:
Dalla equazione (4) sopra, segue che N0 = N(eλt). Sostituendo questo valore nell'equazione (6) si ottiene:
Se si sceglie di usare P per designare l'atomo genitore, l'espressione assume la sua forma familiare:
Questa coppia di equazioni afferma rigorosamente ciò che si potrebbe presumere dall'intuizione, cioè che i minerali formati in tempi successivamente più lunghi in passato avrebbero rapporti figlio-genitore progressivamente più alti. Ciò segue perché, poiché ogni atomo genitore perde la sua identità con il tempo, riappare come un atomo figlio. L'aumento di D/P con il tempo è evidente nell'equazione (7) perché valori di tempo maggiori aumenteranno il valore di eλt, dove λ è costante. L'equazione (8) documenta la semplicità concettuale della datazione isotopica diretta. Il tempo di decadimento è proporzionale al logaritmo naturale (rappresentato da ln) del rapporto tra D e P. In breve, basta misurare il rapporto tra il numero di atomi radioattivi genitore e figlio presenti e può essere calcolato il tempo trascorso dalla formazione del minerale o della roccia, a condizione ovviamente che sia noto il tasso di decadimento. Allo stesso modo, le condizioni che devono essere soddisfatte per rendere il calcolo dell'età preciso e significativo sono di per sé semplici:
1. La roccia o il minerale intesi come sistema devono essere rimasti chiusi rispetto all'aggiunta o alla fuga di atomi genitori e figli dal momento in cui si è formata la roccia o il minerale. Ad esempio, il campione da esaminare deve essere sempre al di sotto della cosiddetta temperatura di blocco, specifica per ogni materiale e che può essere trovata sperimentalmente. Al di sotto di questa temperatura il sistema si può considerare isolato.
2. Deve essere possibile tenere conto di altri atomi identici agli atomi figli già presenti al momento della formazione della roccia o del minerale;
3. La costante di decadimento deve essere nota;
4. La misurazione del rapporto figlio-genitore deve essere accurata, perché l'incertezza in questo rapporto contribuisce direttamente all'incertezza nell'età.
Il processo di formazione di un materiale specifico determina il modo in cui un elemento è incorporato durante la formazione. Nel caso ideale, il materiale incorpora un isotopo genitore e rilascia un isotopo figlio; solo l'isotopo figlio trovato esaminando un campione di materiale deve dunque essersi formato da quando esiste il campione.
Quando un materiale incorpora sia i radionuclidi genitori sia i figli nel momento della sua formazione, bisogna assumere che l'iniziale rapporto tra una sostanza radioattiva e i suoi prodotti di decadimento sia conosciuto. Per essere trovati, questi prodotti devono possedere una vita media abbastanza lunga per essere rilevati in sufficienti quantità. Inoltre, non devono intervenire ulteriori processi che possono modificare il rapporto tra nuclidi iniziali e elementi prodotti dal decadimento. Le procedure atte a isolare ed analizzare i prodotti della reazione devono dunque essere semplici ma attendibili.
I campioni di roccia raccolti per la datazione radiometrica sono generalmente abbastanza grandi (diversi chilogrammi), per eliminare le disomogeneità nella roccia. I campioni vengono frantumati in granuli delle dimensioni della sabbia, mescolati accuratamente per omogeneizzare il materiale, poi si seleziona un campione più piccolo. Nei casi in cui si debbano datare particolari minerali, questi vengono separati dagli altri minerali utilizzando liquidi pesanti (liquidi con densità simile a quella dei minerali) in cui alcuni minerali galleggiano e altri affondano, o la separazione magnetica, sfruttando le diverse proprietà magnetiche dei minerali. Il concentrato minerale può quindi essere sciolto per l'analisi isotopica. La misurazione delle concentrazioni di diversi isotopi viene effettuata con gli spettrometri di massa. In questi strumenti una piccola quantità (microgrammi) del campione viene riscaldata nel vuoto per ionizzare gli isotopi e queste particelle cariche vengono quindi accelerate lungo un tubo a vuoto da una differenza di potenziale. A metà del tubo un campo magnetico indotto da un elettromagnete devia le particelle cariche. La quantità di deflessione dipenderà dalla massa atomica delle particelle; quindi, diversi isotopi sono separati dalle loro diverse masse. I rivelatori all'estremità del tubo registrano il numero di particelle cariche di una particolare massa atomica e forniscono un rapporto degli isotopi presenti nel campione.
Benché la datazione radiometrica sia accurata per principio, la sua precisione dipende dalla cura con cui il procedimento si svolge: bisogna considerare i possibili errori dovuti alla contaminazione degli isotopi genitori e figli nel momento in cui il campione da analizzare si è formato; inoltre, utilizzando uno spettrometro di massa per le misure, si può andare incontro ad interferenze da parte di altri nuclidi con stesso numero di massa degli isotopi. In questo caso si devono apportare delle correzioni alle misure considerando i rapporti con cui si presentano questi nuclidi rispetto agli isotopi cercati.
Le misure ottenute attraverso gli spettrometri di massa possono andare incontro a interferenze e a inaccuratezze. L'affidabilità aumenta se le misurazioni sono prese da differenti campioni dello stesso materiale; in alternativa, se differenti minerali dello stesso campione possono essere datati e si assume che si siano formati nella stessa occasione, essi costituiscono una datazione isocrona del campione: a differenza delle più semplici tecniche di datazione radiometrica, la datazione isocrona non richiede la conoscenza delle proporzioni iniziali dei nuclidi.
Infine, per confermare l'età di un campione si potrebbero richiedere differenti metodi di datazioni radiometriche. La precisione di un metodo di datazione dipende comunque dal tempo di dimezzamento dell'isotopo radioattivo utilizzato per la misura.
Sono stati sviluppati diversi protocolli per affrontare le ipotesi critiche indicate. Nella datazione con l’uranio-piombo, è possibile isolare minerali praticamente privi di piombo iniziale e apportare correzioni per le quantità insignificanti presenti. Nei metodi che utilizzano gli schemi di decadimento del rubidio-stronzio o del samario-neodimio, vengono scelte una serie di rocce o minerali che si presume abbiano la stessa età e percentuali identiche dei loro rapporti isotopici iniziali. I risultati vengono quindi testati per la coerenza interna che può convalidare le ipotesi. In ogni caso, è obbligo dello sperimentatore che effettua le determinazioni includere prove sufficienti per indicare che l'età assoluta ottenuta è valida entro i limiti indicati. In altre parole, è dovere dei geocronologi cercare di valutare il margine di errore includendo una serie di controlli incrociati nelle loro misurazioni prima di pubblicare un risultato. Tali controlli includono la datazione di una serie di unità antiche con età relative ravvicinate ma note e l'analisi replicata di parti diverse dello stesso corpo roccioso con campioni raccolti in località ampiamente distanziate.
L'importanza dei controlli interni e del lavoro di squadra diventa tanto più evidente quando ci si rende conto che i laboratori di geocronologia sono in numero limitato. A causa delle costose attrezzature necessarie e della combinazione di competenze geologiche, chimiche e di laboratorio richieste, essa viene solitamente eseguita da squadre di esperti. La maggior parte dei geologi deve fare affidamento sui geocronologi per i loro risultati. A sua volta, il geocronologo si affida al geologo per l’indicazione delle età relative.
I principali metodi radiometrici utilizzati per la datazione assoluta delle rocce sono i seguenti:
Metodo uranio-piombo - Ideato da B. B. Boltwood nel 1907, quello dell'uranio-piombo è uno dei metodi di datazione più antichi e più utilizzati, efficace nel datare rocce che si sono formate e cristallizzate da un milione a oltre 4,5 miliardi di anni fa, con una precisione nell'ordine dello 0,1-1%. Benché possa essere usato per diversi materiali, questo metodo di datazione è solitamente utilizzato sul minerale zircone (ZrSiO4). Lo zircone incorpora gli atomi di uranio e di torio nella sua struttura cristallina, sostituendoli allo zirconio, respingendo invece quelli di piombo. Si può quindi ritenere che tutto il piombo riscontrato in un dato cristallo di zircone sia radiogenico, cioè sia stato interamente prodotto da un processo di decadimento radioattivo verificatosi dopo la formazione del minerale. In questo modo, si può utilizzare il rapporto tra piombo e uranio presente nel minerale per determinare l'età di quest'ultimo. Il fatto che lo zircone sia piuttosto inerte dal punto di vista chimico e che sia anche piuttosto resistente agli agenti atmosferici fa sì che intere zone, se non addirittura interi cristalli, di questo minerale possano sopravvivere all'eventuale erosione o distruzione della roccia di cui fanno parte mantenendo intatto il loro originario contenuto di uranio e piombo.
Il metodo si basa su due diverse catene di decadimento, la serie dell'uranio dall' 238U al 2o6Pb, con un periodo di dimezzamento di circa 4,5 miliardi di anni, e la serie dell'attinio dall' 235U al 207Pb, con un periodo di dimezzamento di circa 710 milioni di anni.
L'esistenza di due catene di decadimento uranio-piombo parallele fa sì che esistano anche diverse tecniche di datazione basate sul sistema U-Pb, tuttavia, con l'espressione "metodo di datazione uranio-piombo" ci si riferisce al metodo in cui si analizzano entrambi gli schemi di decadimento nella realizzazione del cosiddetto "diagramma di concordanza".
Talvolta le età possono anche essere determinate dal sistema uranio-piombo attraverso la sola analisi dei rapporti tra isotopi di piombo, in quello che viene chiamato "metodo di datazione piombo-piombo". Quest'ultimo trova maggior utilizzo, rispetto al metodo all'uranio-piombo, in alcune situazioni particolari, come il calcolo dell'età di meteoriti o dell'età della Terra. Proprio una delle prime stime moderne sull'età del nostro pianeta (4,5 miliardi di anni) fu eseguita nel 1956 utilizzando il metodo di datazione piombo-piombo dal grande geochimico statunitense Clair Cameron Patterson (1922-1995), pioniere della tecnica di datazione uranio-piombo e alfiere della campagna per la riduzione del piombo nell’ambiente.
Metodo Potassio-Argon - Questo è il sistema più utilizzato per la datazione radiometrica degli strati sedimentari, perché può essere utilizzato per datare la mica verde glauconite, ricca di potassio, e le rocce vulcaniche (lave e tufi) che contengono potassio in minerali come alcuni feldspati e miche. Uno degli isotopi del potassio, 40K, decade in parte per cattura di elettroni (un protone diventa un neutrone) in un isotopo dell'elemento gassoso argon, 40Ar, l'altro prodotto è un isotopo del calcio, 40Ca. L'emivita di questo decadimento è di 11,93 miliardi di anni. Il potassio è un elemento molto comune nella crosta terrestre e la sua concentrazione nelle rocce è facilmente misurabile. Tuttavia, la proporzione di potassio presente come 40K è molto piccola (0,012%) e la maggior parte di questo decade in 40Ca, con solo l'11% che forma 40Ar. L'argon è un gas raro inerte e gli isotopi di quantità molto piccole di argon possono essere misurati da uno spettrometro di massa espellendo il gas dai minerali. La datazione K-Ar è stata quindi ampiamente utilizzata nella datazione delle rocce, ma esiste un problema significativo, il fatto che l'isotopo figlio può fuoriuscire dalla roccia per diffusione perché è un gas. La quantità di argon misurata è quindi spesso inferiore alla quantità totale prodotta dal decadimento radioattivo del potassio. Ciò si traduce in una sottostima dell'età della roccia.
Metodo Argon-Argon - I problemi della perdita di argon possono essere superati utilizzando il metodo argon-argon. Il primo passo in questa tecnica è l'irradiazione del campione mediante bombardamento di neutroni per formare 39Ar da 39K che si trovano nella roccia. Il rapporto tra 39K e 40Ar è una costante nota; quindi, se è possibile misurare la quantità di 39Ar prodotta dal 39K, ciò fornisce un metodo indiretto per calcolare gli isotopi 40K presenti nella roccia. La misurazione dei 39Ar prodotti dal bombardamento viene effettuata mediante spettrometro di massa mentre si misura la quantità di 40K presenti. Prima che un'età possa essere calcolata dalle proporzioni di 39Ar e 40Ar presenti, è necessario scoprire la proporzione di 39K che è stata convertita in 39Ar dal bombardamento di neutroni. Ciò può essere ottenuto bombardando un campione di età nota (uno "standard") insieme ai campioni da misurare e confrontando i risultati dell'analisi isotopica. Il principio del metodo Ar–Ar è quindi l'uso di 39Ar come proxy per 40K. Sebbene sia un metodo più difficile e costoso, Ar–Ar è ora preferito a K–Ar. Gli effetti dell'alterazione possono essere eliminati riscaldando a gradini il campione durante la determinazione delle quantità di 39Ar e 40Ar presenti mediante spettrometro di massa. L'alterazione (e quindi la perdita di 40Ar) si verifica a temperature inferiori rispetto alla cristallizzazione originale; quindi, i rapporti isotopici misurati a temperature diverse saranno diversi. Il campione viene riscaldato fino a quando non vi è alcuna variazione di rapporto con l'aumento della temperatura (si raggiunge un plateau): questo rapporto viene quindi utilizzato per calcolare l'età. Se non viene raggiunto alcun plateau e il rapporto cambia ad ogni passaggio di temperatura, allora il campione è troppo alterato per fornire una data affidabile.
Metodo Rubidio-Stronzio - La datazione rubidio-stronzio è basata sul decadimento beta del Rubidio-87 in Stronzio-87, con un tempo di dimezzamento di 50 miliardi di anni; questo processo è usato per datare le rocce ignee e metamorfiche più antiche e persino i campioni di rocce lunari; la temperatura di blocco è molto elevata, tale da consentire di trascurarne gli effetti. La datazione Rubidio-Stronzio non è però precisa quanto quella Uranio-Piombo, dal momento che implica errori di 30-50 milioni di anni per un periodo di 3 miliardi di anni.
Metodo Uranio-Torio - Un'altra datazione radiometrica a corto raggio è quella basata sul decadimento α dell'Uranio-238 a Torio-234 (datazione uranio-torio), con un tempo di dimezzamento di circa 80.000 anni. Questo decadimento è spesso associato ad un altro decadimento "fratello", quello dell'Uranio-235 nel Protoattinio-231, con un periodo di dimezzamento di 34.300 anni. Mentre l'Uranio è solubile in acqua, il Torio e il Protoattinio non lo sono, per cui essi si separano se precipitano come sedimenti nei fondali oceanici dai quali si può ricavare l'abbondanza di questi isotopi; questo tipo di datazione ha una scala di molte centinaia di migliaia di anni.
lunedì 31 gennaio 2022
Boltwood e l’età della Terra
Anche se il nome di Bertram Borden Boltwood (1870 - 1927) ai più è pressoché sconosciuto, il lavoro di questo chimico e fisico americano sul decadimento radioattivo dell'uranio e del torio è stato importante nello sviluppo della tecnologia di datazione assoluta.
Boltwood scoprì che il piombo era sempre presente nei minerali di uranio e torio. Pensò che il piombo dovesse essere il prodotto finale del decadimento radioattivo dell'uranio e del torio e notò che il rapporto piombo-uranio era maggiore nelle rocce più vecchie. Su suggerimento di Ernest Rutherford, fu il primo a misurare l'età delle rocce dal decadimento dell'uranio in piombo. Nel 1907, dopo che Rutherford aveva stabilito il concetto di tempo di dimezzamento, cioè il tempo richiesto per la disintegrazione di metà degli atomi inizialmente presenti, che è costante per ogni dato isotopo, pensò che, conoscendo la velocità con cui l'uranio si scinde, poteva usare la proporzione di piombo nei minerali di uranio come una specie di misuratore o orologio. L'orologio gli avrebbe detto da quanto tempo quel minerale - e per estensione, la crosta terrestre - esisteva. Le sue osservazioni e i suoi calcoli collocavano l'età della Terra a 2,2 miliardi di anni, molto di più della datazione di Kelvin basata sul raffreddamento da un’ipotetica nebulosa primordiale che assegnava alla Terra un’età massima di 100 milioni d’anni.
L'idea e la tecnica di base di Boltwood sono state utilizzate sin dal 1907, ma i progressi nella tecnologia e nella conoscenza della struttura atomica hanno dimostrato che la Terra è ancora più antica. Il decadimento dell'uranio è così lento che può indicare il tempo geologico. Il ragionamento di Boltwood vale per altri elementi radioattivi come il carbonio-14, che è utilizzato per datare eventi biologici e manufatti umani.
Il lavoro di Boltwood sulla serie di decadimento dell'uranio portò alla scoperta del nucleo genitore del radio, un nuovo elemento che chiamò ionio. Una volta stabilita l'esistenza degli isotopi, si capì che lo ionio era in realtà il torio-230. Sebbene Boltwood non abbia dato il suo nome ad alcun elemento nella tavola periodica, in seguito gli fu dedicato il nome di un minerale, la boltwoodite, un silicato idrato di uranile, originato dall'ossidazione e alterazione dei minerali di uranio.
Nei suoi ultimi giorni, Boltwood soffrì di depressione e si suicidò il 15 agosto 1927.
mercoledì 26 gennaio 2022
Darwin e il problema della datazione geologica
Una delle principali difficoltà di Darwin nel convincere un pubblico scettico, e alcuni fisici altrettanto scettici, fu che c'era stato abbastanza tempo dall'avvento della vita sulla terra perché il lento processo di selezione naturale avesse prodotto le piante e gli animali che vedevano intorno a loro. Darwin aveva bisogno di tempi geologici lunghi, affinché il lento meccanismo della selezione naturale potesse essere accettato come causa adeguata ed efficiente dell’evoluzione biologica.
Darwin si considerava più un geologo che uno zoologo o un botanico, specialmente nei suoi primi anni, e seguì Charles Lyell nell'indicare il ritmo lento di processi come l'erosione e la deposizione come prova di periodi di tempo geologico "incomprensibilmente lunghi". Così ragionava nella prima edizione del 1859 della Origin of Species, nel IX capitolo, intitolato On the imperfection of the geological record:
“Ma la quantità di erosione che gli strati hanno subito in molti luoghi, indipendentemente dal tasso di accumulazione della materia degradata, offre probabilmente la migliore prova del trascorrere del tempo. Ricordo di essere stato molto colpito dall'evidenza della erosione, quando ho visto isole vulcaniche, che sono state consumate dalle onde e tagliate tutt'intorno in scogliere perpendicolari di uno o duemila piedi di altezza; poiché il dolce pendio dei torrenti di lava, a causa del loro stato un tempo liquido, mostrava a prima vista fino a che punto i duri letti rocciosi si fossero un tempo estesi nell'oceano aperto. La stessa storia è raccontata ancora più chiaramente dalle faglie: quelle grandi crepe lungo le quali gli strati sono stati sollevati da un lato, o precipitati dall'altro, all'altezza o profondità di migliaia di piedi; poiché da quando la crosta si è incrinata, la superficie della Terra è stata così completamente spianata dall'azione del mare, che nessuna traccia di queste vaste dislocazioni è visibile esternamente.La faglia di Craven, per esempio, si estende per oltre 30 miglia, e lungo questa linea lo spostamento verticale degli strati è variato da 600 a 3000 piedi. Il Prof. Ramsay ha pubblicato un resoconto di uno spostamento verso il basso ad Anglesea di 2300 piedi; e mi informa che crede pienamente che ce ne sia uno nel Merionethshire di 12.000 piedi; eppure, in questi casi non c'è nulla in superficie che mostri movimenti così prodigiosi; la pila di rocce sull'uno o sull'altro lato è stata spazzata via senza intoppi. La considerazione di questi fatti impressiona la mia mente quasi allo stesso modo del vano tentativo di cimentarsi con l'idea dell'eternità.Sono tentato di citare un altro caso, quello noto della erosione del Weald. Sebbene si debba ammettere che la erosione del Weald è stata una sciocchezza, in confronto a quella che ha rimosso masse dai nostri strati paleozoici, in parti di diecimila piedi di spessore, come mostrato nelle magistrali memorie del Prof. Ramsay su questo argomento. Eppure, è una lezione ammirevole stare sui North Downs e guardare i lontani South Downs; poiché, ricordando che a non grande distanza a ovest le scarpate settentrionale e meridionale si incontrano e si chiudono, ci si può tranquillamente immaginare la grande cupola di rocce che deve aver ricoperto il Weald in un periodo così limitato come dall'ultima parte del Formazione di gesso. La distanza dal nord al sud Downs è di circa 22 miglia, e lo spessore delle varie formazioni è in media di circa 1100 piedi, come mi ha informato il prof. Ramsay. Ma se, come suppongono alcuni geologi, una serie di rocce più antiche è alla base del Weald, sui cui fianchi i depositi sedimentari sovrastanti potrebbero essersi accumulati in masse più sottili che altrove, la stima di cui sopra sarebbe erronea; ma questa fonte di dubbio probabilmente non influirebbe molto sulla stima applicata all'estremità occidentale del distretto. Se, quindi, conoscessimo la velocità con cui il mare consuma comunemente una linea di scogliera di una data altezza, potremmo misurare il tempo necessario per aver spogliato il Weald. Questo, ovviamente, non può essere fatto; ma possiamo, per farci qualche rozza idea sull'argomento, supporre che il mare possa inghiottire scogliere alte 500 piedi al ritmo di un pollice in un secolo. Questa a prima vista sembrerà una quantità troppo piccola; ma è lo stesso che supporre che una scogliera alta un metro venga divorata lungo un'intera linea di costa al ritmo di un metro ogni ventidue anni. Dubito che qualche roccia, anche tenera come il gesso, cederebbe di questo passo, tranne che sulle coste più esposte; sebbene senza dubbio il degrado di un'alta rupe sarebbe stato reso più rapido dalla rottura dei frammenti caduti. D'altra parte, non credo che nessuna linea di costa, lunga dieci o venti miglia, subisca mai contemporaneamente un degrado lungo tutta la sua lunghezza frastagliata; e dobbiamo ricordare che quasi tutti gli strati contengono strati o noduli più duri, che per lunga resistenza all'attrito formano un frangiflutti naturale alla base. Quindi, in circostanze ordinarie, concludo che per una scogliera alta 500 piedi, una denudazione di un pollice per secolo per l'intera lunghezza sarebbe un'ampia concessione. A questo ritmo, sui dati di cui sopra, la denudazione del Weald deve aver richiesto 306.662.400 anni; o diciamo trecento milioni di anni.L'azione dell'acqua dolce sul distretto di Wealden leggermente inclinato, una volta sollevata, non avrebbe potuto essere grande, ma ridurrebbe in qualche modo la stima di cui sopra. D'altra parte, durante le oscillazioni di livello, che sappiamo ha subito quest'area, la superficie può essere esistita per milioni di anni come terraferma, e quindi sfuggire all'azione del mare: quando fosse stata sommersa in profondità per periodi forse altrettanto lunghi, sarebbe, parimenti, sfuggita all'azione delle onde costiere. Così che con ogni probabilità è trascorso un periodo molto più lungo di 300 milioni di anni dall'ultima parte del periodo secondario.Ho fatto queste poche osservazioni perché è molto importante per noi acquisire una nozione, per quanto imperfetta, del trascorrere degli anni. In ognuno di questi anni, in tutto il mondo, la terra e l'acqua sono state popolate da schiere di forme viventi. Che numero infinito di generazioni, che la mente non può cogliere, devono essersi succedute nel lungo corso degli anni! Ora è nei nostri musei geologici più ricchi e che spettacolo irrisorio vediamo!”
Nel 1858 Darwin si era stabilito con la sua famiglia a Down House, a circa 20 miglia a sud di Londra, nella bucolica campagna del Kent, lontano da tutte le pressioni della grande città. A sud della sua casa ci sono due colline, alte circa 250 metri, chiamate North e South Downs. Si tratta dei lembi erosi di una anticlinale, una cupola di rocce stratificate del Cretaceo inferiore tagliate dagli agenti atmosferici per esporre gli strati come creste di arenaria e valli argillose. Le rocce più antiche esposte al centro dell'anticlinale formano una valle poco profonda chiamata Weald e sono attribuite al Giurassico superiore. Al di sopra di queste giacciono le rocce del Cretaceo, che includono il gruppo Wealden di sabbie e argille alternate. Geologicamente, i Downs sono i resti di una grande cupola di gesso, la cui sommità è stata erosa nel tempo. Un capitolo dei Principles of Geology di Lyell descrive l'enorme erosione coinvolta nella formazione del Weald, che era stata studiata, come dice Darwin, anche dal grande geologo scozzese Andrew Ramsey nel saggio On the Denudation of South Wales and the Adjacent Counties of England (1846), nel quale aveva sostenuto il potere del mare di formare grandi pianure di erosione.
Quanto tempo, si domandò Darwin, ci era voluto prima che quella cupola di roccia originale venisse erosa fino al suo stato attuale? Il calcolo gli avrebbe dato una stima di almeno un particolare arco di tempo geologico. Darwin aveva bisogno solo di tre numeri. Innanzitutto, la distanza tra i due Downs, che è di circa 22 miglia (36 Km), poi lo spessore dello strato di gesso: circa 1100 piedi, 335 m. Infine, la velocità con cui avviene l'erosione, un numero più complicato da ottenere. Darwin immaginò una situazione simile a quella che coinvolge le scogliere di gesso di Dover, poche miglia più a sud, sul Canale della Manica, dove le onde stanno lentamente demolendo le bellissime scogliere bianche. La stima di Darwin era che "un’erosione di un pollice per secolo per l'intera lunghezza sarebbe un'ampia concessione".
Darwin si rendeva conto che questo numero era solo approssimativo, tuttavia arrischiò il calcolo, che richiedeva solo due passaggi:
- Se ci vuole un secolo prima che una scogliera di 500 piedi si eroda di 1 pollice, quanto tempo impiegherebbe uno strato spesso 1100 piedi per essere eroso della stessa quantità? Usando le proporzioni, la risposta è 1100/500 = 2,2 secoli.
- Se ci vogliono 2,2 secoli per erodere 1 pollice, quanto tempo impiegherebbe l’erosione di 22 miglia? Trasformando queste miglia in piedi, poi in pollici, si ottiene:
(22 × 5280 × 12) × 2,2 secoli, cioè 306.662.400 anni
Che è il numero che Darwin scrisse: circa 300 milioni di anni. E questa era solo una parte ("una sciocchezza", come diceva) del tempo geologico. La Terra stessa doveva essere molto più antica. Certamente un sacco di tempo, perché il lento processo di selezione naturale abbia luogo e le specie si evolvano.
Purtroppo per lui, entro poche settimane dalla pubblicazione, Darwin fu oggetto di forti critiche, soprattutto su questo calcolo. La sua stima per il tasso di erosione, scrivevano i suoi critici, era totalmente ingiustificata. Era ridicolo, per esempio, usare semplici proporzioni. Il tasso di erosione poteva essere variato nel tempo e non esisteva certamente alcun motivo per presumere che il tasso in passato fosse lo stesso di oggi. Poteva essere mille volte più veloce, o più lento. I 300 milioni di anni erano totalmente inaffidabili.
Si potrebbe quasi dire che il guaio di Darwin nacque originariamente per eccesso di fiducia in sé stesso. Lyell gli aveva detto che il tempo necessario per il cambiamento geologico e biologico era virtualmente senza limiti, e le sue stesse osservazioni avevano rafforzato questa convinzione al punto della certezza. Già nel saggio del 1842 sulle barriere coralline accettò l’estrema imperfezione della documentazione geologica e la realtà di lunghi tempi prima del Siluriano come cosa stabilita, e parlò confidenzialmente delle immense età trascorse durante ogni periodo geologico. Sebbene avesse confessato più volte che la sua fiducia riguardo l’imperfezione dei dati geologici era la parte più debole della sua idea, essa era una debolezza che nasceva dalle difficoltà di ricavare conclusioni dall’evidenza negativa piuttosto che da qualche dubbio sul significato delle lacune nell’evidenza stessa. Preparando l’Origin of Species, pertanto, presentò una meticolosa spiegazione delle sue ragioni di credere che i dati fossero imperfetti, ma abbandonò questa remora quando considerò la discussione della grandezza di questi dati espressi in anni. Piuttosto che tentare di dimostrare l’intervallo di anni attraverso la sua abituale raccolta di prove, scelse semplicemente di illustrare la sua idea con un singolo esempio ricavato da una fonte conosciuta.
Dopo una critica anonima dell’Origin comparsa sulla Saturday Review del 24 dicembre 1859, che criticava fortemente la metodologia dei calcoli di Darwin, egli fu costretto a fare marcia indietro. Il 3 gennaio 1860, Darwin scrisse a Hooker al riguardo: "Alcune delle osservazioni sul passare degli anni sono molto buone, e il recensore mi fa dei colpi buoni e ben meritati, - accidenti, mi dispiace confessare la verità. Ma non riguarda affatto l'argomento principale." Il giorno dopo, disse a Lyell "Hai visto, suppongo la Saturday Review: argomento limitato alla geologia, ma mi ha dato dei colpi sulle nocche perfettamente giusti e severi."
Nella seconda edizione, Darwin continuò a suggerire "una denudazione di un pollice per secolo" per l'intera lunghezza di una scogliera alta 500 piedi, e non cambiò le sue idee. Tuttavia, aggiunse questa frase come corollario, ammettendo che il suo calcolo poteva essere dimezzato o addirittura ridotto di due terzi: "Ma forse sarebbe più sicuro ammettere due o tre pollici per secolo, e questo ridurrebbe il numero di anni a centocinquanta o cento milioni di anni”. Nella edizione americana che uscì nel 1860 aggiunse una nota esplicativa:
“Confesso che un articolo capace e giustamente severo (...) mostra che sono stato avventato. Non ho sufficientemente tenuto conto della malleabilità degli strati sottostanti il gesso (...) Né ho considerato la denudazione in corso su entrambi i lati dell'antica Weald-Bay (...) È mia abitudine osservare da tempo la forma e lo stato della superficie dei frammenti alla base di alte scogliere in ritirata, e non trovo parole troppo forti per esprimere la mia convinzione dell'estrema lentezza con cui vengono consumati e rimossi. Prego il lettore di osservare che ho espressamente affermato che non possiamo sapere con quale velocità il mare logori una linea di scogliera: ho ipotizzato un pollice per secolo per avere una vaga idea del trascorrere degli anni; ma ho sempre supposto che il lettore avrebbe raddoppiato o quadruplicato o aumentato in qualsiasi proporzione che gli fosse parsa giusta il probabile tasso di denudazione per secolo. Ma ammetto di essere stato avventato e sconsiderato nel calcolo”.
Nella terza edizione, pubblicata il 30 aprile 1861, Darwin invocò l'articolo del Saturday Review come motivo per rimuovere del tutto il suo calcolo.
La stima di Darwin fu attaccata in una disputa molto più ampia sull'età della terra tra geologi e fisici, il più notevole tra i quali fu William Thomson, Lord Kelvin. Il punto di disputa fu oggetto di una prima conversazione a tre con il botanico Joseph Dalton Hooker e Charles Lyell. "Non riesco a pensare come si possa attribuire così tanto peso ai fisici", disse Darwin a Hooker, "Sosterrò fino alla morte che il tuo studio su Fernando Poo [isola africana nel golfo di Guinea, oggi Bioko] e sull'Abissinia vale dieci volte di più della convinzione di una dozzina di fisici". La disputa andò avanti così a lungo che fu il figlio matematico di Darwin, George, solo un bambino quando fu pubblicata l’Origin, a dare finalmente a suo padre qualche speranza che i fisici sarebbero stati sconfitti. Lungo la strada c'era il continuo sostegno di geologi come Joseph Beete Jukes che si opposero fortemente quando Darwin propose di omettere del tutto l'argomento "Weald", portando Darwin a esclamare "Quanto è difficile accontentare tutti!" Anche Thomas Henry Huxley che Alfred Russel Wallace ebbero un ruolo in vari momenti.
In quegli stessi anni (1860), il geologo inglese John Phillips (contrario sia alle teorie di Lyell che a quelle di Darwin), basandosi sullo spessore di strati di varia età e sulla presumibile velocità della loro deposizione, stimava invece, in risposta a Darwin, l’età della Terra intorno a 96 milioni di anni. Ma il parere dei geologi era, tutto sommato, poco rilevante. Quello che contava di più, per le implicazioni che aveva, era quello di Darwin. Nel 1863, quando l’Origin era alla sua terza edizione, Thomson calcolò sulla base del presunto tasso di raffreddamento da una massa incandescente, che la Terra stessa aveva solo tra 100 e 200 milioni di anni, e continuò a rivedere questa cifra inesorabilmente verso il basso negli anni successivi.
Il ragionamento di Kelvin si basava sul convincimento che il Sole fosse una massa liquida incandescente che sta dissipando rapidamente la sua energia; e che l’origine del calore solare non potesse essere che gravitazionale, essendo da escludere come inadeguata quella chimica. Il punto di partenza di Kelvin era pertanto la formazione di una massa fusa, derivata dal collasso gravitazionale di una nebulosa, come quella postulata da Kant e Laplace. Se si conosce la massa globale del sistema (ricavata dalla massa stimata attuale del Sole), sistema che è immaginato all’inizio a riposo in tutte le sue parti, si può facilmente calcolare la quantità di calore che sarebbe stato generato come equivalente della energia meccanica delle collisioni avvenute in conseguenza del collasso gravitazionale. In base alla conoscenza del flusso di calore emanato oggi dal Sole e dell’energia disponibile all’inizio, si può risalire alla data di questo inizio. Peccato che allora non si avesse la minima idea dell'esistenza di sorgenti radioattive di energia. La scoperta delle leggi del decadimento radioattivo dei radionuclidi, all’inizio del Novecento, avrebbe affossato per sempre i calcoli di Lord Kelvin.
L’assoluta supremazia delle “leggi fisiche note” su un qualunque altro ragionamento portava appunto a bollare come assurde le ipotesi di Darwin e dei geologi. Calcoli matematici sulla presunta velocità di raffreddamento del Sole e della Terra inducevano Kelvin a postulare un’età della Terra con tutta probabilità inferiore ai 100 milioni di anni. Che fosse un problema di “guerra ideologica” piuttosto che una questione meramente scientifica è messo in evidenza dall’arena su cui Kelvin aveva deciso di aprire le ostilità: il Macmillan’s Magazine, una rivista popolare. Kelvin parlava quindi direttamente al grande pubblico.
Quando Darwin stava lavorando alla quinta edizione, Thomson aveva concluso che 100 milioni di anni erano il limite superiore, piuttosto che inferiore, dell'età della Terra. Darwin spiegò il suo dilemma al geologo scozzese James Croll: "Sono molto turbato per la breve durata del mondo secondo Sir W. Thompson, poiché per le mie opinioni teoriche ho bisogno di un periodo molto lungo prima della formazione del Cambriano". In una lettera al figlio George del 1868, Darwin diceva di guardare, nel libro di Thompson e Tait Treatise on natural philosophy uscito l’anno precedente, la cifra indicata per il tempo trascorso dalla solidificazione della Terra. Egli era preoccupato per “la brevità del mondo” perché le creature pre-siluriane dovevano aver vissuto per età senza fine, “altrimenti le mie idee sarebbero sbagliate, che è impossibile”. Gli strati del Cambriano sono ricchi di fossili di vari tipi di animali, ma nessuno era stato trovato negli strati più antichi, così che la vita complessa sembrava essere sorta improvvisamente. Da allora sono state scoperte prove di animali più grandi dal corpo molle e di abbondante vita microscopica in periodi precedenti, ma Darwin fu costretto a solo postularne l'esistenza e spiegare la mancanza di prove con l'incompletezza della documentazione fossile. Anche allora, non c'era modo di sfuggire al fatto che la selezione naturale avrebbe potuto produrre una così ampia varietà di vita cambriana solo in un arco di tempo precedente molto lungo.
Sebbene Croll avesse risposto cautamente, suggerendo che la crosta terrestre avrebbe potuto formarsi più rapidamente durante il raffreddamento di quanto consentito da Thomson, spingendo così indietro nel tempo il punto in cui avrebbe potuto inizialmente sostenere la vita organica, ciò non era ancora abbastanza per Darwin che, nel frattempo, aveva menzionato il problema al figlio George, neoeletto membro del Trinity College di Cambridge: "Oserei dire che vorrò molti consigli su Croll e Thompson ed essere impiccato da loro".
Nel 1877, George Darwin stava lavorando sull'effetto della gravità della Luna sulla Terra e suggerì che Thomson, che lo aveva appena sostenuto per la borsa di studio della Royal Society, avrebbe dovuto tenerne conto nei suoi calcoli. Seguirono alcuni mesi, ma alla fine Thomson fu convinto dalla proposta di George che l'attrito delle "maree" create nella struttura della Terra dall'attrazione della Luna avrebbe generato calore e avrebbe rallentato la velocità di raffreddamento del pianeta. “Sorrido anche molto per il calore interno. Come questo farà piacere ai geologi e agli evoluzionisti", suo padre esultò in una lettera del 29 ottobre 1878, "Evviva le viscere della Terra e la loro viscosità e la Luna e tutti i corpi celesti e mio figlio George!"
Si ritiene oggi che il Cretaceo sia durato da 145 a 65 milioni di anni fa. Darwin sbagliò il suo calcolo di oltre i due terzi. L’età della Terra è stimata a circa 4,5 miliardi d’anni. Lord Kelvin sbaglio il suo calcolo di più di 45 volte.
Iscriviti a:
Post (Atom)