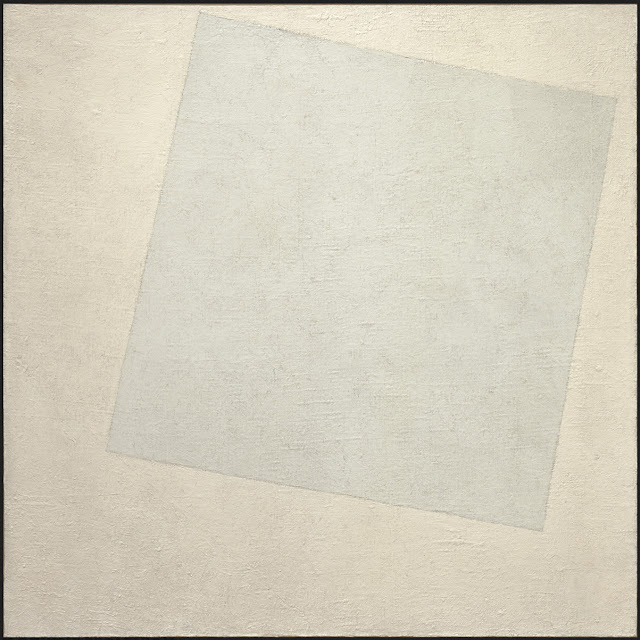Kazimir Malevič, Bianco su bianco, (1918)
L’energetica di Wilhelm Ostwald e il sistema di pensiero sull’organizzazione di Alexander Bogdanov influenzarono a tal punto l’arte dell’avanguardia russa nei primi cinque anni dopo la Rivoluzione che si può dire che formarono un paradigma per la pittura astratta russa tra il 1918 e il 1924 circa.
Bogdanov e Ostwald erano ben noti prima della Rivoluzione. Dopo tale evento, quando gli artisti ebbero il compito di sviluppare un’arte nuova, razionale e demistificata, molti guardarono alle loro idee per un approccio scientifico che fosse esplicitamente congeniale al marxismo. Per Bogdanov la cultura, compresa la scienza, era un principio organizzativo della società, e inevitabilmente il prodotto del sistema sociale. Poiché pensava che una “egemonia culturale generale” della classe lavoratrice fosse cruciale per il successo delle rivoluzioni economiche e sociali, l’opera per sviluppare una cultura proletaria era per lui imperativo per sostenere la rivoluzione socialista. Prima dell'articolazione di Antonio Gramsci di una guerra culturale egemonica, Bogdanov era preoccupato che senza un'adeguata educazione socialista, le masse rivoluzionarie potessero inconsciamente tornare alle abitudini borghesi.
In Arte e classe lavoratrice (pubblicato nel 1918), Bogdanov sosteneva che l’arte è organizzata indipendentemente da ogni compito civile destinato all’artista e che il contenuto dell’arte è la vita nel suo complesso, senza limiti tematici. L’arte non solo difende gli interessi di una classe, ma piuttosto è necessariamente strutturata dalle sue origini di classe e adotta questo punto di vista a un livello fondamentale. La classe lavoratrice, secondo Bogdanov, non dovrebbe rifiutare l’arte del passato, ma comprenderla. Il proletariato deve possedere genuinamente la cultura del passato, compresa una consapevolezza analitica delle idee sottostanti. Pertanto, Bogdanov sosteneva un riesame delle arti e delle scienze per rivelare le loro contraddizioni e le promesse non mantenute come un necessario passo per lo sviluppo di arti e scienze nuove. Infine, Bogdanov immaginava un pensiero che fosse sostanzialmente liberato dal coinvolgimento emotivo, un pensiero più “oggettivo” che sarebbe servito nella costruzione di una nuova consapevolezza e quindi di una nuova arte.
Bogdanov iniziò i suoi sforzi per avviare una nuova cultura proletaria prima della Rivoluzione, mentre era in esilio all'estero. Con Lunačarskij e Maxim Gorkij, lui stesso grande estimatore di Ostwald, diresse scuole per operai, prima nel 1909 a Capri (a casa di Gorkji) e l'anno successivo a Bologna. Sulla base di questa esperienza, dopo la Rivoluzione di febbraio e una settimana prima della Rivoluzione d'Ottobre a Pietrogrado, guidò l'istituzione del movimento della Cultura Proletaria (Proletkult). Per i successivi sei anni, il Proletkult organizzò scuole e seminari in tutto il paese. Nelle sedi si insegnava ai lavoratori a leggere, scrivere, a dipingere, a poetare e imparare la scienza, principalmente dal punto di vista organizzativo di Bogdanov. Gli studenti erano principalmente lavoratori; gli insegnanti erano spesso l'avanguardia letteraria e artistica prerivoluzionaria.
Praesidium dell'organizzazione nazionale Proletkult eletto alla prima conferenza nazionale, settembre 1918. Seduti da sinistra a destra: Fedor Kalinin, Vladimir Faidysh, Pavel Lebedev-Polianskij, Aleksei Samobytnik-Mashirov, I. I. Nikitin, Vasili Ignatov. In piedi da sinistra a destra: Stefan Krivtso, Karl Ozol-Prednek, Anna Dodonova, N.M. Vasilevskj, Vladimir Kirillov.
Sebbene all’inizio fossero nominalmente indipendenti, le scuole furono presto finanziate dal bilancio del Commissariato dell'Educazione (Narkompros), guidato da Anatolij Lunačarskij, amico e cognato di Bogdanov. Sebbene ogni centro del Proletkult fosse abbastanza autonomo e non esistesse un programma scolastico “ufficiale” fino al 1921, quando Lenin intervenne personalmente, Bogdanov fu attivamente impegnato nelle scuole, suggerendo programmi e spiegando e pubblicando le sue idee sul riesame della scienza, arte e cultura in libri e periodici finanziati dal Proletkult. Anche dopo le denunce di Lenin, che vedeva con diffidenza questo sfogo di creatività rivoluzionaria, i laboratori del Proletkult continuarono a esplorare le idee organizzative e tektologiche di Bogdanov sull’arte e nelle questioni culturali; a Mosca questa sezione fu guidata dall'artista e teorico costruttivista Nikolai Tarabukin.
Immediatamente dopo la Rivoluzione, l'avanguardia artistica e l'organizzazione del Proletkult avevano due punti in comune: entrambi cercavano la creazione di una nuova arte, ed entrambi chiedevano la separazione dell'arte dallo stato. Nel suo rapido consolidamento all'interno della struttura del Ministero dell’Educazione, il Narkompros, l'avanguardia operò all'interno di un'organizzazione che forniva anche al Proletkult un supporto finanziario e politico affidabile, perché era guidato da Lunačarskij. Ciò portò inevitabilmente a un notevole conflitto di interessi. Non c'è da stupirsi che molte scuole del proletariato nutrissero inclinazioni d'avanguardia nella teoria e nella pratica dell'arte. Sebbene né il gusto personale di Lunacharsky né quello di Bogdanov fossero inclini al futurismo o al costruttivismo, entrambi gli uomini si trattennero dal sostenere uno stile o un approccio particolare per la nuova arte.
Una delle esposizioni più articolate della filosofia di Bogdanov fu avanzata dal critico e teorico Nikolai Punin, che dirigeva la Sezione di arti visive di Pietrogrado del Narkompros. Le sue lezioni, lette agli insegnanti nell'estate del 1919, seguivano da vicino le idee e la terminologia di Bogdanov. Punin mise in risalto la cultura delle macchine, il pensiero sistemico, l'organizzazione, l'efficienza, il metodo, le immagini astratte e l'opera d'arte come una forma elevata di cognizione umana.
L’artista pietroburghese Maria Ender descriveva l'intero mondo naturale come un flusso di energie:
“Un albero è saturo di energia solare. I rami sono disposti lungo l'energia solare più intensa, le radici, lungo il percorso dei sali più intensi della forza terrestre. La foresta rivela la saturazione dello spazio in tre dimensioni; cattura le forze della vita. L'immagine del gelo sul finestrino è una corrente di forza catturata sul piano Voglio cogliere la direzione. Il corpo nasce dagli incontri dei vari movimenti. Non ci sono confini: la connessione delle cose. Le cose sono noduli di varie energie”.
Maria Ender, Esperimento con una nuova dimensione spaziale (1920)
Nel dicembre 1915, all'ultima mostra futurista di dipinti 0.10 (zero-dieci) a Pietrogrado (ora San Pietroburgo), Kazimir Malevič svelò una modalità radicalmente nuova di pittura astratta che abbandonava ogni riferimento al mondo esterno a favore di forme geometriche colorate fluttuanti su sfondi bianchi. Poiché il suo nuovo stile rivendicava la supremazia sulle forme della natura, lo chiamò "Suprematismo". In un volantino distribuito in occasione della mostra, Malevič scriveva: “Mi sono trasformato nello zero della forma, ho distrutto l'anello dell'orizzonte e sono fuggito dal cerchio delle cose, dall'orizzonte-anello che confina l'artista e le forme della natura." Poiché il suprematismo rifiutava le illusioni deliberate della pittura rappresentativa, Malevič lo vedeva come una forma di realismo ("nuovo realismo pittorico" era il suo termine) e diceva che il suo soggetto erano i componenti di base del linguaggio della pittura, come colore, linea e pennellata. Le unità di base di questo vocabolario visivo erano piani, allungati, ruotati e sovrapposti. Per Malevič, gli sfondi bianchi su cui sono erano rappresentato mappavamo lo spazio illimitato dell'ideale.
Come un ricercatore, Malevič parlò sempre di questo evento come di una scoperta piuttosto che di un'invenzione, e trascorse il resto della sua vita cercando di spiegarne il significato. La sua conclusione visiva radicale nel suprematismo fu, infatti, raggiunta nel corso della sperimentazione di idee mistiche e simboliste, una ricerca di un modo per trasmettere nell'arte un ordine superiore di realtà. Pur essendo arrivato al suprematismo con altri fini, Malevič ne riconobbe il carattere storico radicale e, nel tentativo di spiegare il profondo significato del movimento per l'arte, reinterpretò ripetutamente il suprematismo come visione del mondo.
Kazimir Malevič, Composizione suprematista (1916)
Il suo incontro principale con le idee di Ostwald e Bogdanov può essere datato approssimativamente alla fine del 1918 o all'inizio del 1919, proprio nel momento in cui molti artisti stavano tentando di capire che cosa avrebbe potuto essere un'arte marxista, che cosa poteva rappresentare tale arte e come poteva essere rappresentata. In una conferenza al Proletkult nel 1920 Malevič disse al suo pubblico: "La nuova conclusione suprematista porta a nuovi sistemi, al di là del groviglio di oggetti, a una forza di movimento puramente energetica". L'energia di Ostwald offriva a Malevič un modo per continuare la sua ricerca prerivoluzionaria dell'invisibile e dell'immateriale, agganciandola alla "realtà" del concetto scientifico di energia. La nuova centralità per il suprematismo è facilmente evidente negli appunti di Malevič per una conferenza: “Lo sviluppo dell'energia primaria… Il dinamismo della forma di energia primaria. L'esplosione. L'accumulo di elementi in una fitta rete energetica come espressione di dinamismo.... Il colore come mezzo per esprimere un geometrismo dinamico della forma… Il bianco come massima espressione di energia geometrica”.
Kazimir Malevič, Quadrato nero (1915)
Durante questo periodo, i colori per Malevič erano indicatori dei livelli di energia, presenti nel mondo come movimento e forza universale. Come Oswald, Malevič sviluppò anche un'interpretazione socio-energetica dei colori, che riteneva fossero caratteristici di particolari gruppi sociali. Malevič era così preso da una visione del mondo termodinamica, che quando gli fu chiesto di suggerire un programma per la nuova scuola d'arte di Vitebsk alla fine del 1919, divise la facoltà in tre dipartimenti: statica, velocità e dinamica. Nel dipartimento di statica, dove gli studenti avrebbero dovuto studiare per due anni, le materie hanno un tono spiccatamente bogdanoviano: “Statica: geometria della forma. La composizione di forme contrastanti.... Costruzione. Sistema. Storia del sistema. Teoria dei sistemi”. E quando divenne direttore del Museo della Cultura Artistica di Pietrogrado nel 1923, pose lo studio dei "sistemi" dipinti (cioè i dipinti) come uno dei suoi obiettivi primari.
Come Malevič, Ljubov Popova menziona per la prima volta l'energia alla fine del 1918 o all'inizio del 1919. "Struttura nella pittura = la somma dell'energia delle sue parti", scrisse in un commento per un catalogo, ma a differenza di Malevič, che cercò di interpretare la pittura già esistente, per la Popova l’interesse per l'energia era diretto al suo lavoro in corso. Il grande dipinto intitolato Costruzione pittorica (1920), alto più di un metro e mezzo, è diverso da qualsiasi opera precedente di Popova. Questa rappresentazione di uno spazio profondo in movimento violento, con spirali che salgono lungo una diagonale per l'intera altezza della tela, e frecce e zig-zag che colpiscono verso il basso tra grandi strisce colorate rotanti, è chiaramente un dipinto sull'energia: l'immagine di Popova del mondo energetico. "Il colore partecipa all'energia per il suo peso", scriveva, e "Energetica = direzione dei volumi + piani e linee o loro tracce + tutti i colori".
Ljubov Popova, Composizione pittorica (1920)
I molti collegamenti con il Proletkult portarono i frutti migliori nella teoria e nel lavoro creativo del costruttivismo. Organizzati nel 1921 nelle discussioni tenute all'Istituto di cultura artistica di Mosca, i costruttivisti crearono un linguaggio visivo astratto e materiale che rifiutava l'illusione e i riferimenti soggettivi o spirituali. Gli artisti costruttivisti scelsero di adottare un vocabolario visivo che sentivano scientifico o "oggettivo" ed espressero interesse per l'energia, l'efficienza e le relazioni astratte, producendo un corpo di opere che era concreto, materiale ed esemplare delle metastrutture della tecnologia di Bogdanov. "Il costruttivismo è una nuova scienza", sostenne l'artista Georgij Stenberg: "Il costruttivismo è il mezzo di sviluppo culturale del mondo, che insegna che l'ingegneria è economica, efficiente e sociale". Non c'è espressione più concisa del modello sottostante al costruttivismo dello slogan comparso nel catalogo della mostra Konstruktivizem (Costruttivismo) da Stenberg e Medunetsky nel gennaio 1922: “Il Costruttivismo condurrà l’umanità a padroneggiare un massimo di valori culturali con il minimo dispendio di energia”.
"Qui in Russia", scriveva Popova, "nel momento socio-politico in cui stiamo vivendo, l'obiettivo della nuova sintesi è diventato l'organizzazione come principio per qualsiasi attività creativa, compreso il design artistico". Come Bogdanov, immaginò una disciplina distinta e separata che "ricerca in modo speciale le leggi dell'organizzazione degli elementi - di tempi diversi o dello stesso tempo - e i sistemi della loro organizzazione".
Col tempo, Popova e Aleksandra Aleksandrovna Ėkster svilupparono un insolito stile diagrammatico, dove le linee rette e tratteggiate sembrano indicare un movimento o un processo misurato e organizzato all'interno di un sistema razionalizzato.
Aleksandra Ėkster, Composizione (1921)
I costruttivisti si dedicavano alla creazione di oggetti d'arte che avrebbero organizzato il nuovo uomo sovietico in una direzione collettiva verso il socialismo. Cercavano di creare i progetti e gli oggetti dell'arte proletaria come fusione di essere umano, tecnica, scienza e vita quotidiana basati sul principio della concordanza delle parti, delle forme e dei materiali.
Per i costruttivisti il concetto di “organizzazione” come metodo di combinazione di elementi attivi era un'idea e uno stimolo potente. I modelli tecnici dimostravano i modi pratici per gli artisti di costruire un complesso di "arte di produzione" al fine di adempiere al comando politico che richiedeva agli artisti proletari di fornire oggetti d'arte pratici e funzionali.
Nel 1922 Alekseiy Gan pubblicò l'opera rivoluzionaria Costruttivismo, in cui inserì lo slogan "lavoro, tecnica e organizzazione!" Bogdanov parlava del “lavoratore-organizzatore”, i costruttivisti dell'“artista-organizzatore”: entrambi i modelli implicavano il lavoro collettivo. I costruttivisti vedevano il lavoro artistico collettivo come un percorso verso il socialismo.
L'artista costruttivista era un "artista-organizzatore", un "artista-operaio", un membro del collettivo proletario, che organizzava e creava un oggetto d'arte organizzata nella produzione collettiva. Il prodotto dell'arte del lavoro costruttivista figurava come un complesso organizzato nel senso di Bogdanov.
Il grande regista Ėjzenštejn promosse una stretta alleanza tra Proletkult e LEF (Fronte sinistro delle arti), un gruppo costruttivista di Mosca guidato da Osip Brik e Vladimir Majakovskij. Teorici come Nikolai Tarabukin e Boris Arvatov, che erano istruttori del Proletkult di Mosca, dipendevano fortemente da Bogdanov per i loro concetti di arte proletaria, creatività collettiva e riesame programmatico degli elementi strutturali dell'arte precedente.
Altri pittori affrontarono il tema dell'energia in modo diverso: Vladimir Stenberg suggeriva una specie di plasma magnetico, Alexander Rodčenko, poi grande fotografo e autore di manifesti, realizzò una serie di dipinti che esplorano la luce come creatrice di forme.
Alexander Rodčenko, Lilja Brik (Ritratto per un manifesto pubblicitario - Lengiz: Libri per tutti i campi della conoscenza (1924)
Diversi altri astrattisti si rivolsero alla questione della luce e della luminosità. Sotto l'influenza dell'ingegnere missilistico e filosofo Konstantin Ciolkovskij, che conosceva personalmente, Ivan Kudriašev sviluppò uno strile di astrazione cosmica che chiamò pittura spaziale. Dalla metà degli anni '20 Kudriašev si interessò in particolare al movimento e ai lampi di luminescenza nello spazio cosmico. Dipinse forze dinamiche, dando titoli alle opere che si riferivano a percorsi di movimento attraverso lo spazio profondo. Sebbene non fosse direttamente associato alla termodinamica, Kudriašev rese esplicita la comprensione dell'astrazione condivisa da molti pittori russi dell'epoca:
“La pittura nella forma definita nel mio lavoro cessa di essere una costruzione colore-forma astratta, [piuttosto lo è] diventando un'espressione realistica della percezione contemporanea dello spazio... Spazio, volume, densità, e la luce - e la realtà materiale - questo è qualcosa di sostanzialmente nuovo
che oggi è stabilito dalla pittura spaziale."
Ivan Kudriašev, Traiettoria orbitale di un pianeta che si lancia verso il Sole (1926)
Kliment Redko si interessava allo stesso modo della rappresentazione della luminosità, trasmessa da aree di superficie di colore brillante. Per questi pittori, la rappresentazione degli effetti luminosi incarnava le recenti spiegazioni scientifiche della loro origine e dei loro meccanismi e sottolineava l'abbraccio degli artisti alla visione materialistica del mondo. "Un dipinto", scrisse Redko, "è un organizzatore di fenomeni atmosferici" e "L'aurora boreale è un indicatore di una nuova base scientifica di luminosità nell'energia della luce".
Kliment Redko, Sole di mezzanotte (Luci del Nord), 1925
Malevič, tuttavia, che non andava d’accordo con Redko ed era sempre acutamente consapevole della mutevolezza delle idee, commentò sarcasticamente:
“Dopo molti sforzi sono riusciti a svelare e definire la causa dell'aurora boreale; in una versione scientifica si dice che la causa principale di questo fenomeno sia l'azoto, il quale, presente negli strati superiori dell'atmosfera, assume a bassa temperatura una forma cristallina, rifrangendo i raggi solari o elettrici, ed emette un colore verde luce caratteristica dell'aurora boreale ... Di conseguenza viene confutata la definizione passata, cioè che la causa dell'aurora boreale è Dio che, diciamo, abbassa la barba che trasuda luce.... Se la nuova scienza dell'azoto, del radio e dell'etere considera la causa di molti fenomeni, scoprirà così tutta una serie di quei poteri che erano chiamati Dio dispersi in tutti i fenomeni. Non ci sono motivi per pensare che, dopo questa successiva scoperta dell'azoto come causa dell'aurora boreale, non si troverà un nuovo responsabile in futuro. Né Dio né l'azoto, né X saranno responsabili: l'azoto e Dio saranno un malinteso da parte delle scienze religiose e ... delle scienze materiali ... Oggi è Dio, domani Azoto, il giorno dopo una nuova X, e tutti i nomi e le X formeranno la somma totale delle incomprensioni”.
Un gruppo più giovane di pittori astrattisti, tra i quali proprio Redko, che si definivano “Il Metodo” o “Proiezionisti” furono i più fedeli seguaci di Bogdanov, i suoi più attenti allievi e, alla fine, gli ultimi rappresentanti della pittura astratta in Russia per un lungo periodo, ma di loro parlerò casomai un’altra volta. Il Prolekult era infatti diventato un corpo esterno alla dottrina del partito comunista e fu sciolto nel 1932 e io non voglio andare contro il compagno Segretario Josip Stalin, con il quale mi conviene concordare pienamente e sinceramente.















.png)