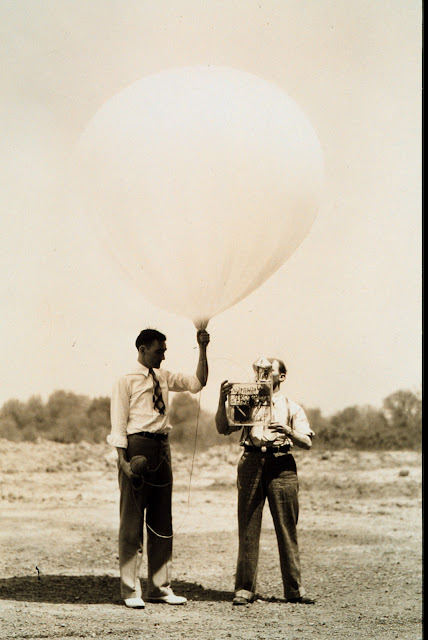La Constitutum Constantini, la più famosa di tutte le falsificazioni medievali, fu scritta a Roma (probabilmente dalla Cancelleria pontificia), o in Francia, tra l’Ottavo e il Nono secolo, e stabilì per secoli la base giuridica per il primato clericale di papa Silvestro e dei suoi successori. Secondo il documento, l’imperatore romano Costantino Il Grande aveva ceduto al papato vaste regioni del suo impero.
La Donazione inizia raccontando la conversione di Costantino alla fede cristiana e la sua guarigione dalla lebbra ottenuta da Silvestro, Vescovo di Roma. Dopo aver così testimoniato, Costantino avrebbe poi concesso a Silvestro il primato su tutti gli altri patriarcati, rendendolo capo di tutto il clero cristiano, e fatto del papato una sorta di regno temporale, con vaste rivendicazioni territoriali a sua disposizione.
Il documento, che avrebbe recato la data del 30 marzo 315, afferma di riprodurre un editto emesso dall'imperatore Costantino. Con esso egli avrebbe attribuito al papa Silvestro I e ai suoi successori una serie di concessioni. La parte del documento su cui si basarono le rivendicazioni papali recita:
«In considerazione del fatto che il nostro potere imperiale è terreno, noi decretiamo che si debba venerare e onorare la nostra santissima Chiesa Romana e che il Sacro Vescovado del santo Pietro debba essere gloriosamente esaltato sopra il nostro Impero e trono terreno. Il vescovo di Roma deve regnare sopra le quattro principali sedi, Antiochia, Alessandria, Costantinopoli e Gerusalemme, e sopra tutte le chiese di Dio nel mondo... Infine, noi diamo a Silvestro, Papa universale, il nostro palazzo e tutte le province, palazzi e distretti della città di Roma e dell'Italia e delle regioni occidentali.»
Inoltre, la Chiesa di Roma ottenne, secondo il documento gli onori, le insegne e il diadema imperiale per i pontefici, ma soprattutto la giurisdizione civile sulla città di Roma, sull'Italia e sull’Impero Romano d'Occidente.
La donazione venne utilizzata dalla Chiesa nel medioevo per avvalorare i propri diritti sui vasti possedimenti territoriali in Occidente e per legittimare il suo potere temporale sulla base di una legge imperiale. Dopo l'età carolingia, la donazione fu riesumata da papa Leone IX nel 1053, e fu dunque introdotta, nel XII secolo, nel Decretum Gratiani e in altre raccolte di Decretali dalle mani di interpolatori. Essa fu considerata un documento veritiero anche dagli avversari del potere dei pontefici. Fece eccezione Ottone III, imperatore dal 996, nipote dell'Ottone ritenuto da molti fondatore del Sacro Romano Impero. Egli, infatti, spinto dalla volontà di rinnovare l'Impero, si era affrancato dal clero cercando di ottenere una posizione di potere sulla Chiesa. Per conseguire il suo fine contestò, nel 1001, la validità del documento, accusando il diacono Giovanni dalle mani mozze di esserne l'artefice. Nel medesimo testo, Ottone sancì la donazione di otto contee di sua proprietà in favore del Papato.
Alcuni secoli dopo, Dante Alighieri, nel De Monarchia, pur non ritenendo falsa la donazione, ne negava il valore giuridico, in quanto con essa l'imperatore aveva recato danno all’Impero Romano, compiendo in tal modo un atto contrario ai propri doveri istituzionali. Infatti, il poeta affermava che né Costantino aveva il diritto di donare a terzi dei territori appartenenti all'Impero, né un papa poteva comprenderli tra i propri possedimenti, in quanto avrebbe contravvenuto ai precetti evangelici riguardo all'obbligo di povertà per la Chiesa: al massimo, avrebbe potuto accettare il dono come usufruttuario. In sostanza, Dante giudicava la donazione come un atto non valido, criticando la Chiesa per averlo considerato la prova giuridica del proprio potere temporale.
Un aumento dello scetticismo in generale e più direttamente verso la presunta pietà e potere della Chiesa cattolica fu uno dei tratti distintivi del pensiero umanistico e rinascimentale. Come fondamento di molti dei diritti e dei privilegi inerenti alla Chiesa, la Donazione di Costantino venne considerata da molti con un occhio molto più critico ed è in questa atmosfera di interrogativi che Lorenzo Valla, sacerdote, umanista e retore, volle esaminare il documento contraffatto, scrivendo nel 1440 il De falso credita et ementita Constantini donatione. Va notato che il patrono politico di Valla all'epoca era Alfonso d'Aragona, coinvolto in un conflitto territoriale con lo Stato Pontificio, e si deve presumere che Valla fosse stimolato dalla sua fedeltà ad Alfonso. Finché la Donazione di Costantino continuava ad essere accettata come valida, le rivendicazioni contrastanti di monarchi come Alfonso potevano essere caratterizzate non solo come imperfette, ma in realtà anticristiane. Valla era deciso a cambiare le cose.
All'inizio del suo discorso, Valla riconosce che è probabile che incontrerà un'opposizione violenta a causa della sua opera, ma afferma coraggiosamente che "... dare la propria vita in difesa della verità e della giustizia è la via della più alta virtù, del più alto onore, della più alta ricompensa." Fornisce anche un imperativo etico al suo attacco alla Chiesa dicendo: “Né è da stimare un vero oratore che sa parlare bene, se non ha anche il coraggio di parlare. Allora abbiamo il coraggio di accusare colui, chiunque sia, che commette crimini che richiedono accusa.”
Valla poi richiama una nota vicenda degli Atti degli Apostoli, in cui Paolo rimprovera Pietro per aver evitato i gentili. C'è una grande abilità nell'uso di questa storia particolare, poiché i Papi, il cui potere Valla sta per minare, considerano la loro autorità ecclesiastica tramandata in una catena ininterrotta dallo stesso Pietro. All'occupante della Sede di Pietro dice: «Nessuno è reso immune dal rimprovero di un'autorità che non rese immune nemmeno Pietro».
A questo punto, Valla sfida direttamente i Papi per la loro complicità nel perpetrare un falso “... o per supina ignoranza, o per grossolana avarizia che è schiava degli idoli, o per orgoglio di potere di cui la crudeltà è sempre la compagna". Dopo averli accusati di stupidità o di avidità, continua a condannarli per "... disonorare la maestà del pontificato, disonorare la memoria degli antichi pontefici, disonorare la religione cristiana, confondere tutto con omicidi, disastri e crimini". In questo modo mantiene la sua fedeltà alla Chiesa come istituzione, spostando il suo attacco su individui all'interno della Chiesa che hanno usato il falso per promuovere se stessi e il potere del papato. Nell'Italia rinascimentale c'erano molti che sostenevano la riforma della chiesa rifiutandosi contemporaneamente di considerare un'alternativa all'autorità ecclesiastica, come avveniva nel nord Europa e come sarebbe drammaticamente emerso con la Riforma luterana.
Valla rivolge poi la sua attenzione al documento stesso, a cominciare dai suoi fondamenti storici, a cominciare dalla legalità di tale dono:Eppure, molti persistevano in questa stessa idea, perché vedevano la storia mitica della conversione di Costantino come esplicativa di tutti il comportamento successivo.
Nessun sovrano avrebbe mai rinunciato a Roma e in generale a tutto l'Occidente. A quanti la giustificavano perché l'imperatore era divenuto cristiano, Valla risponde negando che il regnare fosse incompatibile con la religione cristiana, mentre per chi la sostiene spiegandola come segno di riconoscenza per la guarigione dalla lebbra la risposta è più netta: questa è una favola derivata dalla storia biblica di Naaman, risanato da Eliseo, proprio come quella della leggenda del drago fatto morire dal profeta Daniele.
La donazione, quindi, non ha alcuna plausibilità. Chi la sostiene offende Costantino, il Senato e il Popolo romano, Papa Silvestro I e il pontificato. La donazione è insostenibile anche dal punto di vista storico: per diversi secoli, nessun Papa ha mai preteso obbedienza dai sovrani, perché Roma e l'Italia erano sotto il dominio imperiale, come risulta da un'ampia documentazione storica.
Agli argomenti di ordine giuridico, psicologico e storico, Valla fa seguire una parte dedicata all'esame del documento, che conosce nella forma parziale trasmessa dal Decretum Gratiani. Intanto – osserva il filologo – il testo della donazione è assente nelle copie più antiche del Decretum: non è quindi stato inserito da Graziano, che l'avrebbe coerentemente ricordato insieme al Pactum Ludovicianum. Il Valla dimostra che la lingua della Donazione è un latino che risente degli influssi barbarici e che i riferimenti dell'opera rimandano ad un momento nel quale Costantinopoli è la nuova capitale dell'Impero Romano: la lingua non è quella di un documento dell'età costantiniana, è latino medievale.
Valla è convinto che se il ritrovato cristianesimo di Costantino fosse stato davvero la sua motivazione, più probabilmente avrebbe visto un'opportunità per portare il cristianesimo ai suoi sudditi piuttosto che semplicemente cedere le loro terre. Continua dicendo: “Sei diventato cristiano, Costantino? Allora è molto sconveniente per te ora come imperatore cristiano avere meno sovranità di quella che avevi come infedele. Perché la sovranità è un dono speciale di Dio, per il quale anche i sovrani gentili dovrebbero essere scelti da Dio”. Qui Valla ribalta le argomentazioni sulla conversione di Costantino, dicendo in effetti che diventare giusto avrebbe reso Costantino un sovrano più legittimo, non meno. Valla usa quindi esempi tratti sia dalla Bibbia che dall'antichità per dimostrare che solo perché Dio ha concesso grandi doni a un sovrano, mai prima d'ora un sovrano ha dato in cambio metà del suo impero. I riferimenti di Valla a queste fonti avevano un importante valore retorico, poiché sarebbero stati familiari al suo pubblico, essendo pilastri della letteratura rinascimentale e considerati prove conclusive del comportamento appropriato dei monarchi.
Valla continua il suo Discorso in termini più concreti, sottolineando che non esiste alcuna documentazione esistente sull'accettazione da parte di Silvestro del dono di Costantino. “Dove è la presa di possesso, la consegna? Perché se Costantino ha dato solo una carta, non voleva fare amicizia con Silvestro, ma prenderlo in giro”. Quello che Valla sta dicendo è che se un dono viene dato senza che il titolo legale passi di mano, non c'è affatto dono, ma potrebbe anche essere una presa in giro. Se una persona dovesse inviare una lettera offrendo di fare un regalo, e poi non seguire quella offerta con qualcosa che verifica un cambio di titolo, il regalo è poco più che una vuota promessa. La persona che riceve il regalo dovrebbe anche fornire documenti che certificano la sua accettazione e la successiva amministrazione del regalo. Nessuna di questa documentazione successiva esiste nel caso della Donazione di Costantino, ed è quindi una forte prova circostanziale che né Costantino né Silvestro erano a conoscenza di un tale dono. Valla si fa beffe dell'assenza di questi documenti giustificativi, dicendo: "Dopo la partenza di Costantino, quali governatori fece Silvestro sulle sue province e città, quali guerre fece, quali nazioni che imbracciavano le armi sottomise, attraverso chi continuò questo governo? Non conosciamo nessuna di queste circostanze, rispondete. Penso che tutto questo sia stato fatto di notte e nessuno l'ha visto!”
Valla segnala anche gli anacronismi presenti nel testo che ne screditano la presunta età, come l'uso della parola “satrapo” per riferirsi a funzionari romani, quando in realtà quel termine non era stato usato in tal modo fino all'VIII secolo (è una parola di origine persiana passata poi al greco bizantino) . “Chi ha sentito parlare di satrapi nei concili dei romani? Non ricordo di aver mai letto di menzionare alcun satrapo romano, e neppure di un satrapo in nessuna delle province romane”. Valla sottolinea anche l'uso nel documento dell'espressione “popolo suddito” riferendosi ai cittadini di Roma, cosa che sarebbe stata inconcepibile per un popolo che, in quanto libero cittadino di Roma, governava gli altri. “Possono quelli che governano altri popoli, essi stessi, essere chiamati popolo suddito? È assurdo! Perché in questo, come testimonia Gregorio in molte lettere, il sovrano romano differisce dagli altri, che solo lui è sovrano di un popolo libero”. Gli anacronismi sono prove chiave per smascherare i falsi e Valla fa un ottimo lavoro nel trovarli nel suo Discorso.
Sarebbe anche una prova di un trasferimento nell'amministrazione che ci fosse qualche cambiamento nella moneta coniata dell'impero che Costantino avrebbe presumibilmente ceduto al papa, ma non è così. Lo stesso Valla possedeva monete di quell'epoca che dimostravano il punto. “... ci sono monete d'oro di Costantino dopo che divenne cristiano, con iscrizioni, non in greco, ma in lettere latine, e di quasi tutti gli imperatori in successione. Ce ne sono molti in mio possesso con questa iscrizione per la maggior parte, sotto l'immagine della croce, "Concordia orbis [La pace del mondo]". Che numero infinito di monete dei sommi pontefici si troverebbero se tu mai avessi governato Roma! Ma nessuno di questi si trova, né oro né argento, né si dice che sia stato visto da nessuno. Eppure, chi in quel tempo deteneva il governo a Roma doveva avere una propria moneta: senza dubbio quella del Papa avrebbe portato l'immagine del Salvatore o di Pietro». Questa prova di una continuazione nell'amministrazione dei governanti secolari dell'impero è difficile da confutare, e Valla è saggio usarla più avanti nel testo come supporto alle sue argomentazioni più circostanziali.
Valla segnala poi una delle più evidenti inesattezze storiche quando rileva che la Donazione si riferisce, erroneamente, alla città di Costantinopoli, che al momento in cui si supponeva fosse stato redatto il documento non esisteva. “Come al mondo - questo è molto più assurdo e impossibile nella natura delle cose - si potrebbe parlare di Costantinopoli come di una delle sedi patriarcali, quando non era ancora un patriarcato, né una sede, né una città cristiana, né chiamata Costantinopoli, né fondata, né pianificata! Perché il "privilegio" fu concesso, così si dice, il terzo giorno dopo che Costantino divenne cristiano; quando ancora Bisanzio, non Costantinopoli, occupava quel sito”. Il nome errato di Costantinopoli al posto di Bisanzio è un errore sciatto del falsario e, sottolineandolo, Valla rivela ulteriormente il falso per ciò che è.
Un'ulteriore ignoranza dell'antica terminologia romana viene rivelata quando Valla sottolinea che la Donazione dice "... sono "fatti patrizi e consoli", riferendosi ai chierici della chiesa. I patrizi erano una classe sociale nell'antica Roma, e dalla classe patrizia vi erano solo due consoli, mentre più tardi nel Medioevo il termine "consoli" venne ad essere identificato più in generale con una certa classe di persone, che probabilmente portarono alla confusione del falsario. Valla dice: “Chi ha mai sentito di senatori o altri uomini che sono stati fatti patrizi? I consoli sono "fatti", ma non patrizi. I senatori, i padri coscritti, provengono da famiglie patrizie (chiamate anche senatoriali), equestri o plebee a seconda dei casi…” L’erudito si burla anche di ciò che sarebbe seguito se il clero, infatti, fosse elevato allo status di console romano. “Ma come può il clero diventare console? Il clero latino si è negato il matrimonio; e diventeranno consoli, faranno arruolamento di truppe e si recheranno nelle province loro assegnate con legioni e ausiliari? Servi e schiavi sono fatti consoli? E non devono essercene due, come era consuetudine; ma le centinaia e migliaia di servitori che servono la chiesa romana, devono essere onorate con il grado di generali?” La presa in giro dell'ignoranza del falsario a sua volta fa apparire ridicolo il falso, il che è un eccellente espediente retorico.
Indicando un altro errore, Valla porta i suoi lettori al riferimento del falsario al fatto che il diadema del re era fatto di "oro purissimo e di gemme preziose", quando, infatti, "...un diadema era fatto di stoffa ruvida o forse di seta”. Al tempo di Costantino un “diadema” sarebbe stato costituito da un pezzo di nastro di seta bianca, da legare intorno alla fronte del re indicando il suo status. Più tardi, nel Medioevo, un diadema divenne più associato a una corona, che sarebbe stata probabilmente ornata di gioielli come suppone il falsario. Questo è un altro caso di anacronismo, che si aggiunge alla cronologia sospetta del documento. Valla, con una preponderanza di prove sia concrete che circostanziali, ha costruito un caso impressionante per la confutazione della Donazione di Costantino come genuina. Il suo assalto sistematico alla Donazione attraverso un attento esame è meravigliosamente umanista.
Lorenzo Valla non fu il primo a sostenere che La donazione di Costantino era una frode, e altri più o meno nello stesso periodo, in particolare il cardinale Nicola Cusano e Reginald Pecocke, vescovo di Chichester, dicevano essenzialmente la stessa cosa. Ciò che rese la critica di Valla al documento un evento singolare è stata la natura pubblica della sua critica. Il suo saggio entrò in circolazione nel 1440 e fu ampiamente letto, anche se non pubblicato ufficialmente fino al 1517. Questo fu, non a caso, l'anno delle 95 tesi di Martin Lutero. Non dovrebbe sorprendere che la brillante decostruzione da parte di Valla di uno dei pilastri legali dell'autorità della Chiesa sia diventata estremamente popolare con l'incipiente Riforma protestante.
Valla sviluppò con cura la sua presentazione delle prove contro la Donazione, usando la sua vasta conoscenza del latino classico e le sue capacità retoriche per costruire un caso che è vicino all'inconfutabile, anche all'interno della Chiesa. Nel 1453 lo stesso papa Pio II, in un trattato rimasto inedito, ammise che il documento era un falso. I riferimenti alla Donazione sono notevolmente assenti dai documenti ecclesiastici successivi, sebbene il Vaticano non abbia ufficialmente ammesso l'ovvio fino alla metà del XVI secolo. E abbia continuato a possedere un regno almeno fino alla Breccia di Porta Pia del 20 settembre 1870.
Sebbene l'attacco diretto di Valla a un documento fondamentale della Chiesa possa averlo reso straordinario per il suo tempo, molti dei temi che abbraccia sono, in effetti, tipici della letteratura rinascimentale. La bordata di Valla alla Chiesa cattolica trova eco negli scritti di molti che hanno messo in dubbio la pietà dei chierici nel mezzo di un'epoca di interrogativi. Spesso le storie di questo periodo hanno come personaggi principali sacerdoti o monaci preoccupati per il guadagno terreno, o monache che sono cadute nel peccato mentre vivevano in un convento. L'esposizione di Valla della natura fraudolenta della Donazione avrebbe portato un pubblico già scettico nei confronti della Chiesa a interrogarsi su altre affermazioni dottrinali avanzate da Roma.
Valla è, a questo proposito il tipico umanista rinascimentale, in quanto sottolinea che l'impero retto dai Pontefici sulla terra è stato da sempre un impero di creazione terrena, non di ispirazione divina. Gli umanisti vedevano l'umanità come autonoma, che non richiedeva l'intervento divino per elaborare il suo destino, come espresso da Giovanni Pico nella Orazione sulla dignità dell'uomo. Collocando i Papi nella stessa categoria degli altri monarchi affamati di terra, il potere ecclesiastico viene privato della sua aura religiosa e rivelato solo come un'altra impresa mortale.




.jpg)

,_RP-P-1909-4360.jpg)