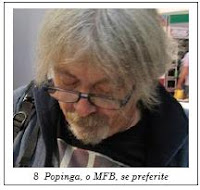Visualizzazione post con etichetta maltusiani. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta maltusiani. Mostra tutti i post
venerdì 4 gennaio 2013
Mariomonti purgativo 2013
GENNAIO
Mariomonti è quella cosa
che ti tassa pure il fiato
e se tu non hai pagato
in apnea devi star.
FEBBRAIO
Mariomonti è quella cosa
che rinnova la Nazione:
con Casini e Buttiglione
sorge il sol dell’avvenir.
MARZO
Mariomonti è quella cosa
che ci fa quadrare i conti,
però senza Mariomonti
il passivo era minor.
APRILE
Mariomonti è quella cosa
che l’Europa lo sostiene:
alle banche gli conviene
e tu il mutuo non l’hai più.
MAGGIO
Mariomonti è quella cosa
che si scontra con Fassina:
desinenza un po’ assassina,
maledette quote ros.
GIUGNO
Mariomonti è quella cosa
che ti manda in pensione
quando hai il pannolone:
con i voti del PD.
LUGLIO
Mariomonti è quella cosa
che ti pubblica un’Agenda:
non è chiara la faccenda
se gliel’ha scritta Ichin.
AGOSTO
Mariomonti è quella cosa
che soddisfa il Vaticano,
pronto a prenderti la mano
se non lo fai pagar.
SETTEMBRE
Mariomonti è quella cosa
senza Ruby e la d’Addario:
lui sa bene, Montimario,
che regnare è meglio che.
OTTOBRE
Mariomonti è quella cosa
che compra gli F-35,
non gli piace chi delinque
contro i nostri militar.
NOVEMBRE
Mariomonti è quella cosa
sempre piena di sussiego:
ha un appeal, non lo nego,
come un calcio nelle pall.
DICEMBRE
Mariomonti è quella cosa
che fa visita a Marchionne:
non gli lancian le madonne
sol venduti e leccacul.
lunedì 22 ottobre 2012
Lima la Rima mi stima
Mi è stato comunicato che ho vinto un concorso di limerick. Si tratta della quarta edizione di Lima la Rima!, organizzato dall’Associazione Fantariciclando, in collaborazione con la cooperativa sociale Gulliver, il patrocinio del Comune di Forlì - Assessorato alla Cultura, Politiche Europee e Rapporti Internazionali, e del Comune di San Mauro Pascoli.
Ho partecipato con due poesie tratte da Giovanni Keplero aveva un gatto nero, la raccolta di rime umoristiche matematiche e fisiche pubblicata da Scienza Express nel 2011. La poesia vincente è risultata questa:
Fine del retto
Un angolo retto si credeva perfetto
e in un triangolo si sentiva costretto.
S’allontanò con una scusa
dalla povera ipotenusa.
In un intestino, poveretto, ora fa il retto.
venerdì 27 aprile 2012
Giocando con i narcisi
I wandered lonely as a cloud
I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.
Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.
The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed -and gazed -but little thought
What wealth the show to me had brought:
For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.
(William Wordsworth, 1802)
Adattamento con rima
Solo vagavo come nuvola sospesa
che alta fluttua su colline e valli,
quando di colpo vidi una distesa,
un esercito, di narcisi gialli;
accanto al lago, sotto le fronde,
danzanti alla brezza in lente onde.
Fitti come splendenti stelline
nella Via Lattea tremolanti,
distesi in una linea senza fine
intorno alla baia, lungo i versanti;
diecimila ne vidi con un’occhiata
che ninnavano i capi in danza beata.
Accanto ad essi un ballo d’onde lucenti,
ma essi le superavano in allegria:
un poeta davvero gode i momenti
in tale gioconda compagnia;
Fissavo e fissavo ma poco ho pensato
a qual bene la scena mi ha dato;
ché spesso, quando giaccio per ore
in assente o pensosa attitudine,
essi balenano in quell’occhio interiore
che è la grazia della solitudine;
allora di piacere il mio cuore si sazia
e con i narcisi danza e ringrazia.
Haiku
Solo vagavo,
poi vidi i narcisi,
gioia del cuore.
Maltusiano
Daffodillo è quella cosa
che abbonda in Inghilterra:
pei poeti in quella terra
è assai meglio del narcis.
Cronaca
CLAMOROSA VISIONE DI UN POETA
Diecimila narcisi danzanti visti in un colpo solo durante una passeggiata presso la baia di Glencoyne. La sorella minimizza: “Solo qualche decina”. La polizia interroga l’uomo, sospettato di far uso di sostanze allucinogene.
Limerick scientifico
Vagavo nei campi come nuvola solitaria,
esposta al vento e al capriccio dell’aria,
quando vidi i narcisi
che geni ben precisi
rendono gialli per legge ereditaria.
Abstract
DAFFODILS: A JOY TO THE INWARD EYE
William Wordsworth1
To be published in The Lyrical Ballads Journal, 4, 15, 1802
1 Lake District University, Cumberland, GB
Wandering in the fields, a poet saw 104 daffodils (Narcissus, clade Amaryllidoideae). This article reports on the vision of their dance in the breeze which brought and still brings joy to his inward eye.
sabato 3 dicembre 2011
Siamo andati con il don
(special guest: Simone Cristicchi)
al Museo di Leonardo:
siamo usciti un po' in ritardo
perché abbiamo perso il don.
Siamo andati con il don
alla gita di Loreto:
Mariolino ha fatto un peto
proprio dentro il santuar.
Siamo andati con il don
alla Messa di Natale:
all’uscita, sul piazzale,
il furgon non c’era più.
Siamo andati con il don
al convegno di C.L.:
ne abbiam viste delle belle,
quasi meglio di YouPorn.
Siamo andati con il don
a veder Passaparola:
nell’aprir la Coca-Cola
ho macchiato Jerry Scott.
Siamo andati con il don
in un circol culturale
c’era gente un po’ speciale
dentro quella Casa Pound.
Siamo andati con il don
quattro giorni a Riccione,
ma il padron della pensione
ci ha scacciati tutti quant.
Siamo andati su dal don
a portargli coppa e crudo:
ci ha aperto un uomo nudo
che non era certo il don.
Aggiornamento del 14 marzo 2012:
Abbiam fatto con il don
una riffa per il Burundi:
"sicut transit gloria mundi",
si è intascato tutto quant.
Siamo andati senza il don
a vedere le battone,
una bella occasione
per notare proprio il don.
Siamo andati con il don
a giocare al calcetto:
nella doccia, con affetto,
lui mi ha fatto una carezz.
giovedì 1 dicembre 2011
Maltusiani dementi
Gavettone a Ferragosto
è uno scherzo da ignoranti.
Se lo fanno a Ognissanti
è davvero criminal.
Siamo andati con la bici
a seguir la processione
e veder la confusione
che facevan le miccett.
Siamo andati con la bici
tutti quanti in oratorio
ma c’ha detto don Gregorio
di gettare gli spinell.
Siamo andati con la bici
a vedere le puttane
poi sono sorte delle grane
con i loro protettor.
Fornicare a tutta manetta
ci vuol proprio la forza di un bue,
ma bisogna essere in due
(e poi il bue è anche castrat).
Quando parte la corriera
ogni giorno è gran fermento:
io di questo son contento
perché poi non salgo su.
Era già tardi, quasi le nove,
e siamo andati per cancelli:
suonare tutti i campanelli
è la gioia dei miei trent’ann.
Se si va presto al voto
scelgo Silvio Berlusconi:
ha comprato dei campioni
per la squadra del mio cuor.
sabato 1 ottobre 2011
La musa vagabonda di Luciano Folgore
Il poeta Omero Vecchi (1888-1966) aveva mostrato un precoce talento e alcune sue composizioni, in stile e metrica tradizionali, erano state pubblicate da importanti riviste letterarie quando aveva solo quindici anni. Nel 1908, non ancora ventenne, fu attratto dalla sirena marinettiana del Futurismo, partecipando attivamente alle battaglie e ai proclami roboanti del movimento. Soprattutto decise di cambiare nom de plume, e, su consiglio di Marinetti, scelse per sé, da allora e per sempre, il due volte brillante pseudonimo di Luciano Folgore.
Negli anni convulsi e drammatici della Grande Guerra pubblicò raccolte di poesie, scritte nello stile sperimentale e iconoclasta del verbo futurista, ma si fece notare anche per lo spirito birbone con il quale collaborò alle riviste La Voce e Lacerba, dove lanciò tra gli altri futuristi i demenziali versi maltusiani, suoi e di Petrolini, che celebrarono la loro apoteosi nel gustoso Almanacco Purgativo del 1914:
Padreterno è quella cosa
che ti veglia giorno e notte
ma che poi se ne strafotte
delle tue calamità.
Moralista è quella cosa
che del fico vuol la foglia,
ma se poi gli vien la voglia
vuole il frutto e al femminil.
La saliera è quella cosa
che ha la forma di un occhiale;
da una parte ci sta il sale
e dall’altra ci sta il pep.
L’obelisco è quella cosa
che si drizza sulle piazze,
ne van matte le ragazze
perché duro e volto in su.
Sulle trincee fu un massacro, e lo Zang-tumb-tumb stava, lentamente ma inesorabilmente, diventando maniera, da inno giovanile e iconoclasta che era stato. E già Marinetti si stava adattando al ruolo di vice D’Annunzio sull’Altare della Patria culturale. Folgore decise nel 1919 che il Futurismo non faceva più per lui, forse perché si stava istituzionalizzando, forse perché lui era cambiato e incominciava a prevalere in lui quella vena di nichilistico disincanto che lo avrebbe sopraffatto se non avesse reagito con l’arma dell’umorismo. Pubblicò nello stesso anno le poesie futuriste che aveva scritto durante la guerra, ultimo omaggio alla sua stessa giovinezza, tra le quali leggiamo capolavori come Tutta nuda:
Te,
nuda dinanzi la lampada rosa,
e gli avori, gli argenti, le madreperle,
pieni di riflessi della tua carne
dolcemente luminosa.
Un brivido nello spogliatoio di seta,
un mormorio sulla finestra socchiusa,
un filo d'odore,
venuto dalla notte delle acacie aperte,
e una grande farfalla che ignora
che intorno a te
non si bruciano le ali,
ma l'anima.
Folgore lasciò i vecchi amici senza rancori, ma prese una strada diversa. La sua vena umoristica, lieve e giocosa, a volte dissacrante, fece capolino nel volume di racconti Crepapelle (1919), vero spartiacque tra la fase più propriamente futurista e quella umoristica. Si diede poi alle parodie, pubblicando nel 1922 e nel 1926 due raccolte di poesie (Poeti controluce e Poeti allo specchio) scritte “nello stile di” che gli valsero un posticino nel poco affollato Empireo degli umoristi italiani. All’appello della folgoriana attenzione c’erano tutti coloro che riscuotevano all'epoca un certo successo negli ambienti letterari, molti dei quali non dicono più nulla al lettore moderno. Tra i più noti ancor oggi Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Gabriele d'Annunzio, Trilussa, Filippo Tommaso Marinetti, Giovanni Papini, Guido Gozzano, Sibilla Aleramo, Annie Vivanti, Ada Negri, Giuseppe Ungaretti, Aldo Palazzeschi e lo stesso Folgore, che non risparmiava nessuno, a qualunque corrente poetica appartenesse, neppure se stesso.
Il procedimento di Folgore era piuttosto costante: preso il componimento più noto del poeta da parodiare, ne imitava il metro e il contenuto, calandolo a livello del quotidiano e ingigantendo le tematiche del poeta stesso, che erano trasformate in ossessioni, in manie. Così nacque ad esempio L’Alba, in cui prendeva di mira i versi leggeri e dubbiosi di Giovanni Pascoli, trasformati in esitazioni quasi ebeti:
Gli orti di Barga stavano, pervasi
da un lieve freddo, lieve, così lieve
che a dirlo non faceva freddo, quasi.
Brina? Sì, no. V'era un biancor di neve,
un presso a poco, un nulla, una chimera
e qualche schiocco nella strada breve.
A un tratto parve che dal ciel piovesse
un po' di guazza, ma non piovve affatto,
com'uno che dicesse e non dicesse.
La parodia più riuscita è forse La pioggia sul cappello, gioco sulla Pioggia nel pineto dannunziana, in cui Folgore portava all’eccesso le preziosità lessicali e il baule mitologico del poeta pescarese, applicati a una situazione banale come la pioggia che coglie D’Annunzio e la sua donna mentre sono a passeggio per la città:
Silenzio. Il cielo
è diventato una nube,
vedo oscurarsi le tube
non vedo 1'ombrello,
ma odo sul mio cappello
di paglia,
da venti dracme e cinquanta
la gocciola che si schianta,
come una bolla,
tra il nastro e la colla.
Per Giove, piove
sicuramente,
piove sulle matrone
vestite di niente,
piove sui bambini
recalcitranti,
piove sui mezzi guanti
turchini,
piove sulle giunoni,
sulle veneri a passeggio,
piove sovra i catoni,
e, quello ch'è peggio,
piove sul tuo cappello
leggiadro,
che ieri ho pagato,
che oggi si guasta;
piove, governo ladro!
…
E piove soprattutto
sul tuo cappello distrutto
mutato in setaccio,
che ieri ho pagato
che adesso è uno straccio,
o Ermïone
che scordi a casa 1'ombrello
nei giorni di mezza stagione.
Anche il rarefatto Ungaretti de L’importo sepolto raggiunge risultati esilaranti:
Oggi è sabato,
domani
sarà
domenica,
poi lunedì;
sempre così
e non da ieri.
L'ho detto.
Ora
me ne vado
a letto
volentieri,
perché
sono stanco
di questi
grandi pensieri.
Nel 1935 seguì una raccolta di parodie di prosatori: Novellieri allo specchio. Parodie di D'Annunzio e altri. Fu insomma un precursore degli esercizi di stile di Queneau o, come probabilmente avrebbe detto il francese, un suo “plagiario per anticipazione”.
La pagina scritta era un confine troppo stretto per la sua creatività, così Folgore si cimentò, per tutta la sua carriera conclusasi con la morte nel 1966, anche con il teatro serio, il varietà, i programmi radiofonici per gli adulti e per i bambini (con testi in rima poi raccolti in volume), con la televisione.
Significativa fu la collaborazione con importanti riviste popolari, come il Travaso delle idee, periodico di satira politica e di costume, e, tra il 1918 e il 1954, la Tribuna Illustrata, settimanale di cronaca e opinione che allora rivaleggiava con la Domenica del Corriere. Sulla Tribuna pubblicava poesie ed epigrammi umoristici venati da una certa dose di pessimismo sulla vita e sulla pretesa degli uomini di dare ad essa un senso. Questi scritti erano firmati con lo pseudonimo di Esopino, che Folgore aveva utilizzato per la prima volta per firmare con Petrolini la rivista Zero meno zero nel 1915 (e che negli anni ’50 sarebbe stato utilizzato anche da Gianni Rodari per alcune fiabe di animali nello stile di Perrault).
La prima produzione di Folgore/Esopino per la Tribuna Illustrata fu raccolta in un libretto dal titolo Musa Vagabonda. Gioconda e qualche volta profonda, pubblicato da Campitelli a Foligno nel 1927. Da questa pubblicazione traggo Il mio Aldilà, in cui si manifesta a mio parere il segno dell’umorismo di Folgore: vagabondo, giocondo e qualche volta profondo.
Se morissi una notte all' improvviso
no, non vorrei salire in paradiso.
Il paradiso è un sito
troppo fuori di mano,
un infinito pieno d'infinito,
un lontano lontano, assai lontano.
Giunti lassù si perde la nozione
delle cose terrestri e vi si oblia
oltre il dolore e la malinconia
i fatti, le disgrazie, le persone,
che ci han rotto le scatole e avverrebbe
ch' angeli o santi si perdonerebbe
coloro che ci diedero fastidio
fino al delirio o fino al suicidio.
Invece io chiedo in premio dei miei mali
non la beatitudine, ma il modo
di vendicarmi a fondo di quei tali.
Vorrei morto di fresco entrare a un tratto
nel corpo del mio gatto,
del mio gatto siamese,
dal muso nero e gli occhi di turchese,
che passa tutto il giorno
ad acciuffar le mosche
che gli ronzano intorno.
Perché dentro le mosche prigioniere,
ci stan l' anime perse dei noiosi
che turbarono sempre i miei riposi.
Ah che rara fortuna, oh che piacere
dar la caccia alle mosche dopo morto!
Spero che Dio, supremo giustiziere,
se ne ricordi e non mi faccia torto.
domenica 7 agosto 2011
La più bella recensione del Keplero
4.1 Giovanni Keplero aveva un gatto nero
«Giovanni Keplero
Aveva un gatto nero
Che storceva le vibrisse
Se sentiva cerchio e non ellisse»
Immagino conosciate tutti Popinga. Se invece non lo conoscete, è bene rimediare. Cominciate allora col Popinga più universalmente noto, quel Kees Popinga che riveste il ruolo del placido assassino in “L’uomo che guardava passare i treni” di Georges Simenon: non c’è Maigret (non può proprio esserci, a ben vedere), ma Popinga basta e avanza: è uno dei migliori Simenon.
Dopo questa dovuta presa di familiarità coll’eroe eponimo, andate adesso a conoscere il Popinga più noto del web: per farlo, è sufficiente fare un salto sul suo blog, http://keespopinga.blogspot.com/, e da quel sito capirete molte più cose di quante se ne possano raccontare in questa rubrica.
La frase che troneggia sulla sua home-page è infatti: “Scienza e Letteratura: terribilis est locus iste”, e non v’è dubbio che Popinga mantenga la promessa. I suoi post navigano regolarmente sul crinale affascinante e poco esplorato in cui le narrazioni diventano scienza e le scoperte scientifiche sono narrate come racconti. Una miscela che riesce a sorprendere e affascinare, ogni volta, i partigiani di entrambe le culture. Certo è che sarebbe bello avere avuto come insegnante, ai tempi del liceo, il professor M.F. Barozzi: chi sa esplorare i misteri della scienza e narrarli con la maestria del letterato deve per forza essere in grado di rendere affascinante anche più soporifera delle lezioni, nonché essere dotato di un gran bel senso dell’umorismo.
E, guarda caso, qualche giovane studente questa fortuna ce l’ha davvero: Popinga insegna, e un po’ per rendere i suoi insegnamenti meno ripetitivi, un po’ per puro ed egoistico desiderio di rivincita contro l’apparente immobilità ciclica della didattica, si è dedicato a comporre versi che riguardano – e spesso riassumono – principi e leggi della fisica, postulati e teoremi di matematica. Brevi composizioni, rigorosamente allineate alla metrica prescelta (una “dotta premessa” del suo libro spiega e illustra con dovizia di esempi e dettagli cosa siano i limerick, i cleryhew, i misteriosi fib, nonché le disgraziate incarringhiane e i versi maltusiani), ma vergognosamente divertenti.
E, inevitabilmente, sono anche un gioco da giocare. Se il cleryhew che dà il titolo al libro (riportato in testa a quest’articolo) è di facile e immediata lettura – a meno che tra i lettori di RM non vi sia qualcuno che abbia dimenticato che è stato proprio Keplero a scoprire che le orbite dei pianeti sono ellissi e non cerchi – altri componimenti sono decisamente più impegnativi:
Sentite questo “Destino dei bosoni”:
Il fotone migliore della sua generazione
Era stanco del gruppo, voleva distinzione
Dai fermioni canzonato
Si fece scoraggiato
E gli sembrò un principio d’esclusione
Solo un limerick, ma a voler scriverci le note a piè di pagina per una classe di liceo, ci vuole un intero corso introduttivo di meccanica quantistica. Naturalmente, un’intera sezione è dedicata alla matematica: questo si intitola “La tentazione”.
C’era un asintoto dalla fede ispirato
Che fece voto di non esser toccato
Ma davanti a una cotangente
Bella, sinuosa, suadente
Dovette ammettere di sentirsi tentato
Come spesso accade quando la chiave di lettura è multipla ed intelligente, si rischia perfino di esagerare nell’attribuire significati ai testi. Prima ancora di entrare in possesso del libro, il vostro umile recensore si è imbattuto in questo fib (senza sapere cosa fosse un fib) dal misterioso titolo “Agorafobia”, ma dall’esplicativo sottotitolo “Interazione Forte”:
È
Una
Forza
Crudele
Che ci trattiene
In un piccolo locale
All’interno di un complesso edificio
Come dice l’autore, questi fib sulle forze fondamentali (certo, vi sono anche quelli per l’interazione elettromagnetica, debole, gravitazionale e di Higgs) giocano sulla doppia lettura, al pari degli indovinelli e delle crittografie. Colto dall’entusiasmo, chi scrive era anche convinto che l’interazione forte evocata dai versi fosse splendidamente sottolineata dalla forma grafica della poesia: al pari della celebre “The Bomb” di Gregory Corso, che era una lunga poesia i cui versi disegnavano graficamente il fungo atomico, pareva che il componimento di Popinga riproducesse il grafico dell’interazione forte, molto intensa a distanze nucleari ma con un rapidissimo affievolimento al crescere della distanza. In realtà, la forma grafica della poesia è stabilita a priori dal suo essere un fib, ovvero una composizione le cui sillabe si basano sulla serie di Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… il primo e il secondo verso devono essere composti d’una sola sillaba, il terzo da 2, il quarto da 5, e così via. Ne segue che anche un fib dedicato a una gaussiana avrebbe la forma di quello appena citato per l’interazione forte, con gran scorno delle capacità deduttive del vostro recensore.
Ma forse è un buon segno: tutti i giochi intelligenti nascondono altri giochi, anche involontari. Il libro del professor Barozzi, in arte Popinga, è al tempo stesso libro di scienza, di poesia, di umorismo. Far convivere le tre cose è davvero meritorio, riesce solo ai grandi.
Una recensione da tale fonte e in tali termini renderebbe felice chiunque. Grazie, Rudi!
Etichette:
clerihew,
fisica,
haiku,
incarrighiana,
limerick,
ludolinguistica,
maltusiani,
matematica,
Popinga,
recensioni,
Rudi Mathematici,
scienza e letteratura
lunedì 4 aprile 2011
Giovanni Keplero aveva un gatto nero
Oggi Lunedì 4 aprile 2011 esce in libreria un libro che prima non era mai uscito nelle librerie. È un libro di poesie umoristiche scientifiche, cioè un libro scientifico di poesie umoristiche, oppure un libro umoristico di poesie scientifiche, a scelta del lettore. S’intitola Giovanni Keplero aveva un gatto nero. Matematica e fisica in versi ed è edito da Scienza Express di Torino. L’ho scritto io, che mi firmo con il nome anagrafico di Marco Fulvio Barozzi, ma tra parentesi metto anche il soprannome di Popinga con il quale sono conosciuto in rete. Si tratta di un libro scritto per divertirmi mentre lo scrivevo e ho scoperto che le operine che contiene divertivano anche gli altri. In libreria costa solo 9 €, ma è possibile ordinarlo direttamente alla casa editrice, risparmiando il 15%. Per chi non sapesse di che cosa sto parlando, dico che esso contiene limerick di matematica e fisica:
La fusione nucleare
Vinti da un impellente desiderio
due nuclei innamorati di deuterio
fecero una fusione.
Ci fu un’esplosione:
la nascita di Elio provò l’adulterio.
Flatlandia
Disse un semicerchio di Matera:
“Se ruoto sul diametro divento la sfera!”
Chiosò il rombo: “Che coglione,
non esiste una terza dimensione!”
Per il semicerchio fu giornata nera.
Ed anche clerihew:
Antonio Meucci
Antonio Meucci
morì per i suoi crucci:
se la spassava in un motel
e ai Brevetti ci andò Bell.
Poi incarrighiane e maltusiani:
L’insieme Z
È l’insiem dei razionali,
con la virgola o le frazioni:
corrispondon alle divisioni
tra numeratore e denominator.
Diversamente dai naturali,
non si contan sulle dita:
si rischierebbe persin la vita
a far frazioni delle falang.
La balistica
La balistica è la scienza
che studia il moto dei proietti:
se le sue leggi non accetti
rischi di sbagliare mir.
E persino poesie basate sulla serie di Fibonacci (fib):
Agorafobia
(Interazione forte)
È
una
forza
crudele
che ci trattiene
in un piccolo locale
all’interno di un complesso edificio.
E anche degli haiku:
Ormai tra di noi
forze di van der Waals,
stanco amore.
Secondo me potreste anche comprarvelo. Chi volesse, può venire a sentire la presentazione che farò al Salone del Libro di Torino sabato 14 maggio dalle ore 13 alle 14 dialogando con gente importante come Piero Bianucci, mentre Maria Rosa Menzio leggerà alcuni dei versi. Il tutto organizzato da Scienza Express edizioni.
Etichette:
clerihew,
Editoria scientifica,
fisica,
haiku,
incarrighiana,
limerick,
ludolinguistica,
maltusiani,
matematica,
poesia,
scienza e letteratura
domenica 6 febbraio 2011
Rangle: Il logaritmo di un verso
Rangle: Il logaritmo di un verso: "Quando ho aperto questo blog, senza avere alcuna idea di cosa fosse un blog, che l'unica forma di condivisione di contenuti che praticavo er..."
Peppe Liberti mi ha preceduto. Per non fare Cicero pro domo sua, come qualcuno ha scherzosamente detto su Facebook, lascio a un amico il compito di fare pubblicità alla mia prossima uscita editoriale. Grazie, Peppe!
mercoledì 28 gennaio 2009
Incarrighiane e maltusiani ad uso de’ liceali

La geometria
Geometria è quella cosa
che si faceva col compasso,
ma oggi, con gran spasso,
si disegna con Cabrì.
L’esagono
È l’esagon la figura
con sei angol e sei lati:
se questi poi son prolungati
piace molto in Israel.
Apollonio e le coniche
Son le coniche quelle curve
ottenute tagliando un cono:
con vari piani lo seziono
di diversa inclinazion.
Costituiscono la famiglia
cerchio, parabola ed ellissi
e l’iperbole, se agissi
con un piano parallelo all’ass.
L’insieme N0
Numeri naturali son quegli enti
che contiamo sulle dita,
senza di lor la nostra vita
sarebbe assai più complicat.
Solo più tardi è stato aggiunto
quel pallin che è lo zero:
per gli antichi era mistero
una cifra valente nient.
L’insieme Z
È l’insiem dei razionali,
con la virgola o le frazioni:
corrispondon alle divisioni
tra numeratore e denominator.
Diversamente dai naturali,
non si contan sulle dita:
si rischierebbe persin la vita
a far frazioni delle falang.
L’insieme Q
È l’insiem dei relativi
che sono numeri con il segno:
una trovata di vero ingegno;
senza segno è ‘l valore assolut.
Sol con essi si può fare
ogni tipo di sottrazione:
era proprio contraddizione
togliere sette da cinque dit.
Il prodotto tra i monomi
Il prodotto tra i monomi
avvien in algebra sovente,
la persona intelligente
in un minuto lo sa far.
Basta il segno stabilire,
moltiplicare i coefficienti
e sommare gli esponenti
della parte letteral.
Relazione
Relazion tra due insiemi
è l’insiem di coppie ordinate
che soddisfano proprietà date:
qui l’amore non c’entra nient.
Lo scarto quadratico medio
Lo scarto quadratico medio
inver non è un enigma,
lo si indica con sigma,
è la radice della varianz.
Misura la dispersione
nei pressi del valore atteso,
così è pure inteso
come deviazione stand.
I mobili
Sono mobili quelle cose
che si muovono secondo leggi:
si misurano con aggeggi
per scoprir che legge è.
Non si devono scambiare
con gli arredi della stanza:
questi invece non han l’usanza
di spostarsi dal paviment.
Conservazione
Conservazion è quella cosa
per la qual, nel sistema isolato,
una grandezza avrai trasformato
ma il suo totale non cambia valor.
In politica è davver gran pregio,
essere per la conservazione,
tutelar Famiglia e Nazione,
contro le trame dei sovversiv.
La balistica
La balistica è la scienza
che studia il moto dei proietti:
se le sue leggi non accetti
rischi di sbagliare mir.
L’accelerazione
Accelerazion è quella cosa
che ci spinge tutti quanti,
sia se andiamo avanti
come pure in retromarc.
È variazion di velocità
che agisce su una massa
quando una forza ell’incassa:
intera o la component.
Lo zero assoluto
Zero assoluto è stato raro
dentro al qual non ci si trastulla
ché nelle molecole diventa nulla
l’agitazione dovuta al calor.
Poiché cessa il disordinato moto
(e si sa che la temperatura
dell’energia cinetica è una misura),
al di sotto non puossi andar.
Il teorema di Bernoulli
In un liquido ideale
tra le molecole non v’è attrito,
non le comprimi con il dito,
tanto meno con un piston.
Nella corrente stazionaria
dentro ogni particella
il totale ognor si livella
d’energia meccanica e di pression.
sabato 24 gennaio 2009
Ferdinando Ingarrica, maestro suo malgrado

Ti saluto, o gentiluomo
Nel 1834 fu dato alle stampe a Napoli l'Opuscolo che contiene la raccolta di cento anacreontiche su di talune scienze, belle arti, virtù, vizj, e diversi altri soggetti, composto per solo uso de' giovanetti, di Ferdinando Ingarrica, giudice del regno borbonico alla Gran Corte criminale nel Palazzo di Giustizia di Salerno. Forse con la stessa penna usata per firmare la condanna di un giacobino, ispirato da una musa ottusa, don Ferdinando scriveva poemetti didascalici come questo:
"L'astronomia"
Stronomia è scienza amena
Che l'uom porta a misurare
Stelle, Sol e'l glob'Lunare,
E a veder che vi è là sù.
Quivi giunto tu scandagli
Ben le Fiaccole del Mondo:
L'armonia di questo tondo
Riserbata a Dio sol' è.
Queste anacreontiche, poi chiamate incarrighiane storpiando il nome dell’autore, sono composizioni in ottonari di comicità inconsapevole, con ardite acrobazie verbali e spesso con l'ultimo verso apocopato. La prima edizione fece ridere tutta Napoli, e il successo del libro provocò il moltiplicarsi di composizioni apocrife; le edizioni successive del libro, non autorizzate, misero addirittura in difficoltà l’Ingarrica con la corte. Pare che la famiglia dell'autore abbia cercato di togliere dalla circolazione il maggior numero possibile di copie dell'Opuscolo, per sottrarre dal ridicolo il loro congiunto.
I commenti dei contemporanei furono davvero spietati (“bestia”, “spropositate poesie”, “conati strani”), ma l’Ingarrica aveva creato un genere di successo suo malgrado:
"Religione"
Religione tu a noi insegni
Come adorasi il Gran Dio;
Ah potessi ognora io
Colla faccia in terra star!
Chi seconda i tuoi precetti
Rasserena mente e core,
Vive ben; né mai timore
Della Morte debbe aver.
"L'ubriaco"L'Ubriaco è l'uom schifoso
Che avvilisce la natura;
Tutto dì la sepoltura
Per Lui aperta se ne sta.
Il far' uso del liquore
Con dovuta temperanza
L'Estro sveglia, e con possanza
Spinge l'Uomo a poetar.
"L'ecclissi"
Ecclissi è quando s'incontra
Fra il Sol' la Lun' sovente
O fra Lun' la Ter' movente
E scuror ne vien qua giù.
Questo fatto sì innocente
Una volta fe’ timore
Si credea che Dio in livore
Stasse colla Umanità.
L’ultima anacreontica era composta da soli quattro versi:
“Il saluto”
Ti saluto, o Gentiluomo,
Per averti rincontrato;
Il tuo piè sia salvato
Dall'intrigo ingannator.
Le anacreontiche incarrighiane erano così popolari in tutto il Regno e, dopo l’unificazione, in tutta l'Italia meridionale, che accadeva che due amici, nell'incontrarsi per strada, si dicessero a vicenda: “Ti saluto, o gentiluomo”. C’era anche chi le sapeva tutte a memoria. Le pseudo-incarrighiane diventarono di moda tra i letterati napoletani, e anacreontiche di vari autori furono aggiunte alle ristampe non autorizzate dell'Opuscolo. Alcune sono talmente fedeli allo spirito di don Ferdinando da sembrare originali:
"Sulla Trinità"
La Trinità significa
Un Dio in tre persone,
Di una intenzione;
Ma di diverse età.
Il Padre col cappello,
Il figlio colle spine,
Lo spirto coll'augello,
O che bella Trinità!
"L'astronomia"
Stronomia è scienza amena
Che l'uom porta a misurare
Stelle, Sol e'l glob'Lunare,
E a veder che vi è là sù.
Quivi giunto tu scandagli
Ben le Fiaccole del Mondo:
L'armonia di questo tondo
Riserbata a Dio sol' è.
Queste anacreontiche, poi chiamate incarrighiane storpiando il nome dell’autore, sono composizioni in ottonari di comicità inconsapevole, con ardite acrobazie verbali e spesso con l'ultimo verso apocopato. La prima edizione fece ridere tutta Napoli, e il successo del libro provocò il moltiplicarsi di composizioni apocrife; le edizioni successive del libro, non autorizzate, misero addirittura in difficoltà l’Ingarrica con la corte. Pare che la famiglia dell'autore abbia cercato di togliere dalla circolazione il maggior numero possibile di copie dell'Opuscolo, per sottrarre dal ridicolo il loro congiunto.
I commenti dei contemporanei furono davvero spietati (“bestia”, “spropositate poesie”, “conati strani”), ma l’Ingarrica aveva creato un genere di successo suo malgrado:
"Religione"
Religione tu a noi insegni
Come adorasi il Gran Dio;
Ah potessi ognora io
Colla faccia in terra star!
Chi seconda i tuoi precetti
Rasserena mente e core,
Vive ben; né mai timore
Della Morte debbe aver.
"L'ubriaco"L'Ubriaco è l'uom schifoso
Che avvilisce la natura;
Tutto dì la sepoltura
Per Lui aperta se ne sta.
Il far' uso del liquore
Con dovuta temperanza
L'Estro sveglia, e con possanza
Spinge l'Uomo a poetar.
"L'ecclissi"
Ecclissi è quando s'incontra
Fra il Sol' la Lun' sovente
O fra Lun' la Ter' movente
E scuror ne vien qua giù.
Questo fatto sì innocente
Una volta fe’ timore
Si credea che Dio in livore
Stasse colla Umanità.
L’ultima anacreontica era composta da soli quattro versi:
“Il saluto”
Ti saluto, o Gentiluomo,
Per averti rincontrato;
Il tuo piè sia salvato
Dall'intrigo ingannator.
Le anacreontiche incarrighiane erano così popolari in tutto il Regno e, dopo l’unificazione, in tutta l'Italia meridionale, che accadeva che due amici, nell'incontrarsi per strada, si dicessero a vicenda: “Ti saluto, o gentiluomo”. C’era anche chi le sapeva tutte a memoria. Le pseudo-incarrighiane diventarono di moda tra i letterati napoletani, e anacreontiche di vari autori furono aggiunte alle ristampe non autorizzate dell'Opuscolo. Alcune sono talmente fedeli allo spirito di don Ferdinando da sembrare originali:
"Sulla Trinità"
La Trinità significa
Un Dio in tre persone,
Di una intenzione;
Ma di diverse età.
Il Padre col cappello,
Il figlio colle spine,
Lo spirto coll'augello,
O che bella Trinità!
La scuola di don Ferdinando
Una corrente sotterranea lega l’opera dell’Ingarrica, che il rodariano Carmine De Luca ha definito “una sorta di via italiana al nonsense”, a molti prodotti della rima italiana, sia colta che popolare.
Furono sicuramente influenzati dalle anacreontiche incarrighiane i “versi maltusiani” dei futuristi che gravitavano intorno alla rivista Lacerba durante la sua breve vita (1913-1915) e frequentavano il caffè letterario Giubbe Rosse di Firenze. Il nome "maltusiani" faceva riferimento scherzoso alle teorie dell’economista Thomas R. Malthus, sostenitore della necessità della limitazione delle nascite (con la castità): senza rispetto per la verità storica, poiché allora il metodo anticoncezionale più diffuso era il coitus interruptus, le giocose rime maltusiane avevano la peculiarità di terminare con un verso troncato. Il trionfo dei versi maltusiani fu il divertentissimo Almanacco Purgativo del 1914 curato dai lacerbiani. Scrissero versi maltusiani Luciano Folgore (1888-1966), che li diffuse tra gli altri futuristi, Giovanni Papini (1881-1956) e Ardengo Soffici (1879-1964), che dipinse la Composizione con uovo rosso sopra riprodotta.
Padreterno è quella cosa
che ti veglia giorno e notte
ma che poi se ne strafotte
delle tue calamità.
(Luciano Folgore)
Si va al cinematografo
insieme a molta gente,
s’entra, e naturalmente
dopo si deve uscir.
(Anonimo)
La saliera è quella cosa
che ha la forma di un occhiale;
da una parte ci sta il sale
e dall’altra ci sta il pep.
(Anonimo)
Lo stesso procedimento veniva adottato da Ettore Petrolini (1884-1936), che spesso partecipava alle serate organizzate dai futuristi:
È la moglie quella cosa
che per lusso e per vestito
spende il doppio del marito
e si chiama la metà.
E’ l’amore quella cosa
che platonico tu chiami
se la femmina che ami
ti vuol dar soltanto il cuor
Farmacista è quella cosa
se stai bene te ne freghi
viceversa poi lo preghi
se per caso sei malat.
Dopo un oblio di qualche decennio, l’Ingarrica veniva riscoperto e, in parte, rivalutato: Ettore Janni in I poeti minori dell'Ottocento (Rizzoli, Milano, 1958) scriveva “che don Ferdinando non diceva sciocchezze, ma le verità comuni le diceva scioccamente: caricatura, dunque, di non pochi scrittori dello stesso stampo ma che passano per uomini di riguardo.” In quegli anni Paolo De Benedetti, uno dei principali biblisti italiani, direttore editoriale e consulente di molte case editrici, autore di moltissimi limerick, trovava anche il tempo di scrivere versi maltusiani, come questi, del 1957 (ora in Paolo De Benedetti, Nonsense e altro, Milano, Libri Scheiwiller, 2002):
È Milano quel paese
tutto pien di ragionieri
messi a guardia dei forzieri
dove stanno i panettòn.
Riproposti nuovamente dalla rivista elettronica Golem ai tempi della direzione di Stefano Bartezzaghi, negli ultimi anni i versi apocopati di don Ferdinando, di Petrolini e dei maltusiani hanno trovato nuovi seguaci sull’esempio dei suoi redattori:
Internet è quella cosa
che t'appar se ti connetti
e ti piace finché smetti
di rileggere Golèm.
Ma se il server non ti serve
non fai altro che aspettare:
maledici ogni tuo lare
e ai ginocchi scende il lat.
(Stefano Bartezzaghi)
Berlusconi è quella cosa
che ci dà TV ogni sera
poi per non patir galera
organizza Forzital.
(Umberto Eco)
Umberteco è quella cosa
che s'inventa un'abbazia
poi per colpo di pazzia
non ricorda manco il nom.
(Umberto Eco)
L'Ingarrica, accanto a tanti sciagurati librettisti d’opera, è stato il maestro di buona parte della versificazione per canzonette fino ad anni abbastanza recenti. Tullio De Mauro, in un suo saggio sui testi dei cantautori italiani (in Borgna - Dessi, C'era una volta una gatta. I cantautori degli anni '60, Savelli, Roma, 1977), cita ad esempio l’opera di Bixio e Cherubini, che, gli anni Venti del secolo scorso, foggiarono gioielli come la "qual seduzion ognun prova" (Alcova, 1921), oppure "Hanno la chioma bruna, / hanno la febbre in cor. / Chi va a cercar fortuna, / vi troverà l'amor" (nel celeberrimo Tango delle capinere, 1922).
Il fascismo fu una casa accogliente per i versi à la Ingarrica. Le canzonette di regime pullulavano di troncamenti: in Giovinezza “Non v'è povero quartiere / che non mandi le sue schiere, / che non spieghi le bandiere / del fascismo redentor”.
Gli anni Cinquanta furono caratterizzati da quella che, nel 1952, Alberto Cavaliere (l'autore dell’indimenticabile Chimica in versi) denunciò come la "inflazione di cuor e amor". Nilla Pizzi mieteva successi con versi come “Se il vento scuote e fa tremar / le siepi in fiore, / poi torna lieve a carezzar / con tanto amore! / E tu, che spesso fai soffrir / tormenti e pene, / sussurrami baciandomi / che m'ami ancor...” (L’edera, D’Acquisto-Seracini, 1958). I ritmi delle canzoni americane e i testi degli chansonnier francesi rimasero a lungo un fenomeno limitato, e avrebbero dato frutti in Italia solo a partire dagli anni ’60. Ma, accanto ai primi cantautori, ai primi complessini beat, ancora mieteva successi la canzone tradizionale di Luciano Tajoli, Claudio Villa e dei loro epigoni, in cui è possibile riconoscere gli ultimi influssi di don Ferdinando nella cultura popolare.
Una corrente sotterranea lega l’opera dell’Ingarrica, che il rodariano Carmine De Luca ha definito “una sorta di via italiana al nonsense”, a molti prodotti della rima italiana, sia colta che popolare.
Furono sicuramente influenzati dalle anacreontiche incarrighiane i “versi maltusiani” dei futuristi che gravitavano intorno alla rivista Lacerba durante la sua breve vita (1913-1915) e frequentavano il caffè letterario Giubbe Rosse di Firenze. Il nome "maltusiani" faceva riferimento scherzoso alle teorie dell’economista Thomas R. Malthus, sostenitore della necessità della limitazione delle nascite (con la castità): senza rispetto per la verità storica, poiché allora il metodo anticoncezionale più diffuso era il coitus interruptus, le giocose rime maltusiane avevano la peculiarità di terminare con un verso troncato. Il trionfo dei versi maltusiani fu il divertentissimo Almanacco Purgativo del 1914 curato dai lacerbiani. Scrissero versi maltusiani Luciano Folgore (1888-1966), che li diffuse tra gli altri futuristi, Giovanni Papini (1881-1956) e Ardengo Soffici (1879-1964), che dipinse la Composizione con uovo rosso sopra riprodotta.
Padreterno è quella cosa
che ti veglia giorno e notte
ma che poi se ne strafotte
delle tue calamità.
(Luciano Folgore)
Si va al cinematografo
insieme a molta gente,
s’entra, e naturalmente
dopo si deve uscir.
(Anonimo)
La saliera è quella cosa
che ha la forma di un occhiale;
da una parte ci sta il sale
e dall’altra ci sta il pep.
(Anonimo)
Lo stesso procedimento veniva adottato da Ettore Petrolini (1884-1936), che spesso partecipava alle serate organizzate dai futuristi:
È la moglie quella cosa
che per lusso e per vestito
spende il doppio del marito
e si chiama la metà.
E’ l’amore quella cosa
che platonico tu chiami
se la femmina che ami
ti vuol dar soltanto il cuor
Farmacista è quella cosa
se stai bene te ne freghi
viceversa poi lo preghi
se per caso sei malat.
Dopo un oblio di qualche decennio, l’Ingarrica veniva riscoperto e, in parte, rivalutato: Ettore Janni in I poeti minori dell'Ottocento (Rizzoli, Milano, 1958) scriveva “che don Ferdinando non diceva sciocchezze, ma le verità comuni le diceva scioccamente: caricatura, dunque, di non pochi scrittori dello stesso stampo ma che passano per uomini di riguardo.” In quegli anni Paolo De Benedetti, uno dei principali biblisti italiani, direttore editoriale e consulente di molte case editrici, autore di moltissimi limerick, trovava anche il tempo di scrivere versi maltusiani, come questi, del 1957 (ora in Paolo De Benedetti, Nonsense e altro, Milano, Libri Scheiwiller, 2002):
È Milano quel paese
tutto pien di ragionieri
messi a guardia dei forzieri
dove stanno i panettòn.
Riproposti nuovamente dalla rivista elettronica Golem ai tempi della direzione di Stefano Bartezzaghi, negli ultimi anni i versi apocopati di don Ferdinando, di Petrolini e dei maltusiani hanno trovato nuovi seguaci sull’esempio dei suoi redattori:
Internet è quella cosa
che t'appar se ti connetti
e ti piace finché smetti
di rileggere Golèm.
Ma se il server non ti serve
non fai altro che aspettare:
maledici ogni tuo lare
e ai ginocchi scende il lat.
(Stefano Bartezzaghi)
Berlusconi è quella cosa
che ci dà TV ogni sera
poi per non patir galera
organizza Forzital.
(Umberto Eco)
Umberteco è quella cosa
che s'inventa un'abbazia
poi per colpo di pazzia
non ricorda manco il nom.
(Umberto Eco)
L'Ingarrica, accanto a tanti sciagurati librettisti d’opera, è stato il maestro di buona parte della versificazione per canzonette fino ad anni abbastanza recenti. Tullio De Mauro, in un suo saggio sui testi dei cantautori italiani (in Borgna - Dessi, C'era una volta una gatta. I cantautori degli anni '60, Savelli, Roma, 1977), cita ad esempio l’opera di Bixio e Cherubini, che, gli anni Venti del secolo scorso, foggiarono gioielli come la "qual seduzion ognun prova" (Alcova, 1921), oppure "Hanno la chioma bruna, / hanno la febbre in cor. / Chi va a cercar fortuna, / vi troverà l'amor" (nel celeberrimo Tango delle capinere, 1922).
Il fascismo fu una casa accogliente per i versi à la Ingarrica. Le canzonette di regime pullulavano di troncamenti: in Giovinezza “Non v'è povero quartiere / che non mandi le sue schiere, / che non spieghi le bandiere / del fascismo redentor”.
Gli anni Cinquanta furono caratterizzati da quella che, nel 1952, Alberto Cavaliere (l'autore dell’indimenticabile Chimica in versi) denunciò come la "inflazione di cuor e amor". Nilla Pizzi mieteva successi con versi come “Se il vento scuote e fa tremar / le siepi in fiore, / poi torna lieve a carezzar / con tanto amore! / E tu, che spesso fai soffrir / tormenti e pene, / sussurrami baciandomi / che m'ami ancor...” (L’edera, D’Acquisto-Seracini, 1958). I ritmi delle canzoni americane e i testi degli chansonnier francesi rimasero a lungo un fenomeno limitato, e avrebbero dato frutti in Italia solo a partire dagli anni ’60. Ma, accanto ai primi cantautori, ai primi complessini beat, ancora mieteva successi la canzone tradizionale di Luciano Tajoli, Claudio Villa e dei loro epigoni, in cui è possibile riconoscere gli ultimi influssi di don Ferdinando nella cultura popolare.
Iscriviti a:
Post (Atom)

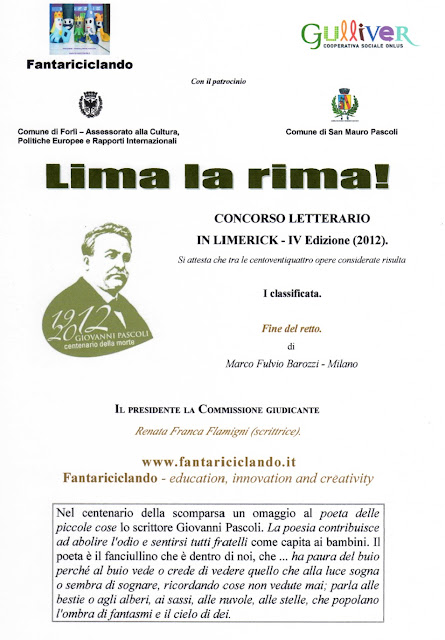

.jpg)